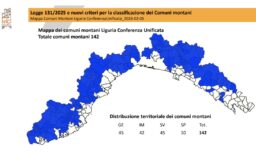Trent’anni dopo aver raccontato la prima guerra in Europa dal 1945, i giornalisti Francesco Battistini e Marzio G. Mian sono tornati ad analizzare quegli anni e hanno cercato di capire, attraverso interviste e testimonianze, l’ex Jugoslavia di oggi dove sta andando.
È questo l’obiettivo di “Maledetta Sarajevo” (Neri Pozza, 2022).
Non sono buone notizie, visto che una nuova stagione di tensione non viene totalmente esclusa. Pochissime le voci di speranza e di ricostruzione.
Il fallimento degli accordi di Dayton è evidente dal racconto che emerge dal libro. Un libro che ripercorre alcuni dei fatti più importanti di quei maledetti, quelli sì, anni Novanta, ma che non è una ricostruzione storica e lineare degli eventi. Suggeriamo, dunque, prima di approcciare questa lettura, di rinfrescarsi la memoria ripercorrendo le tappe indicate nella cronologia a fine libro e magari rileggere qualche riassunto delle guerre jugoslave.
In particolare, i due autori si soffermano sul conflitto in Bosnia e sulla sua eredità oggi. Una battaglia cruenta e disumana nei confronti dei civili (in particolare donne e bambini) insostenibile dal punto di vista emotivo anche solo rileggendo alcune esperienze di chi è sopravvissuto.
Ancora oggi quella fase non è stata superata, è questo il nodo cruciale. Il nazionalismo impera e l’odio etnico viene trasmesso alle nuove generazioni. Si guarda al passato invece che al futuro.
In quella guerra non ci fu nessun vincitore e gli ideologi delle stragi, in Serbia, hanno avuto anche un posto in Parlamento, nel post conflitto: su tutti Biljana Plavšić, l’unica donna processata dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia per aver partecipato ai crimini commessi durante la guerra. Gli autori dei massacri sono stati nascosti per anni, con la complicità di chi occupava posti di primo piano e sono ancora oggi osannati dal popolo serbo.
Il racconto si alterna attraverso interviste a civili e ai protagonisti dell’epoca: testimoni e mediatori internazionali come Carl Bildt, Lord Owen, Carla Del Ponte o il generale francese che comandava i caschi blu dell’Onu e scappò da Srebrenica. Tra gli intervistati anche Radovan Karadžić, presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina dal 1992 al 1996 e condannato all’ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Latitante fino al luglio 2008, dal 1999 si riciclò come esperto New Age di medicina alternativa: lavorò in una clinica privata di Belgrado sotto falso nome di Dragan David Dabic, nascondendo il suo volto dietro lunghi capelli e barba bianchi. Le responsabilità dei serbi sono evidenti, ma in Maledetta Sarajevo emergono anche le colpe dei vertici bosgnacchi e croati.
L’Europa non sapeva nulla della Bosnia e di ciò che sotto Tito era rimasto nascosto. I nazionalisti serbi covavano una vendetta nei confronti dei musulmani da secoli: dalla sconfitta del 15 giugno 1389, la battaglia della Piana dei Merli, in cui le truppe ottomane ebbero la meglio su quelle serbe. La volontà di avere uno Stato da spartirsi a spese dei musulmani da parte di Croazia e Serbia fu la causa scatenante di una conflitto che sfociò nella pulizia etnica.
Prima della guerra la Bosnia-Erzegovina aveva 4,4 milioni di abitanti di cui 31,2% serbi, 14,4% croati e 43,5% appartenente invece all’etnia bosniaca. Nel 2016, primo censimento dopo la guerra, i bosniaci erano il 50,11% (musulmani), 30,8% i serbi (ortodossi) e 15,4% i croati (cattolici). Sarajevo oggi non è più quella città incontro di culture diverse come testimoniava anche una linea turistica “est-ovest” a delimitare l’architettura della città occidentale da quella orientale. I matrimoni misti sono crollati, l’enclave musulmana, da sempre simbolo di moderazione, si è in parte radicalizzata, avendo dovuto sopportare per anni fame, cecchini, attacchi sfibranti.
L’Europa ha compiuto parecchi errori all’epoca e anche oggi, nel non accogliere sotto la bandiera blu a stelle Bosnia e Serbia. Anche gli Usa intervennero in ritardo. Il rischio è di reiterare questi errori negli anni Venti del Duemila. L’Italia politica non fece per nulla una bella figura negli anni Novanta, solo l’allora ministro degli Esteri De Michelis intuì i pericoli del riconoscimento dell’indipendenza della Croazia, che diede il via alle rivendicazioni etnico-nazionaliste, mentre la buona volontà dei volontari e di chi accolse i profughi sembra appartenere ormai a un passato lontano.
Di grande impatto le pagine di testimonianza su come si faceva giornalismo di guerra all’epoca e di come gli scoop sui lager gestiti dai serbi fecero smuovere le coscienze e le forze militari internazionali. Epico il racconto di come la redazione di Oslobodenje riuscì a pubblicare ugualmente il quotidiano a Sarajevo nei quattro anni di assedio, pagando a caro prezzo con diversi giornalisti morti. Fu l’ultima guerra raccontata senza Internet. E ci si domanda: con i social network sarebbe stato diverso? Ci sarebbero voluti tutti questi anni e una scia infinita di morti, feriti e profughi per far cessare l’assedio alla città?