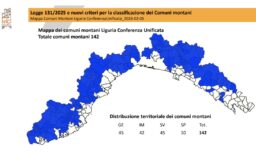L’Italia rischia di perdere una delle più importanti partite economico-commerciali che si stia giocando in Europa, quella dei traffici portuali, a causa della mancata interconnessione infrastrutturale, specie nei retroporto.
Si ricorda nel recentissimo documento (marzo 2016) del Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (Autore: Marketa Pape, Servizio di ricerca per i deputati) sull’ accesso al mercato dei servizi portuali che «In un terzo tentativo di liberalizzare i servizi portuali nell’Unione europea, nel 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a eliminare la competizione sleale e migliorare l’efficienza commerciale dei principali porti marittimi dell’Unione Europea.
La proposta stabilisce un quadro «per l’accesso al mercato dei servizi portuali e disposizioni comuni in materia sia di trasparenza dei finanziamenti pubblici per i porti che di diritti d’uso, senza influire sulle norme sociali e occupazionali degli Stati membri». Il contesto riguarda i circa 1.200 porti marittimi dell’Unione e ribadisce quanto siano “ fondamentali per la sua economia, dal momento che consentono il transito del 74% circa delle merci importate ed esportate e del 37% degli scambi all’interno dell’Unione.
Oltre ad essere essenziali sia per il settore dei trasporti sia per la competitività dell’Ue,
«i porti danno lavoro a oltre 3 milioni di persone e possono potenzialmente creare ulteriore occupazione e attrarre gli investitori. Più del 90% di tutte le merci e i passeggeri che transitano per i porti dell’Ue utilizzano i 329 porti marittimi all’interno della rete transeuropea di trasporto».
Si è fatto quindi il punto su ciò che gli scali rappresentino per l’economia continentale e quanto va fatto per offrire loro garanzie di funzionamento in un ambito di diffuso rispetto delle regole. Si legge – a completamento – su Leadership 2020 che l’industria navale e delle attrezzature marine impiega in Europa più di 500mila persone e vanta un fatturato medio annuo pari a circa 72 miliardi di euro, comprendente: la cantieristica dal punto di vista delle costruzioni e delle riparazioni. I precedenti tentativi della Commissione di modernizzare i servizi portuali (nel 2001 e nel 2004) hanno generato controversie principalmente a causa di aspetti di natura sociale o legati al mercato del lavoro e sono stati respinti dal Parlamento europeo.
Nel 2007 «la Commissione ha individuato sfide considerevoli per il settore (i livelli di prestazione, i collegamenti con l’entroterra, le tecnologie esistenti e il loro impatto sull’ambiente, la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, le restrizioni nell’accesso al mercato e l’organizzazione del lavoro nei porti)” affrontandole tuttavia con strumenti orizzontali e misure morbide, salvo poi decidere nel 2013, che le misure morbide avevano avuto “un impatto scarso o nullo».
Italia, con la Liguria capofila, e Nord Europa si sono mosse diversamente. A cominciare da water front e retroporti. Il porto di Genova (come quelli di La Spezia e Savona) sarebbero in grado di cambiare volto alle città di appartenenza, solo facendo, in sedicesimo, quello che (possono) fare i grandi porti del nord Europa. Ma sull’Atlantico parliamo del successo di un mondo al servizio dei porti (in Germania), così come parliamo (in Italia) di crisi di un mondo che al contrario le banchine le sfrutta per drenarne anche le briciole finanziarie. Se ne parla, con la massima attenzione, in una pubblicazione tecnica del centro studi della Cassa Depositi e Prestiti, uno dei centri di finanziamento delle infrastrutture italiane. «La perdita di competitività della portualità italiana è un danno non solo per il settore ma per l’intero sistema economico nazionale, non solo perché questa (portualità ndr) rappresenta il 2,6% del pil ma anche perché è un elemento di competitività per tutto il sistema industriale».
In Italia La Cassa “vede” ventiquattro porti, ognuno con i propri programmi di investimento, organizzativamente non comunicanti l’uno con l’altro, scali con alle spalle infrastrutture di trasporto frammentate e senza alcuna priorità di realizzazione. Il rischio creato dalla mancata interconnessione infrastrutturale, specie nei retroporto, è di far perdere all’ Italia una delle più importanti partite economico-commerciali che si stia giocando in Europa. Perché una sconfitta nella riorganizzazione della logistica, significa non solo la perdita di posizioni di favore geografico del comparto dei moli, ma “anche un costo per le imprese che ad oggi assomma ad un onere sui loro conti che supera i 12 miliardi di euro. E c’ è di più nel triste ambito della mancanza di colloquio tra scali. Tutte gli scali nazionali, infatti, hanno lanciato proposte di investimento sulle proprie banchine. La Cassa depositi e prestiti, nello studio, ha messo insieme le cifre ed i relativi ritorni per singolo porto tratti dai programmi dei 24 scali nel settore container. Ebbene, se si realizzassero tutti si arriverebbe ad un aumento di capacità, a livello nazionale, di 11 milioni di teu in un paese che oggi ne movimenta poco più di 10. Un raddoppio non giustificato da alcunché, visto lo stato delle vie di uscita dai porti stessi, della logistica per la distribuzione e della burocrazia.
Manca dunque un coordinamento, un piano che si basi su una strategia comune, su tagli alla politica d’ orticello, sulla riduzione delle inefficienze che limitano tutto.
Se Rotterdam, il miglior sistema portuale d’ Europa, movimenta da sola quanto tutti i porti italiani messi insieme una ragione ci sarà.
E la volontà di migliorare continuamente il servizio reso, la si legge nel continuo incremento dei traffici. E questo concetto vale per tutti i porti del nord Europa. Raccontando Rotterdam, Nicola Bozzi scrive su “Studio”:
«probabilmente il baricentro più rappresentativo del rapporto tra città e porto è l’ex bacino di carenaggio ribattezzato Rdm Campus. La sigla una volta stava per Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, adesso sta per Research, Design and Manufacturing”, e continua” il massiccio complesso che ospita l’ufficio risale ai primi del Novecento e, fino alla Seconda Guerra Mondiale, vi venivano costruite navi militari e, dopo, da crociera. Nel 1914, come si faceva in Inghilterra, la compagnia che gestiva l’attracco ci fece costruire intorno case per i propri lavoratori e le loro famiglie, creando una vivace comunità».
.Negli anni 80, però, il molo andò in bancarotta e da quel momento l’occupazione continuò a calare drasticamente. Fino alla riqualificazione. Nell’ultimo decennio l’autorità portuale e il politecnico di Rotterdam hanno investito un sacco di soldi nel rinnovamento degli spazi del molo, i primi intensificando il trasporto via acqua ogni mezz’ora e i secondi istituendovi i propri laboratori pratici. Anche il centralissimo museo Boijmans van Beuningen ha lanciato un programma artistico proprio in un capannone dietro l’angolo, il Submarine Wharf”. Porto, università, arte. Con obiettivo unico la città, non se stessi. Paragonare questo brano di storia vera e possibile alla genovesità di Erzelli, università e tecnologia, fa sorridere molto amaramente.
.