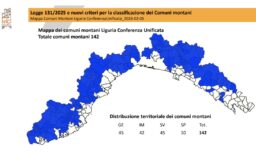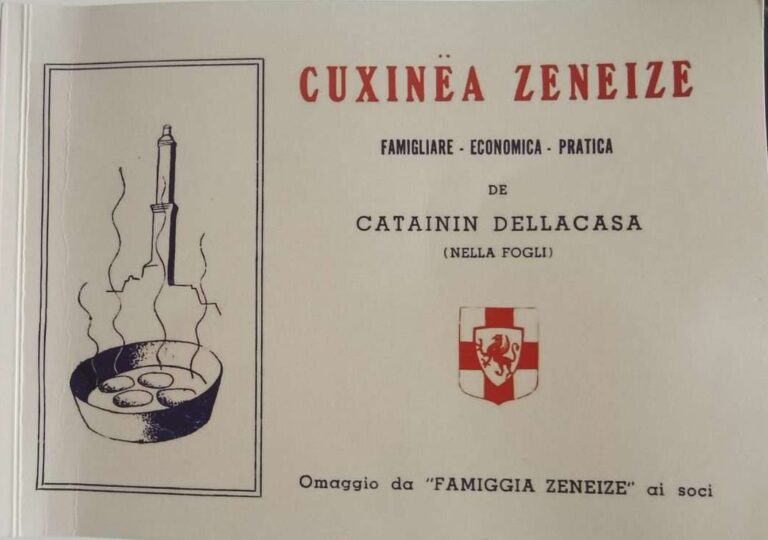Oggi non trattiamo di una ricetta ma di un ricettario: la “Cuxinea zeneize” di Catainin Dellacasa, un libretto scritto in genovese e pubblicato nel 1945 a Buenos Aires dalla tipografia Maggiolo. Lo ha scoperto Luca Sessarego – presidente dell’Associazione Sessarego nel mondo e vicepresidente dell’Associazione Liguri nel mondo – e la copia anastatica è stata realizzata da Deferrari editore con il contributo della Regione Liguria.
La nostra rubrica, dedicata a ricette liguri (o versioni di ricette liguri) oggi meno praticate di un tempo oppure poco conosciute al di fuori della loro area di origine, vorrebbe essere un piccolo contributo alla divulgazione della conoscenza della nostra storia materiale e anche suggerire qualche possibile variante alla nostra dieta. Questo gioiello che dobbiamo a Sessarego e alla sua associazione getta un fascio di luce sul passato della cucina genovese e su come è stata riadattata in base ai prodotti disponibili nell’Argentina di allora. Consigliamo di acquistarlo, per le riflessioni che può stimolarci e anche per la bellezza delle pagine di pubblicità di prodotti e negozi della Buenos Aires di allora, in gran parte gestiti da famiglie liguri.
Si diceva del passato. Il lavoro di Dellacasa, un centinaio di ricette, 75 pagine, è conservativo. Anche se nel 1945 pure a Genova e nel resto d’Italia la rivoluzione dei costumi e dei consumi doveva ancora venire, le ricette di questo volumetto sembrano più strettamente legate a quelle dei libri di cucina genovese dell’Ottocento, in particolare alla “Cuciniera Genovese” dei Ratto padre e figlio (prima edizione 1863, seguita da numerose ristampe) e forse anche alla “Vera cuciniera genovese” di Emanuele Rossi (prima edizione 1865). Un fenomeno usuale nelle comunità rimaste isolate dalla madrepatria, che investe molti aspetti della vita quotidiana: per ricostruire l’evoluzione di una lingua i glottologi, quando è possibile, studiano i dialetti parlati in aree lontane dagli epicentri metropolitani. Il pegliese tuttora in uso a Carloforte ci fornisce indicazioni sul pegliese-genovese di secoli fa.
Un esempio chiaro di questo conservatorismo è nella ricetta del pesto che Dellacasa ci propone (pag. 5).
 Con la ricetta di Ratto quella di Dellacasa ha in comune l’impiego del prezzemolo (ma non della maggiorana) e del burro. Menziona un formaggio piacentino mentre Ratto prescrive sardo e parmigiano, ingredienti che si sono poi affermati fino a entrare nell’odierno disciplinare del pesto. Bisogna tenere conto della disponibilità degli articoli alimentari in loco (per avere basilico tutto l’anno bisogna coltivarlo in serre dove la temperatura resti costante sui 21, 22 gradi, giorno e notte, pratica non comune neppure in Liguria fino a qualche decennio fa) e anche del fatto che il pesto quando Ratto ha scritto il suo libro era ancora in fase pionieristica-sperimentale (Rossi, per esempio, prescrive “formaggio d’Olanda” e parmigiano). Secondo Paolo Lingua questa salsa-bandiera della cucina genovese e ligure era nata verso metà Ottocento (vedi qui “Il mistero del pesto” di Paolo Lingua). E Dellacasa, come probabilmente altre cuoche e cuochi liguri emigrati, si atteneva ai testi ottocenteschi. Nel ricettario argentino non sono presenti i pinoli (e neppure le noci, una volta a Genova molto spesso usate al posto dei pinoli) il che si può spiegare sia con la loro scarsità in Argentina sia anche col fatto che né Ratto né Rossi li prescrivono.
Con la ricetta di Ratto quella di Dellacasa ha in comune l’impiego del prezzemolo (ma non della maggiorana) e del burro. Menziona un formaggio piacentino mentre Ratto prescrive sardo e parmigiano, ingredienti che si sono poi affermati fino a entrare nell’odierno disciplinare del pesto. Bisogna tenere conto della disponibilità degli articoli alimentari in loco (per avere basilico tutto l’anno bisogna coltivarlo in serre dove la temperatura resti costante sui 21, 22 gradi, giorno e notte, pratica non comune neppure in Liguria fino a qualche decennio fa) e anche del fatto che il pesto quando Ratto ha scritto il suo libro era ancora in fase pionieristica-sperimentale (Rossi, per esempio, prescrive “formaggio d’Olanda” e parmigiano). Secondo Paolo Lingua questa salsa-bandiera della cucina genovese e ligure era nata verso metà Ottocento (vedi qui “Il mistero del pesto” di Paolo Lingua). E Dellacasa, come probabilmente altre cuoche e cuochi liguri emigrati, si atteneva ai testi ottocenteschi. Nel ricettario argentino non sono presenti i pinoli (e neppure le noci, una volta a Genova molto spesso usate al posto dei pinoli) il che si può spiegare sia con la loro scarsità in Argentina sia anche col fatto che né Ratto né Rossi li prescrivono.
Nel complesso molte ricette della Cuxinea zeneize sono uguali a quelle della madrepatria, altre contengono modifiche, dovute principalmente all’ambiente. È interessante leggerle per confrontarle con le nostre, e anche per trarne qualche spunto. Per esempio, il “Porpetton de patate” (pag. 63) è costituito da patate bollite e besciamella dove, con il burro compiono anche olio (di oliva?) e fontina tagliata a pezzetti e fatta sciogliere nella salsa. Sembra piuttosto saporito e viene voglia di provarlo.
Infine, chi era Catainin Dellacasa? Non lo sappiamo. Sotto il suo nome compare, tra parentesi, “Nella Fogli”. Il suo volumetto è stato stampato a cura dell’associazione “Famiggia zeneize” come omaggio ai soci, e Luca Sessarego nella prefazione ci informa che questa associazione, che aveva sede in pieno centro a Buneos Aires, era formata da un’élite di genovesi e loro discendenti appartenenti alla classe più agiata della società. L’autrice di quest’opera doveva farne parte. Leggendo il testo si ha l’impressione che Catainin fosse una signora del ceto medio o alto, che conosceva la cucina, sapeva cucinare ma non era una cuoca dipendente. E parlava tanto il genovese quanto l’italiano. Alcune espressioni per le quali probabilmente non aveva trovato l’equivalente in genovese sono in un italiano che i ceti popolari non praticavano (“durante l’anno solare”, pag. 3, “assolutamente indispensabile”, pag. 4…). E le allusioni a Dante (pag. 3) e ai greci antichi (pag. 7), la prefazione firmata Catainin Dellacasa con i suoi consigli alle “scignorinn-e da mario che no san ancon ninte de cuxinn-a” e il finale che, pur mantenendo il tono colloquiale (ma non popolare) dell’opera, tende al lirismo, confermano questa impressione.