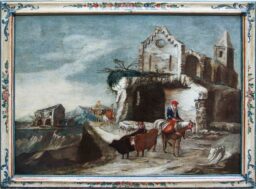Un metodo per rilevare la presenza di mercurio nell’acqua, un dispositivo impiantabile per la somministrazione localizzata di farmaci. Diverse parti protesiche, un sensore di contatto ideato per un piede robotico, composti e composizioni per il trattamento della fibrosi cistica. Sono solo alcune delle più recenti invenzioni che portano la firma della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, ben 1.056 oggetti in portfolio tra brevetti depositati e domande di brevetto. Solo nel 2019 l’Iit ha ottenuto la concessione di 29 brevetti europei.

Invenzioni che spaziano dall’area medicale alla robotica, fino alla nanotecnologia: «L’interesse della ricerca si sposta seguendo andamenti ciclici innescati da molteplici driven – spiega a Liguria Business Journal Lorenzo Rossi, Intellectual property manager di Iit – per esempio, l’anno in cui il Nobel per la Fisica è stato vinto dall’inventore del grafene, la scienza dei materiali ha rivolto la propria attenzione verso questo materiale. Negli ultimi anni il primo posto era sempre occupato dalle telecomunicazioni, per un certo periodo è cresciuta la robotica, l’anno scorso invece le tecnologie medicali hanno preso il sopravvento. Non parliamo solo di farmaci, ma anche di tutto ciò che riguarda le scienze della vita».
L’Iit cerca di coprire tutti i settori di interesse per la ricerca: «Dal nostro istituto nasce la proprietà intellettuale – ricorda Rossi – E i brevetti, al centro del trasferimento tecnologico, la nostra mission principale, sono il primo presidio per la protezione della proprietà intellettuale». A occuparsene una squadra di sette persone, quotidianamente al lavoro per far sì che un’invenzione dell’Istituto riesca a ottenere la concessione della domanda di brevetto: «Un team numeroso – sottolinea Rossi – se paragonato a quelli che lavorano nello stesso ambito negli altri centri di ricerca o università italiane».
Nel gruppo di lavoro guidato da Rossi, la maggior parte di persone si occupa della valutazione della brevettabilità delle invenzioni, segue procedure e aspetti tecnici e supporta i ricercatori nel percorso che, in linea di massima, si conclude con la concessione del brevetto. Un iter decisamente lungo: «Dopo un periodo di analisi interna all’Iit, della durata di circa 4-5 mesi – illustra Rossi – si prosegue con il procedimento d’esame della domanda che, mediamente, in un Paese europeo, dura circa 3 anni e mezzo. Una volta ottenuta la concessione, la vita del brevetto dura 20 anni».
Un ricercatore dell’Istituto italiano di tecnologia ha dunque nelle mani un’invenzione unica e rivoluzionaria, meritevole di protezione intellettuale. Si rivolge al team guidato da Lorenzo Rossi. Poi che succede? «L’inventore ci presenta il prodotto e il team ne valuta la brevettabilità – spiega – Svolgiamo quindi un’analisi a monte, propria del nostro istituto, per valutare tutti gli aspetti brevettabili dell’invenzione. E cerchiamo di capire insieme al ricercatore quale sia effettivamente l’invenzione brevettabile di quel determinato prodotto. Potrebbe essercene una, nessuna, o più di una. Si tratta di uno studio che, per esperienza, ci porta a raggiungere risultati migliori».
Individuata la brevettabilità, ha inizio l’iter vero e proprio, che parte con il deposito della domanda di brevetto in uno o più Paesi: «Generalmente, si sceglie di partire con l’Italia, per poi allargarsi ad altre nazioni, in Europa e Stati Uniti prima di tutto. Eventualmente, la domanda si estende anche a Cina e Giappone. Ogni nazione esegue un esame autonomo e secondo le leggi locali». I fattori da cui dipende la scelta sono più d’uno: «Prima di tutto si opta per i mercati in cui l’invenzione avrebbe maggior successo – sostiene – La scelta dipende anche dalle migliori possibilità di portare a termine il percorso di concessione, nonché dal budget a disposizione per quel brevetto: l’iter di deposito della domanda non è certo gratuito».
Costi di deposito a parte, in Italia il deposito di una domanda di brevetto comporta un esborso medio di 3.400 euro. In Europa si aggira sui 4.500 euro, 4.100 negli Usa. «Per invenzioni molto complesse, come quelle legate ai farmaci, oltre a pagare tasse aggiuntive, occorre anche allegare una documentazione più lunga: anche questo aspetto comporta un ulteriore costo – ricorda Rossi – Inoltre, durante il percorso d’esame della domanda, ogni interazione con l’esaminatore ha un prezzo. Pertanto, più numerosi sono questi scambi di comunicazione, maggiore sarà l’esborso da parte nostra. Anche per questo, periodicamente, il gruppo di lavoro valuta per ogni domanda se procedere con gli investimenti oppure abbandonare il percorso». A ciò si aggiungono costi esterni, come quelli di traduzione delle pagine di documentazione, affidate ad agenzie specializzate. Per fare un esempio, una recente domanda di brevetto, partita in Italia e poi allargatasi a Cina, Giappone e Usa, è costata alla Fondazione 72 mila euro.
Le attività di trasferimento tecnologico, nel loro complesso, generano ricavi superiori ai costi di protezione della proprietà intellettuale. Le sole attività di licensing, che fanno parte delle attività di trasferimento tecnologico, coprono il 40% dei costi di protezione della proprietà intellettuale. A questi ricavi se ne aggiungono altri, di tipo “indiretto”, sempre legati all’utilizzo del brevetto.
Anni di lavoro, lunghi e costosi, che hanno però permesso a tecnologie rivoluzionarie di ottenere la protezione della proprietà intellettuale. Tra quelle già sul mercato, Rossi ricorda in particolare due spin-off: la piattaforma robotica riabilitativa Hunova di Movendo Technology e la tecnica di lavorazione del grafene a opera di Bedimensional.
Leggi anche: Il ventilatore polmonare FI5 fermo al prototipo per colpa della burocrazia
Alcune innovazioni hanno dato anche un proprio contributo alle attuali esigenze sanitarie: «L’esempio più interessante è il ventilatore polmonare FI5, in cui F sta per Ferrari, I sta per Istituto italiano di tecnologia e 5 rappresenta il numero delle settimane impiegate per la progettazione del dispositivo». La Fondazione Iit ha deciso di lasciare cadere questa invenzione nel pubblico dominio: «Una scelta etica che ci è sembrata doverosa visto il difficile momento che stiamo vivendo – sottolinea Rossi – Non abbiamo limitato l’accesso a questa tecnologia: ognuno può liberamente scaricare dal nostro sito tutte le informazioni necessarie per realizzare questo ventilatore».
Il Covid non ha fermato la ricerca dell’Iit, ma ha comunque limitato il suo modo di lavorare, anche nel gruppo guidato da Lorenzo Rossi: «Il “contatto” con il ricercatore è fondamentale nel nostro lavoro – dice il manager dell’Iit – Il confronto diretto ci permette di risolvere in cinque minuti una questione che altrimenti si trasforma in una lunghissima serie di scambi di mail. Non si tratta di un rallentamento delle attività, quanto piuttosto di un frazionamento delle stesse».
Proseguono, anche in emergenza sanitaria, le collaborazioni esterne: «Al momento siamo in stretto contatto con l’Università di Stanford, con cui stiamo investigando la possibilità di realizzare nuovi farmaci basati sulla nanotecnologia. In passato, con Harvard, abbiamo svolto un bellissimo lavoro sui dispositivi per la stimolazione nervosa, che ci rende molto orgogliosi. Collaboriamo praticamente con tutte le università italiane e, appunto, anche molte straniere. Addirittura quella di Santiago di Compostela».