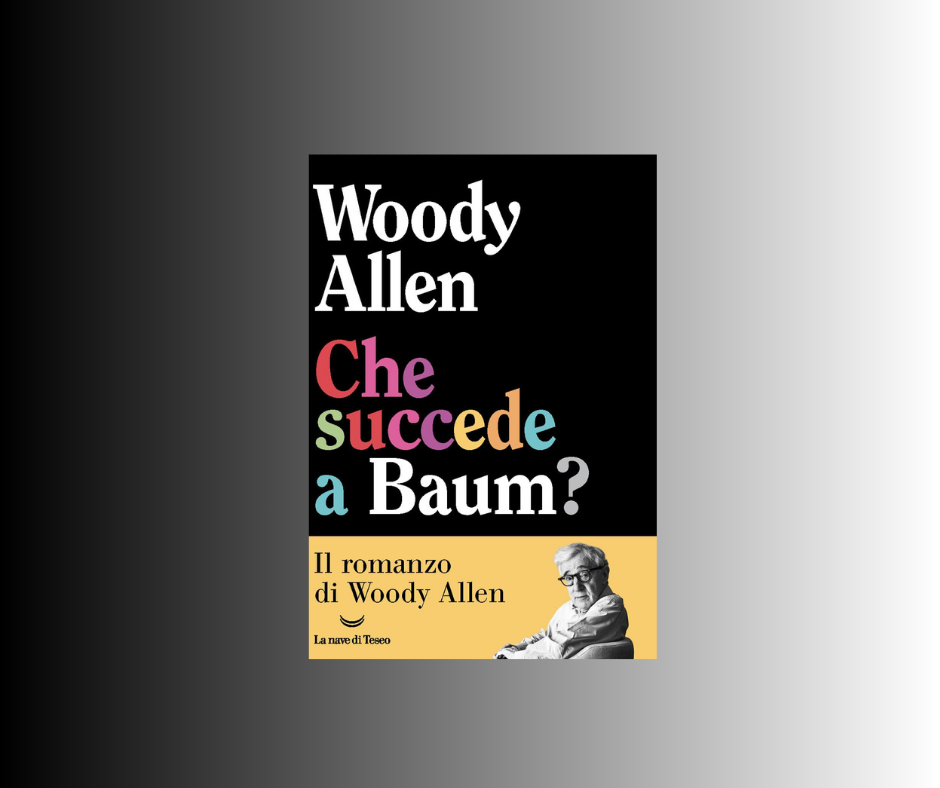La cosiddetta generazione dei millennials è cresciuta nell’ultimo decennio col mantra dell’austerità e della stabilità dei conti pubblici come il pilastro fondamentale di un paese finanziariamente sano e di una economia prospera. Da oramai tre decenni, il problema principale dell’Italia è quello di un debito pubblico troppo elevato rispetto al proprio prodotto interno lordo, rapporto che dal 1990 al 2019 è oscillato tra il 100% ed il 135%.
Nel corso del 2020, complice l’epidemia di Covid-19 che sta determinando il peggiore tracollo della nostra economia in termini percentuali dal 1944, questo rapporto schizzerà di 20 punti percentuali, fino al 155% (dati Mef aggiornato). Il deficit tra le entrate e le uscite dello Stato, rimasto per 7 anni sotto il fatidico 3%, quest’anno salirà fino al 10%, una percentuale che non si vedeva dal 1986 (gli anni della cosiddetta “finanza creativa”). Le misure a sostegno delle imprese varate dal Governo Italiano tra marzo e maggio genereranno emissioni di debito pubblico aggiuntive per quasi 100 miliardi nei prossimi mesi, mentre da qui a fine anno andranno in scadenza altri 300 miliardi di debito pubblico. Lo Stato si troverà nelle condizioni di dover rastrellare a breve quasi 400 miliardi, una cifra decisamente imponente date le condizioni attuali.
Nella variegatissima storia del nostro paese, sono stati ben pochi i periodi paragonabili con quello che stiamo vivendo attualmente. Dal punto di vista delle finanze pubbliche, il momento storico da cui possiamo trarre i migliori insegnamenti è forse il periodo immediatamente successivo all’unificazione nazionale, avvenuta il 17 marzo 1861.
In quell’anno, l’Italia era una Paese infinitamente più povero e sottosviluppato di quello che possiamo pensare. Pochissime infrastrutture (appena 1.900 km di ferrovie), tutte concentrate al Nord, analfabetismo all’80% con punte del 95% nel Sud e nelle Isole. L’economia era tutta incentrata sull’agricoltura, l’impresa industriale più grande della penisola era l’Ansaldo di Sampierdarena, che contava appena 1.000 addetti. Ciononostante, per un quindicennio abbondante, il neonato Regno d’Italia riuscì a emettere una mole di debito pubblico immensa, rastrellandone una parte consistente all’estero, prevalentemente tra Francia ed Inghilterra. Tutto questo mantenendo tassi di interesse stabili o addirittura in lieve discesa (tra il 3% e il 5%).
La motivazione? Il deficit pubblico tra entrate ed uscite dello Stato aveva raggiunto dimensioni impensabili, parliamo di un rapporto di 1:1,9 tra entrate e uscite. Nel 1861, per fare un esempio, le entrate del Regno d’Italia ammontavano a 457 milioni di Lire, le uscite a 903 milioni. In termini attuali, il deficit ammontava al 97% (ricordate il 3%!). Questo trend si mantenne costante per tutti gli anni 60 dell’800 (si veda immagine 1), venendo riassorbito solo negli anni 70, quando l’aumento delle entrate fiscali ci portò al tanto sospirato pareggio di bilancio (gli anni della “lesina”).
Nello stesso periodo 1861-1875, il debito pubblico esplose da 3.062 milioni di lire a 7.732 milioni (si veda immagine 2), cioè dal 40% a circa il 104% del pil stimato.
 Eppure, furono moltissimi a decidere di investire in Italia, nonostante la situazione in apparenza disperata delle finanze pubbliche. Tra il 1865 e il 1869, ben 450 milioni di lire di debito pubblico furono collocate all’estero. A tassi di interesse invariati. La motivazione? L’Italia non produceva deficit per il gusto di farlo, ma investiva per modernizzare il Paese.
Eppure, furono moltissimi a decidere di investire in Italia, nonostante la situazione in apparenza disperata delle finanze pubbliche. Tra il 1865 e il 1869, ben 450 milioni di lire di debito pubblico furono collocate all’estero. A tassi di interesse invariati. La motivazione? L’Italia non produceva deficit per il gusto di farlo, ma investiva per modernizzare il Paese.
Nel 1861, le ferrovie della penisola ammontavano a 2.700 km complessivi. Nel 1879, i km in esercizio ammontavano a quasi 10.000, quadruplicando in meno di un ventennio (si veda immagine 3). 
Tra il 1869 e il 1879 vennero costruiti quasi 6.500 km di strade (si veda immagine 4), prevalentemente nel Mezzogiorno, dove il 90% dei Comuni altro accesso non aveva che i sentieri usati per la transumanza del bestiame.
Nello stesso momento in cui il Paese si dotava di infrastrutture moderne, aumentavano le entrate fiscali. Dai 457 milioni del 1861, le entrate raggiunsero i 1.100 milioni, complici un aumento innegabile delle imposte ma anche la notevole vitalità economica che il nuovo Regno aveva acquisito.
Abbiamo sbagliato qualcosa nell’ultimo decennio? In parte sì, in parte no. La grande lezione del primo decennio dell’Italia unita è che il mercato è disposto ad accettare e finanziare aumenti di spesa finalizzati alla modernizzazione economica del Paese (“spese straordinarie”), mentre altrettanto bene non sarebbe andata se avessimo investito in “spesa corrente”, ovvero spesa improduttiva il cui unico obbiettivo è fare welfare fine a sé stesso. Questa è la trappola in cui siamo caduti da oltre un quarantennio. Col deficit pubblico l’Italia non sta finanziando la modernizzazione del Paese, ma il mantenimento di uno stato sociale farraginoso ed antiquato. Esplicativo è l’esempio del reddito di cittadinanza che, al modico costo di 7 miliardi di euro annuali (lo 0,4% del pil) produce effetti positivi per lo 0,1%.
Pertanto, di fronte alla tragedia che si sta vivendo, che ci espone ad una profonda riflessione sull’importanza della programmazione, troppo spesso dimenticata per far posto alla logica elettorale, si potrebbe cogliere l’opportunità del “fare di necessità virtù”. L’attuale tempesta verrà affrontata con una straordinaria immissione di liquidità, la strategia di investimento di tali risorse determinerà il futuro dell’Italia. Si tratterà di prestiti, la cui capacità di restituzione dipenderà dal livello di crescita.
Come evidenziato nell’articolo, il tema della sostenibilità del debito dipende anche dalla politica di investimento. Investire nelle infrastrutture, seppure con un deciso incremento del deficit di bilancio, spingerebbe una crescita del pil consentendo sul medio-lungo periodo di contenere il rapporto deficit/pil, rafforzando l’economia dall’altro lato e guadagnando appeal sui mercati. Rilanciare l’Italia significa inevitabilmente rinnovare il tessuto infrastrutturale. Inoltre, a fronte del numero di opere incompiute, la traccia da seguire è piuttosto immediata, poiché quelle opere richiederebbero tempistiche più brevi della progettazione ex novo.
(Davide Siviero e Andrea Vella)