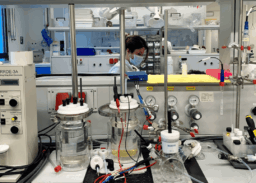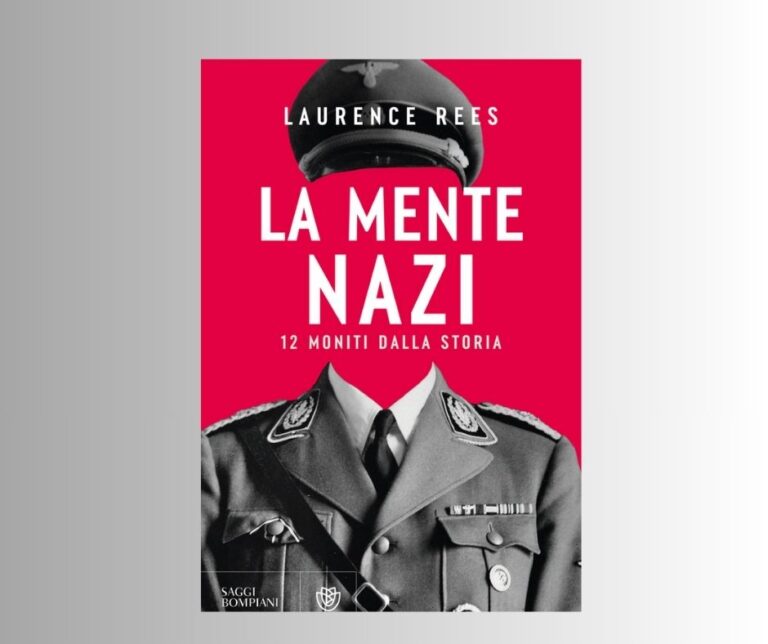“La mente nazi” di Laurence Rees (Bompiani, traduzione di Jadel Andreeto) formula le lezioni che dovremmo trarre dal nazismo. Il libro si articola in dodici capitoli che analizzano le origini, le motivazioni e le conseguenze di quella visione del mondo e propongono ciascuno un monito specifico.
Moniti che in questi giorni sembrano tanto più opportuni, con le democrazie minacciate da regimi autocratici ai loro confini e, in alcuni paesi, dal tentativo di concentrare potere e presentare come nemici gli avversari politici al loro interno.
Capire la mentalità nazista può qundi aiutarci a capire la mentalità dei nuovi nemici della democrazia e della libertà. L’autore, però, ci avverte: se è vero che “senza una solida conoscenza dei fatti del passato, i moniti che ci vengono consegnati rischiano di non essere compresi fino in fondo” …è anche vero che “per comprendere davvero la mentalità nazista, dobbiamo accettare una verità fondamentale: siamo tutti figli del tempo e del luogo in cui nasciamo” (pag. 11).
Ma se il tempo e il luogo che hanno contribuito a formare quella mentalità appartengono al passato, a che scopo studiare i fatti di quel tempo? Il passato non si ripete. Rees non lo spiega in modo esplicito, ma a noi sembra di poter dedurre che non si ripetono le circostanze in cui certi avvenimenti sono accaduti, non torneranno mai le camicie brune a spargere il terrore nelle strade della Germania, come in Italia non sono un pericolo gli imbecilli con il braccio teso nel saluto (pseudo)romano e magari il busto di Mussolini in casa: ricorrenti sono le dinamiche che generano gli eventi storici, e certi tratti psicologici appaiono insiti nella natura umana. Determinate circostanze possono (ri)mettere in moto o accelerare determinate dinamiche. Ma attenzione: non è affatto semplice riconoscere per tempo tali circostanze. Rees mette in guardia da uno dei luoghi comuni più diffusi, secondo cui “certi orrori siano nati dal carattere autoritario della società tedesca. È una spiegazione troppo facile che non rende giustizia alla complessità del reale. I criminali tedeschi che compaiono in queste pagine avevano motivazioni molto diverse tra loro: alcuni erano cresciuti in ambienti rigidi e gerarchici, altri no. E poi c’è un dato importante da tenere a mente: molti di quelli che presero parte atttiva allo sterminio degli ebrei non venivano affatto dalla Germania: arrivavano dalla Lituania, dall’Ucraina, dalla Romania e da altri paesi dell’Europa orientale (…) La verità scomoda è che quei crimini terribili non avvennero perché i nazisti erano tedeschi ma perché erano essere umani (…) L’ingiustizia basta sull’etnia, sulla razza o sull’origine può emergere in qualuinque società, in qualunque parte del mondo (pag. 390).
Illuminanti sono i capitoli in cui l’autore ricostruisce l’evoluzione delle modalità genocidiarie praticate dai nazisti, dalle fucilazioni effettuate dagli Einsatzgruppen allo sterminio di tipo industriale dei campi di annientamento come Auschwitz, che oltre a essere più efficienti nel rapporto tra tempo e mezzi impiegati e persone uccise avevano il vantaggio di liberare i persecutori dal confronto diretto con le loro vittime. Perché, e questo è uno dei tratti più interessanti del libro che di solito non vengono messi in evidenza, parte degli assassini con la svastica non era costituita da sadici e psicopatici. Certo, l’attività di sterminio lasciava a costoro la possibilità di esercitare liberamente le loro inclinazioni, ma molti non sopportavano l’orrore dei crimini che dovevano commettere e chiedevano di esserne esentati. E non subivano punizioni, venivano considerati con condiscendenza per la loro “debolezza” e trasferiti ad altri compiti. Più problematici per i comandanti era il numero, ben più numeroso, di chi, dopo avere ucciso, subiva conseguienze psicologiche profonde. “Rudolf Höss – scrive Rees – comandante di Auschwitz, nelle sue memori postbelliche scrisse che ‘molti membri degli Einsatzkommando non potendo più sopportare di sporcarsi di sangue, si uccisero‘” (pag. 300).
Ma allora come si è trovata la manovalanza per eseguire l’olocausto? Rees ricorda noti studi di psicologi americani in cui si sono sperimentati i comportamenti di persone chiamate a ruoli di vittime e carcerieri/torturatori e cita, a proposito di uno di questi esperimenti, un’osservazione di Zygmunt Bauman che a nostro avviso dovrebbe essere scolpita in targhe da affiggere nelle aule scolastiche: ‘Particolare scalpore e collera suscitò l’ipotesi che la crudeltà non venga commessa da persone crudeli, ma da uomini e donne comuni che cercavano di assolvere nel modo migliore i propri normali compiti; e la conclusione che, mentre la crudeltà risulta sì correlata, ma scarsamente, con la le caratteristiche personali di chi la commette, appare invece correlata molto fortemente con il rapporto di autorità e subordinazione, con la normale, quotidiana struttura del potere e dell’obbedienza’” (pag. 339).