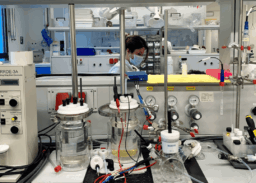L’Europa rilancia il nucleare e l’Italia in questo processo gioca un ruolo importante. Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare sono pronte a rispondere alla nuova domanda. Il nostro Paese negli anni Sessanta era uno dei primi al mondo nel nucleare, per competenze e per produzione, con il referendum del 1987 ha rinunciato a ottenere energia dall’atomo. Ma non ha perso la capacità di farlo. Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare sono riuscite a mantenere le competenze necessarie, lavorando in Italia nel “decommisioning” delle centrali già costruite e all’estero nella realizzazione di nuovi impianti. E con loro hanno lavorato altre aziende italiane.
La scheda
Ansaldo Energia è oggi una società controllata al 99,60% da Cdp Equity e per il restante da Shanghai Electric Corporation. È un fornitore di soluzioni a ciclo completo sperimentate e flessibili per la produzione di energia. Il know-how del Gruppo Ansaldo Energia (che comprende Ansaldo Green Tech e Ansaldo Nucleare) abbraccia tutte le principali tecnologie che rendono possibile la transizione energetica: dalle turbomacchine al service, dagli elettrolizzatori alle microturbine, fino alle tecnologie nucleari.
Ansaldo Nucleare e la sua controllata Ansaldo Nuclear Ltd (Uk) operano insieme come una “one-stop company” specializzata nel settore atomico. Nata a Genova nel 1966 come Ansaldo Meccanico Nucleare spa, nel 1999 Ansaldo Nucleare è diventata una divisione di Ansaldo Energia e il 1° novembre 2005 si è trasformata in una società indipendente partecipata al 100% da Ansaldo Energia. Ansaldo Nucleare copre tutte le attività nucleari, dalla produzione di componenti critici ad alta tecnologia alla progettazione e costruzione di nuovi impianti, dal decommissioning alla ricerca avanzata nel campo del waste management, della fusione, degli impianti di quarta generazione e degli small modular reactors. Ansaldo Nucleare ha inoltre in atto collaborazioni con centri di ricerca e università, e partecipa a partnership pubbliche e private finalizzate a colmare il divario tra ricerca di base e applicazioni industriali.

Daniela Gentile, amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare, ci racconta questa storia di perseveranza negli alti e bassi di quasi settanta anni.
– Come inizia la storia di Ansaldo Nucleare?
«La storia del nucleare in Italia è iniziata nel decennio dei Sessanta. In quegli anni è nata Ansaldo Meccanico Nucleare, nel 1966. Poco dopo, nel 1972, è stata costituita la Nira. Le due società maturano competenze partendo da licenze degli Stati Uniti, della Westinghouse e della General Electric. Nel 1981 Ansaldo Meccanico Nucleare diventa Ansaldo Impianti, che nel 1989 si fonde con Nira e dà vita ad Ansaldo Nucleare. Io sono stata assunta in Nira nel 1985, subito dopo essermi laureata a Genova in ingegneria chimica, ed ero con l’ingegner Adinolfi. Seguivamo la tecnologia pressurizzata. Negli anni Ottanta c’è stata la grande partecipazione dell’Italia, con Enel, Ansaldo e Nira, all’avventura del Superphénix in Francia, che utilizzava la tecnologia dei reattori veloci raffreddati a sodio. Di fatto l‘Italia era uno dei Paesi protagonisti nell’energia nucleare, il terzo al mondo per produzione. Nel 1986 ha avuto il picco di produzione di poco meno di 9, 8,7 gigawattora di energia proveniente da centrali nucleari, che corrispondeva più o meno a un 5% dell’incidenza sulla produzione dell’energia elettrica. La prima centrale era stata costruita nel 1963 a Latina, negli anni immediatamente successivi, vennero realizzate le centrali di Trino Vercellese, Caorso e Garigliano. Purtroppo Chernobyl, nel 1986, con l’ondata emotiva conseguente, ha cambiato completamente lo scenario: dopo l’incidente si è continuato nella costruzione dell’impianto di Montalto di Castro – sarebbe stato un impianto più grande degli altri, dotato di tecnologia di raffreddamento secondo lo schema ad acqua bollente – ma il referendum del 1987 ha segnato la fine del progetto. Tra il 1988 e il 1990 i governi hanno deciso di chiudere tutte le centrali elettronucleari italiane».
– Che cosa ha potuto fare Ansaldo Nucleare?
«In quel frangente storico Ansaldo ha avuto il coraggio di rimanere nel settore nucleare. È stata una decisione davvero coraggiosa. E lungimirante. Il paese aveva deciso che non ci sarebbe più stato un nucleare in Italia e Ansaldo lo ha mantenuto lavorando all’estero, proseguendo nella collaborazione con tecnologie, con sviluppatori di tecnologie nucleari stranieri in paesi stranieri. L’esempio più importante è la partecipazione agli impianti di Cernavoda in Romania. Negli anni Ottanta nasce la prima unità. L’impianto ha tecnologia canadese, il vendor, l’owner della tecnologia è Candu, che oggi è in AtkinsRéalis, un grosso gruppo canadese. Candu ha realizzato la parte del cuore nucleare, noi tutto quello che si chiama balance of plant, la parte di sistemi meccanici ed elettrici ausiliari che al di fuori dell’isola nucleare gestiscono l’impianto. Negli primi anni del 2000 si è replicato, la Romania ha raddoppiato, con un secondo impianto uguale al primo, e devo dire che l’ingegner Adinolfi ne va molto fiero. La realizzazione degli impianti nucleari nel corso degli anni ha incontrato molte difficoltà, ma quell’impianto fu costruito con solo sei mesi di ritardo e pochi punti percentuali di extra budget. Il che dimostra che c’è un modo di fare il nucleare in tempi ragionevoli. Ansaldo Nucleare ha partecipato all’impresa e questo è un punto distintivo».
– Dopo il referendum, mancando il mercato domestico, l’attività nel nucleare, per quanto salvaguardata, deve essersi ridotta.
«Nel palazzo della Nira, che poi è stato abbattuto, eravamo tanti, un migliaio. Poi il gruppo si è ridotto a qualche centinaio di persone. Si sono perse competenze. Alcuni sono andati a fare altro, altrove, molti si sono trasferiti all’estero, le università hanno cominciato ovviamente ad avere sempre meno iscrizioni a Ingegneria Nucleare. Ancora oggi, comunque, questa facoltà c’è al Politecnico di Milano, a quello di Torino, a Roma, a Pisa, a Bologna e a Palermo. D’altra parte alcune competenze, tra le persone rimaste, sono cresciute.
– Perché?
«Perché la chiusura delle centrali in Italia ha richiesto un’attività di decommissioning, lo smantellamento dei siti. E qua l’Italia si è trovata a giocare un ruolo di precursore. Ansaldo Nucleare ha incominciato a costruirsi competenze nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari. E questo ha portato l’azienda a fare grandi passi avanti, per esempio, nella movimentazione robotica. Oggi al nostro interno abbiamo un segmento che cura in particolar modo la meccatronica. Si è partiti dallo sviluppo della movimentazione di parti nucleari, dove il contributo della persona deve essere il minore possibile. Questa competenza ci è riconosciuta, abbiamo partecipazioni importanti in contratti per la realizzazione di apparati per la movimentazione da remoto, il cosiddetto remote handling. È nata poi l’avventura collegata alla fusione, ai grandi progetti di fusione, alla fine del secolo scorso. Pensiamo a Iter. Siamo nella fase sperimentale della tecnologia più borderline che possa esistere. Ansaldo c’è dentro, sia Ansaldo Energia sia soprattutto Ansaldo Nucleare».
– Iter è nato nel 2006, da allora qual è stato il contributo di Ansaldo Nucleare?
«Ansaldo Nucleare ha partecipato a contratti insieme ad altri partner italiani. Bisogna dire che la nostra azienda non è affatto l’unica nel contesto nazionale ad aver mantenuto competenze, anzi, le competenze della filiera italiana nel nucleare sono importanti e sono riconosciute a livello europeo, e non solo europeo, anche mondiale. Nel campo della fusione siamo tanti italiani in Iter e noi abbiamo contratti insieme ad altri partner. Possiamo dire che l’Italia è partner primario del progetto. Noi in consorzio insieme a Mangiarotti, Westinghouse e Walter Tosto stiamo realizzando per Iter parte dei settori del tokamak. Malacalza ha fornito tutti i magneti. Quindi siamo impegnati nei nuovi reattori all’estero, nelle tecnologie esistenti e nello sviluppo della fusione. E poiché con il passare degli anni gli impianti nucleari hanno necessità delle cosiddette attività di service o di estensione di vita utile, anche qui Ansaldo Nucleare è stata capace di ritagliarsi un ruolo. Tra i contratti più recenti c’è quello che riguarda la centrale nucleare di Krško in Slovenia per attività di estensione della sua vita utile.
La centrale di Krško è stata costruita nel 1981, è entrata in attività nel gennaio 1983, e da oltre 40 anni fornisce un quarto di energia della Slovenia e un quinto di quella della Croazia. L’impianto è in comproprietà dei due paesi e delle compagnie Gen Energija, slovena, come parte della Elektro-Slovenija (Eles) e della croata Hrvatska elektroprivreda (Hep).
Si tratta di verificare tutti i componenti dell’impianto ed effettuare le attività di manutenzione, sostituzione, controllo affinché l’impianto possa continuare a essere esercito. Un contratto eseguito bene, con soddisfazione del cliente, che ci ha consentito nel corso degli anni seguenti di ottenere, come anche adesso, tante altre piccole commesse e quindi di vincere diverse gare su sistemi secondari dell’impianto di Krško. Effettuiamo attività di service anche lontano, come nell’impianto di Embalse in Argentina dove è intervenuta anche Ansaldo Energia. Ansaldo Nucleare e Ansaldo Energia in Embalse hanno eseguito le attività necessarie per allungare la vita utile dell’impianto e hanno rivisto anche tutte le funzionalità della turbina a vapore. Tra queste attività presenti e la partecipazione alla ricerca sulla fusione, proiettata nel futuro, c’è in mezzo una novità che non è sperimentale ma già attuabile: quella dei nuovi reattori. Attività in cui l’Italia può veramente giocare una partita per fare la differenza».
 – Come siete arrivati ai nuovi reattori?
– Come siete arrivati ai nuovi reattori?
«È stata importante la collaborazione con Westinghouse, che a valle di Chernobyl ha iniziato un’attività di rivisitazione dei principi dei sistemi legati alla gestione dei sistemi di sicurezza degli impianti nucleari: questi sistemi devono essere in grado di entrare in funzione e garantire lo spegnimento in sicurezza del reattore in qualsiasi situazione. Ecco, tutte queste attività hanno portato a una collaborazione molto stretta, veramente molto stretta, tra Ansaldo Nucleare e Westinghouse, nella realizzazione del progetto cosiddetto AP1000 e AP600. Sono progetti e tecnologie di reattori nucleari pensati per rispondere a due esigenze. La prima, era quella che dicevo, ovvero indirizzare a una gestione di sicurezza passiva le tecnologie nucleari esistenti, la seconda è quella di renderli più modulari possibili. Nell’ambito del progetto Westinghouse AP1000 si è incominciato a studiare come realizzare gli impianti in maniera modulare, assemblando in fabbrica alcune parti che poi possono essere trasportate in cantiere, accelerando la costruzione di un impianto nucleare. Si trattava di tagliare tempi e costi. Nel cantiere la costruzione è più complessa, più lunga, più difficile e più costosa. Non è sostenibile che occorrano decenni per costruire una centrale. Occorre trovare nuove modalità costruttive».
L’11 dicembre 2022 il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha adottato con 409 voti a favore, 173 contrari e 31 astenuti (su 613 votanti) la relazione sui piccoli reattori nucleari, a prima firma dell’eurodeputato sloveno del Ppe, Franc Bogovič, che chiede una specifica strategia industriale globale per lo sviluppo dei piccoli reattori nucleari nell’Unione Europea. I piccoli reattori modulari (small modular reactors) sono reattori nucleari più piccoli sia in termini di potenza sia di dimensioni fisiche, rispetto alle centrali tradizionali su scala gigawatt, con una potenza compresa tra 10 e 300 MegaWatt. Si basano su tecnologie esistenti e sono progettati per essere costruiti in fabbrica in forma modulare standard e il loro vantaggio principale è che possono essere assemblati in fabbrica e poi spediti e installati sul posto, quindi anche in aree remote con capacità di rete limitata o in aree in cui l’uso di grandi centrali nucleari tradizionali non è possibile. Questa tipologia di reattori utilizza reazioni di fissione nucleare per creare calore che può essere utilizzato direttamente o per generare elettricità.
– La partecipazione di Ansaldo Nucleare ai progetti AP1000 e AP600 di Westinghouse è stato quindi un passo fondamentale?
«Sì, perché ci ha consentito di contribuire molto attivamente alla definizione di queste peculiarità progettuali, di questa nuova tecnologia e di collaborare con Westinghouse alla realizzazione dei primi AP1000 in Cina. In quel paese abbiamo partecipato al contratto di Sanmen, fornendo una parte del contenimento metallico del reattore attualmente in funzione. Abbiamo accumulato esperienza di progettazione di quelli che poi sono diventati gli ingredienti fondamentali del nuovo nucleare, degli small modular reactors, che rendono possibile quell’assemblaggio preliminare in fabbrica di cui parlavo».
– I costi di costruzione si tagliano riducendo le dimensioni?
«Non solo. Bisogna ridurre le dimensioni – mantenendo tutti quei concetti di sicurezza passiva intrinseca sviluppati da Chernobyl a oggi – ma anche far sì che gli impianti siano uguali, ridurre il più possibile le modifiche tra un impianto e l’altro: questo garantisce una riduzione dei tempi di licensing, ovvero di autorizzazione. L’iter autorizzativo alla realizzazione di un impianto nucleare o di una nuova tecnologia nucleare è lungo, molto lungo. Una volta validato, qualificato un impianto, se gli altri sono uguali la loro qualificazione richiederà tempi molto inferiori. I reattori più piccoli offrono un altro vantaggio: possono essere messi a servizio di distretti industriali. E quindi possono diventare quell’elemento a garanzia di maggiore competitività del sistema industriale che gli industriali italiani vanno reclamando. Giustamente, perché oggi si trovano penalizzati da un costo dell’energia molto più alto rispetto agli altri paesi europei, circa 30% rispetto alla Francia».
– Se gli impianti fossero a servizio di determinati territori potrebbero essere accolti con più interesse?
«L’idea è anche questa, di rappresentare il beneficio a livello locale di un impianto relativamente piccolo che non solo serve il distretto industriale – i primi a reclamare questo approccio sono gli acciaieri – ma può aiutare diverse industrie nelle altre forme di energia di cui hanno bisogno, perché non tutto è elettrificabile. Gli small reactors non solo producono energia elettrica competitiva e continua, possono contribuire ad abilitare la produzione a basso costo dell’idrogeno, che può generare alte temperature. Quindi parliamo di teleriscaldamento, di calore utilizzabile per diversi processi industriali, pensiamo alle cartiere, al food. Concludendo, sono molti gli aspetti che possono facilitare una comprensione dei benefici che un impianto piccolo, intrinsecamente sicuro, può portare a una comunità, industriale e non. Inoltre in questi anni la tecnologia nucleare ha lavorato molto per riuscire a governare la flessibilità del reattore: un tempo si diceva che il reattore deve funzionare sempre al 100% e di conseguenza è difficilmente compatibile con le rinnovabili nella produzione di energia ma adesso non è più così, perché le tecnologie dei reattori piccoli si sono evolute in modo da renderli flessibili e quindi compatibili con la gestione delle rinnovabili. Il nucleare non deve essere visto come il divoratore delle rinnovabili: i due tipi di produzione di energia sono complementari: la verità è che il nucleare è il miglior amico delle rinnovabili. Perché l’energia rinnovabile sappiamo che per sua natura è intermittente e quindi ha necessità di un importante contributo di stoccaggio dell’energia affinché questa, sempre e solo in forma elettrica, possa essere resa disponibile. Lo scenario energetico al 2050 è un puzzle composto da tanti tasselli e più il sistema è complesso più è necessario avere più armi a disposizione per gestirlo».
– Il nucleare quindi dovrà avere uno spazio importante nel nostro ventaglio energetico?
«Sì ma la sua quota può arrivare a un’incidenza massima del 10% delle necessità dell’Italia nel 2050. Il resto deve venire da energie rinnovabili o legate al gas con la cattura della CO2. Il nucleare può dare un contributo parziale rispetto alla totalità dell’energia elettrica, ma teniamo presente che una partecipazione del 10% del nucleare alla produzione di energia elettrica 2050 secondo uno studio che abbiamo fatto insieme a Nomisma genererebbe un risparmio di 40 miliardi all’anno».
– Gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione europea portano a rivalutare il ruolo del nucleare?
«Sì. Due fattori di recente, a mio parere, hanno portato a riconsiderare completamente il nucleare sotto un’altra veste. Il primo è sicuramente l’obiettivo del 2050, il secondo è la necessità di risolvere il problema nato con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e quindi il problema del costo del gas che si è riversato su tutti i paesi europei e ci ha fatto comprendere quanto essere monodipendenti per l’energia fosse pericoloso. La consapevolezza di questi due elementi ha portato l’Europa a riconsiderare il nucleare. Ricordiamoci che nel 2019, quando il Green Deal è nato, nella tassonomia europea non c’erano né il gas né il nucleare. Sono stati piano piano reinseriti, il gas grazie alle battaglie condotte attraverso le associazioni, che hanno fatto notare come non si possa farne a meno, visto che rispetto al carbone abbatte del 50% le emissioni. E hanno proposto: per diminuire le emissioni cominciamo a togliere di mezzo il carbone e passare al gas. Bisogna anche dire che l’Italia è stata molto brava in questa attività in favore del gas. Il secondo passo, e qui la Francia ha lavorato molto, è stato quello di inserire il nucleare».
– L’invasione dell’Ucraina ha segnato uno spartiacque
«A partire da quel momento e in seguito poi alla crisi energetica generata dalla guerra l’Europa ha cominciato a fare velocemente passi per tornare a parlare di nucleare. Molti paesi europei stanno realizzando gli strumenti per effettuare investimenti nel nucleare della generazione attuale. La Romania è il primo esempio che ci vede nuovamente coinvolti, perché questo paese sta negoziando, sempre con Candu, il completamento delle due unità che sono rimaste sospese a Cernavoda, la 3 e 4. Cernavoda in questa maniera si troverebbe ad avere quattro impianti uguali, tutti e quattro con contributo di Ansaldo Nucleare e dell’Italia, perché insieme a noi a Cernavoda ci sono molte altre aziende italiane nostre fornitrici. Nell’aprile scorso Ansaldo Nucleare ha incontrato nella sede del gruppo Ansaldo Energia oltre 70 aziende italiane attive nel campo della filiera nucleare per presentare e approfondire gli sviluppi relativi ai progetti legati al mercato nucleare in Romania. L’incontro è avvenuto a valle della firma del memorandum of understanding che si è tenuta in febbraio tra Sace, Ansaldo Nucleare e l’azienda romena per l’energia nucleare Societatea Nationala Nuclearelectrica. L’accordo prevede una linea di finanziamento fino a 2 miliardi di euro per il progetto di plant life extension (prolungamento di vita) dell’unità 1 di Cernavoda e il completamento dell’unità 3 e 4. Ansaldo Nucleare ha presentato nei dettagli ai fornitori italiani il progetto relativo al prolungamento di vita dell’Unità 1 nel quale avrà un ruolo primario. Un altro paese che ci sta pensando è la Repubblica Ceca, che poi deciderà quale sarà il vendor di riferimento, però ha già pianificato la realizzazione relativamente a breve di impianti nucleari con le tecnologie attuali. Ci sono altri paesi che ci stanno pensando, come la Bulgaria, la Francia ha appena dichiarato la realizzazione di sei nuovi impianti EPR, probabilmente ne andrà a realizzare anche altri, quindi l’Inghilterra, e altri paesi europei».
– Quali sono i passi istituzionali di questa svolta europea?
«Importante è stata la costituzione della European Industrial Alliance on Small Modular Reactors, che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo, la dimostrazione e l’installazione dei piccoli reattori modulari in Europa entro l’inizio del decennio 2030, in linea con la recente comunicazione Ue per il raggiungimento dei target climatici per il 2040 e il 2050, in cui si sottolinea che tutte le tecnologie saranno necessarie per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica. All’Alliance sono associati tutti i soggetti europei interessati a contribuire e a partecipare a un programma di realizzazione di nuove tecnologie legate agli Small Modular Reactors in Europa. Ovviamente noi ci siamo, ma è notevole è che l’Italia sia presente con un numero di partecipanti secondo solo, e di poco, alla Francia. Questo dimostra come il sistema italiano veda nel nucleare opportunità di sviluppo indipendentemente dalla realizzazione degli impianti nucleari in Italia, e anche quanto sia considerato a livello europeo. Nella prima assemblea generale dell’SMR Alliance i commissari europei lo hanno rimarcato. Anche il ministero dell’Ambiente si è iscritto all’Alliance, ed è un altro segnale importante del fatto che l’Italia al suo interno sta tornando a rivalutare questa opportunità».
– Quali sono gli obiettivi concreti di questa alleanza?
«Creare sinergie, definire percorsi di sviluppo e tecnologie che poi possono generare finanziamenti di progetti, perché sviluppare il nuovo nucleare richiede investimenti significativi. Ci sono molte tecnologie che quando sono considerate dalle autorità europee di importanza particolare vengono abilitate a superare i limiti definiti dagli aiuti di Stato. Ecco, abilitare anche il nucleare è uno dei percorsi che l’Europa sta intraprendendo. E l’Italia, che non ha di fatto il nucleare da 40 anni, ha mantenuto competenze di formazione di altissimo livello, tali da essere riconosciute a livello europeo. L’Smr Industrial Alliance ha al suo interno dei gruppi di lavoro, e l’Italia è coordinatrice, con il professor Ricotti del Politecnico di Milano, del gruppo di lavoro legato alla formazione delle risorse, mentre nel gruppo di lavoro della supply chain il vicechair è Massimo Tacconelli della Walter Tosto».
– Come si può quantificare la capacità di produzione del nostro Paese?
«Il Politecnico di Milano ha valutato che a oggi il comparto manifatturiero italiano è già pronto per produrre una media di otto Smr all’anno, reattori di tecnologia Smr like. Quindi la manifattura italiana nel nucleare c’è, è importante ed è riconosciuta a livello europeo e mondiale, e può consentire alla nostra produzione industriale di essere più competitiva. In questo processo noi di Ansaldo ci vediamo come una parte significativa, grazie all’attività portata avanti negli anni, ci sentiamo di poter giocare un ruolo di coordinamento e integratore della supply chain italiana. Ora ci stiamo confrontando con la Edf francese. L’anno scorso Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Edf e Nuward hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo delle tecnologie degli Small Modular Reactor e il coinvolgimento nell’intera filiera dei reattori già esistenti, tra cui gli EPR1200. Ansaldo Nucleare può giocare un ruolo di partner chiave nella progettazione della nuova tecnologia di reattori e come fornitore di sistemi e componenti speciali. L’intero gruppo Ansaldo Energia potrà essere coinvolto nella fornitura di turbine per gli impianti di tecnologie esistenti e future».
– Voi lavorate su licenze fornite?
«Abbiamo lavorato in passato sempre su licenze fornite, però in questa Alliance non solo collaboriamo su tecnologie altrui ma partecipiamo, insieme alla Romania e al Belgio, alla realizzazione di una nostra tecnologia. Una tecnologia cosiddetta di quarta generazione, di reattori raffreddati a piombo, dove Ansaldo Nucleare vuole giocare una partita di detentore di proprietà intellettuali. Questo è un percorso partito all’inizio degli anni 2000 partecipando a piccoli progetti europei, ed è arrivato alla costituzione di un consorzio con Enea e Raten, che è l’equivalente romeno di Enea. Questo consorzio, che si chiama Falcon, ha l’obiettivo di sviluppare una tecnologia di small modular reactor di quarta generazione raffreddati a piombo. Si è inoltre gradualmente allargato il colloquio con Sck Cen, centro di ricerca nucleare belga. L’obiettivo è quello di condividere lo sviluppo di questa tecnologia con altri paesi europei, sempre nella consapevolezza che sviluppare tecnologie nucleari è molto importante. Inoltre avere tecnologie condivise tra noi, il Belgio e la Romania ci consente e consentirà di partecipare ai progetti di realizzazione. È importante anche la sinergia con Ansaldo Energia, perché oltre alle turbine stiamo guardando a parti che si possono produrre all’interno di Ansaldo Energia. Quindi la rinascita del nucleare può rappresentare per Genova una grandissima opportunità. E in questa prospettiva il tema delle competenze è enorme. Se il nuovo nucleare partirà, in Italia per l’Italia o solamente in Italia per l’Europa, saranno necessarie determinate competenze».
– L’Università di Genova non potrebbe aprire una facoltà?
«L’Università di Genova ha un corso di impianti nucleari con il professor Lomonaco, con il quale siamo in contatto. Non è un indirizzo nucleare come nelle altre città che avevo citato, però un segnale positivo, me lo diceva il professor Ricotti, è che c’è stato un aumento molto significativo di iscrizioni al primo anno di Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano. I giovani stanno guardando nuovamente agli indirizzi di specializzazione nucleari come un potenziale sbocco per il loro sviluppo professionale, perché hanno la consapevolezza della necessità del nucleare e la sensibilità nei confronti dei temi legati alla sostenibilità. Sono molto sensibili ai temi legati alla sostenibilità e vedono nel nucleare un alleato, come effettivamente è. Gli iscritti sono un paio di centinaio, non bastano ma considerate le condizioni di partenza sono tanti. Ricotti dice che così tante iscrizioni al primo anno non le aveva mai viste. Ma non solo, c’è da coltivare il percorso di crescita delle skills a livello universitario, anche a livello di istituti tecnici: servono competenze per la manifattura, la saldatura. Competenze sulle quali si può creare un percorso virtuoso di crescita. E anche in questo l’Italia è sempre stata avanzata. E ricordiamo che a Genova c’è l’Istituto Italiano di Saldatura, un ente nazionale. Abbiamo una grande tradizione anche in questo campo».