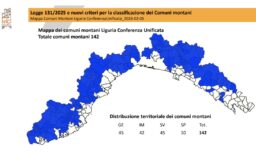Non è questione, o non solo, di avere un porto grande, che Genova non avrà mai, ma di essere un grande porto. Avere regole di ingaggio nel mondo delle banchine è fondamentale, come lo è il non volersi limitare a movimentare le merci, ma offrirsi come chi sa lavorare le merci prima di imbarcarle o appena dopo averle sbarcate.
Un esempio: Brema. Vediamone gli ultimi numeri. Al termine del primo bimestre 2017 il traffico nel porto anseatico è diminuito del -4,0%. I volumi di traffico in importazione e in esportazione sono diminuiti rispettivamente del -5,0% e del -3,0%. Nel totale le merci varie sono ammontate a 5,0 milioni di tonnellate (-4,5%), di cui 4,4 milioni di tonnellate di merci in container (-5,2%). Nel settore delle rinfuse il traffico si è asciugato dell’1,2%.
Percentuali statistiche, che parlano di un minor traffico. Ma non raccontano se i ricavi del porto tedesco siano diminuiti o cresciuti. Non dicono cosa è stato mosso e non raccontano quanti di quei milioni di tonnellate sono state meramente imbarcate e sbarcate o se, parte di esse, sono state anche lavorate nell’ambito portuale o limitrofo. Dunque il misurare il valore proprio della movimentazione delle merci di un porto è importante ai fini economici, come pure determinare il valore aggiunto associato alla movimentazione di una tonnellata di merce.
Alcuni porti del Nord utilizzano diverse metodologie per valutarne l’impatto sulla voce “utili”.
La prima di queste regole fu presentata dal porto di Amburgo nel 1976: “il valore aggiunto creato da una tonnellata di carico convenzionale è cinque volte più alto del valore aggiunto collegato alla movimentazione di una tonnellata di merci alla rinfusa e quindici volte più alto di una tonnellata di rinfuse liquide”.
A Brema, sei anni dopo, si decise per una regola basata sulle differenze dei costi di lavoro per la movimentazione del carico: “una tonnellata di general cargo equivale a tre tonnellate di rinfuse solide e a dodici di rinfuse liquide”.
Poi anche Rotterdam, Anversa costruirono dei parametri dove si calcolava la “convenienza” nei rapporti tra merci da imbarcare, sbarcare, quando non lavorare.
Quindi, bisogna fare molta attenzione quando si leggono le statistiche di traffico merceologico di un porto; i paragoni con altri porti divengono artificiosi e di propaganda. Però, aver riportato queste regole ci induce a una riflessione puntuale, valida per ogni porto: l’occupazione e il valore aggiunto per tonnellata aumentano se le merci subiscono trasformazioni logistiche o industriali all’interno dell’area portuale. Per esempio, il riempimento e lo svuotamento di container è fino a cinque volte più a “lavoro intensivo” che l’imbarco e lo sbarco da una nave, considerato “lavoro base”. Lo stoccaggio, la distribuzione e altre attività logistiche, nel quadro del subappalto industriale o della manifattura dopo nell’area portuale, generano livelli di occupazione discreti per un dato livello base di traffico nel porto. Per questo motivo, molti porti europei si sono evoluti da centri di puro transhipment verso sistemi complessi di funzioni chiave all’interno di un sistema logistico, in modo da far coesistere attività terminalistiche pure e attività logistiche.
Una Città Stato di lungo corso e una ex Repubblica Marinara. Brema e Genova hanno storia e consuetudini oggi distanti e del tutto a sé. Ma la struttura dello stato anseatico e il suo modo di intendere la portualità, guarda un po’, sono stati mutuati proprio da quelle di Genova che, quando era regina dei mari, insegnava a tutti come si organizzavano trasporti e commercio. Brema non ha cambiato abitudini e tradizioni da allora, e le conserva. E soprattutto le applica. Genova non se le ricorda più. Lascia che i propri insegnamenti li mettano in pratica gli altri. Troppo conservatorismo, anche per imparare dal proprio passato, che oggi saprebbe di troppo moderno e, forse, di “foresto”. Le città, oggi, hanno in comune alcune difficoltà economiche. La crisi iniziata nel 2008 ha infilzato Brema. A un centimetro dal cuore. Perché ne ha fermato il porto. Oggi le cose iniziano ad andare un po’ meglio. Nella relazione di fine 2009. Il Senatore all’economia e ai porti della città stato di Brema, Ralf Nagel, omologo dell’allora presidente dell’Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, per descrivere le previsioni dei traffici dello scalo anseatico, e in generale per la portualità tedesca, aveva usato la frase “c’è un tenue raggio di speranza” attendendosi per l’anno in corso un +3% rispetto all’anno passato, che aveva chiuso a -17% rispetto al 2008.
In Germania si cerca sempre – nel 2009 come nel 2016 – di vedere il bicchiere mezzo pieno. A Brema le positività, per quanto misuratissime, espresse dalla Autorità portuale rappresentano sempre un motivo di fiducia per gli operatori e di slancio per le imprese. E questo nonostante nel mondo, che a Brema è visto come mercato unico, circa 500 portacontainer siano state poste in disarmo e tutte le compagnie armatoriali stiano registrando forti perdite.
A Genova non funziona propriamente così. Si aspetta semplicemente che qualcuno, magari chi l’ha iniziata, faccia finire la crisi. E quello che dice il proprio presidente del Porto lo si lascia scivolare via.
Ma Brema non è solo porto. Sul fiume Wieser, dove la città giace, si cerca di andare comunque avanti. E ci si basa su un economia che si diversifica. Qui hanno stabilimenti grandi aziende multinazionali del comparto alimentare, come la Kellog’s e la Kraft. Vicine tra loro creano cioccolato (che in Italia non va moltissimo) tante imprese storiche come Feodora. La tecnologia avanzata si presenta con grandi nomi, anche se Genova, nel comparto, è decisamente più forte: c’è una sede della Airbus, ci sono i cervelli e la produzione della Rde, impresa di elettronica militare, una via di mezzo tra la vecchia Elsag e l’Oto Melara. Sempre a Brema si tenta di cavalcare l’auto e il suo mercato ormai striminzito, nei resti delle fabbriche di Daimler Chrisler, qui sorte proprio per sfruttare il concetto oggi caro anche in Italia del “chilometro zero” tra i luoghi di produzione e quelli di spedizione.