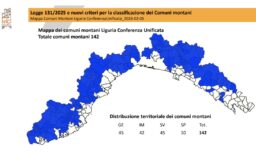“Il malessere turco” di Cengiz Aktar (Il Canneto Editore) è un saggio agile, preciso e documentato che ricerca nella storia millenaria della Turchia le cause del malessere attuale di un Paese dove oggi l’inflazione è alle stelle, l’ambiente devastato, la libertà politica repressa, sistema giudiziario, mondo accademico, amministrazione, esercito dominati dal potere politico, corrotto e inefficiente, un Paese che fa parte della Nato ed è scosso da violento antiamericanismo e tensioni con l’Unione europea, ed è impegnato in azioni armate in Siria, Iraq, Libia. Eppure fino a pochi anni fa la Turchia non solo cresceva dal punto di vista economico ma, almeno fino al 2004, era candidata a entrare nell’Unione europea e aveva realizzato diverse riforme perché la sua candidatura fosse accettata.
 Secondo Cengiz Aktar il malessere turco ha radici lontane. Nel suo tentativo di occidentalizzarsi completamente, da fine Ottocento e in modo più esasperato dopo la sconfitta e la disfatta definitiva dell’impero ottomano nella prima guerra mondiale “la Turchia ha cominciato il XX secolo con una costruzione forzata che ha visto milioni di non musulmani esclusi dalla definizione e dall’appartenenza a questa nazione che cerca di inventarsi. La stessa nazione era tenuta unita dall’Islam per la mancanza di qualsiasi altro denominatore comune, lingua inclusa. Ne seguirono i genocidi degli Armeni, dei Siriaci, dei Greci, del Ponto Eusino, così come la negazione di qualsiasi identità etnica diversa da quella turca, come per esempio l’identità curda”. (…) “Alla fine il sincretismo e il cosmopolitismo ottomano che hanno permeato l’intera cultura fino all’avvento della nazione, concetto evidentemente occidentale, si sono disgregati per dare spazio a una unicità nazionale, etnica, religiosa, linguistica e storica debilitante e al contempo insicura proprio perché artificiale. La nazione monocromatica sembra avere la meglio sul ricco cosmopolitismo ottomano. Il rovescio della medaglia del passaggio dall’Ottomano al Turco appare in tutta evidenza: nel voler troppo occidentalizzarsi la Turchia ha perduto la sua anima”. (pag. 15-16).
Secondo Cengiz Aktar il malessere turco ha radici lontane. Nel suo tentativo di occidentalizzarsi completamente, da fine Ottocento e in modo più esasperato dopo la sconfitta e la disfatta definitiva dell’impero ottomano nella prima guerra mondiale “la Turchia ha cominciato il XX secolo con una costruzione forzata che ha visto milioni di non musulmani esclusi dalla definizione e dall’appartenenza a questa nazione che cerca di inventarsi. La stessa nazione era tenuta unita dall’Islam per la mancanza di qualsiasi altro denominatore comune, lingua inclusa. Ne seguirono i genocidi degli Armeni, dei Siriaci, dei Greci, del Ponto Eusino, così come la negazione di qualsiasi identità etnica diversa da quella turca, come per esempio l’identità curda”. (…) “Alla fine il sincretismo e il cosmopolitismo ottomano che hanno permeato l’intera cultura fino all’avvento della nazione, concetto evidentemente occidentale, si sono disgregati per dare spazio a una unicità nazionale, etnica, religiosa, linguistica e storica debilitante e al contempo insicura proprio perché artificiale. La nazione monocromatica sembra avere la meglio sul ricco cosmopolitismo ottomano. Il rovescio della medaglia del passaggio dall’Ottomano al Turco appare in tutta evidenza: nel voler troppo occidentalizzarsi la Turchia ha perduto la sua anima”. (pag. 15-16).
Analisi lucida e convincente. Lascia perplessi dove indica nel mancato ingresso della Turchia nell’Unione europea la causa del riflusso autoritario del Paese. La candidatura della Turchia iniziata nel 1959, osserva Cengiz Aktar, aveva prodotto risultati tangibili sul piano politico, sociale ed economico, riforme ispirate da standard, norme, valori e principi europei che stavano trasformando il Paese. Trasformazione bloccata dal disfacimento della relazione con l’Europa. A partire dalla fine del 2005 il processo di adesione della Turchia ha perso slancio e la Turchia è rapidamente sprofondata in una dinamica negativa che può essere descritta come deoccidentalizzazione. A bloccare questo processo di adesione, osserva l’autore, sono stati la Francia guidata da Nicolas Sarkozy, i democristiani di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi. Si potrebbe aggiungere la Grecia, che verso la Turchia nutre sentimenti di ostilità e timore simili a quelli delle repubbliche baltiche, di Polonia e Ucraina verso la Russia.
“Purtroppo – si legge nel saggio – il volontarismo filo-europeo e riformista iniziato nel 1999 (…) non è stato correttamente valutato né preso in considerazione in tempo dall’altra parte in causa, e cioè dall’Europa (…) se questa fosse riuscita a vincere le sue ancestrali riserve verso una Turchia europea (…) la Turchia non si troverebbe dove è oggi, sotto il giogo di un islam politico fuori controllo” (pag. 50).
Ma siamo sicuri che sarebbe bastato l’ingresso nell’Unione europea per impedire la deriva islamico-autoritaria che ha strappato la Turchia dall’Occidente? L’Ue da anni ha contrasti in materia del rispetto dello Stato di diritto con Polonia e Ungheria, Paesi che, al contrario della Turchia, da sempre fanno parte dell’Europa. Non dell’Unione europea, dell’Europa. Cosa succederebbe se nell’Unione entrasse uno Stato che ha come atto fondativo la pulizia etnico-religiosa e dove “A cominciare dal 2013 il ritorno dell’islam politico, che era stato eliminato dal centro nevralgico dello Stato all’inizio del XIX secolo, è sempre più apparso come una rivincita sui due secoli di occidentalizzazione (pag. 57-58)”? E dove intolleranza e aggressività non sono un velo imposto dallo Stato sulla società: nel caso dell’attacco militare contro le aree popolate dai curdi nel nord della Siria “l’atteggiamento nazionalistico favorevole alla guerra mescolata a simboli religiosi si addice alla stragrande maggioranza dell’opinione pubblica turca, che porta cicatrici di genocidi, pogrom e saccheggi secolari contro i non musulmani, i non sunniti e i non turchi maggioranza”. (pag. 68). Un Paese di 85 milioni di abitanti dove “Il regime gode di un grado di sostegno popolare senza pari nella storia delle repubblica” (pag. 77) e l’indottrinamento dei giovani “è intriso di un sentimento di appartenenza religiosa all’islam sunnita, combinato con un nazionalismo sfrenato e conquistatore, profondamente radicato nella popolazione” (pag. 79).
Secondo Cengiz Aktar la nuova Turchia rappresenta “un enigma per l’Europa dopo il fallimento della sua candidatura all’Unione europea” (pag. 55)”. Ma se oggi è un enigma prima era un’incognita, che comportava un esperimento molto pericoloso.