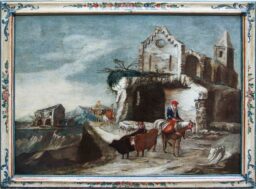L’approvazione avvenuta pochi giorni fa del bilancio 2020 di Fincantieri spa fa ha evidenziato una perdita netta per 245 milioni per il grande gruppo italiano della cantieristica, pari a un roe negativo del 26,8%. Questo risultato negativo fa seguito al già deludente bilancio 2019, che già evidenziava una perdita che sfiorava i 150 milioni per l’esercizio precedente.
Secondo il management dell’azienda, per comprendere appieno tale risultato è indispensabile non dimenticare il grande impatto della pandemia Covid-19 sulla produzione dei cantieri, la quale è stata del 20% inferiori alle attese e ha influito negativamente sul risultato di esercizio di quasi 200 milioni.
La relazione della gestione non ha mancato però di evidenziare svariati punti di forza del gruppo il quale, secondo le previsioni, dovrebbe iniziare a produrre utili per i suoi shareholder già dall’anno in corso. Il management aziendale ha evidenziato come l’ebitda del gruppo rimanga stabilmente positivo (314 milioni), consentendo di far fronte alle obbligazioni più impellenti e di onorare gli interessi sul proprio debito, che nel corso del 2020 ha superato il miliardo di euro. Le linee di credito aziendali sono altresì ancora sfruttabili, con la possibilità di estendere di ulteriori 2,3 miliardi l’indebitamento per far fronte alle urgenze più impellenti. Anche la situazione del portafoglio ordini del gruppo appare estremamente confortevole, con oltre 116 nuove unità commissionate per un controvalore superiore ai 35 miliardi, con tempi di consegna che arrivano fino alla fine del decennio appena iniziato. In tal senso, il fatto che non si siano verificate cancellazioni di ordini, specie nel settore cruise, è di per sé estremamente positivo, indicando un’alta fiducia negli operatori per le prospettive di un settore oramai completamente impossibilitato nelle proprie attività da oltre un anno.
Notizie positive giungono anche dal settore destinato alle costruzioni di naviglio militare, con ordini provenienti sia dall’Italia (due Fremm e due unità sommergibili) sia dagli Usa (10 potenziali unità unmanned classe FFG(X)). Proprio il settore militare sta sempre prendendo più piede come pilastro di sostegno fondamentale per il gruppo, con ordini in crescita continua da oltre un lustro, sulla scia del trend di incremento globale delle spese militari negli ultimi anni. Degno di nota è stato il varo della nuova e moderna unità portaelicotteri “Trieste” per la Marina Militare Italiana (“Trieste”), una delle maggiori commesse di sempre fatte dal Ministero della Difesa (oltre 1,1 miliardo di scorso valore).
Direttamente, ma non soltanto, collegato al settore militare è l’ambito della ricerca e sviluppo in cui Fincantieri si conferma tra i più all’avanguardia nel mondo. Negli ultimi anni, sono stati fatti grandi investimenti presso i siti produttivi norvegesi e statunitensi nell’ambito della realizzazione di diverse unità unmanned da destinare al servizio sia civile che militare (tra cui le sopra menzionate unità per la Marina Usa).
Accanto alle prospettive future in via di consolidamento non sono tuttavia da dimenticarsi i punti di debolezza che, oltre all’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, hanno zavorrato i conti del gruppo.
La prima considerazione riguarda la possibilità che la struttura organizzativa del gruppo non sia ottimale, ma che risenta di un’elevata rigidità e dispersione dei suoi innumerevoli siti produttivi (20 in totale, di cui 9 in Italia). Operare con un elevato numero di cantieri sparsi per l’Europa e il Nord America porta indubbiamente un vantaggio per quanto riguarda la capacità produttiva, ma può portare svantaggi sotto altri punti di vista. Un grande numero di ordini per una struttura simile risulta vantaggiosa perché consente uno smistamento delle commesse tra più siti, ma, nel caso in cui gli ordini calassero oppure, come in questo caso, il volume della produzione fosse di molto inferiore al previsto, il breakeven point del gruppo avrebbe più alte possibilità di non essere raggiunto, portando a un passivo di bilancio. Ne è una prova il bassissimo margine di contribuzione della produzione (ebitda margin del 6,1%), che dimostra una redditività del gruppo estremamente fragile anche in un momento in cui non vi è una problematica inerente a un basso numero di ordinativi. Cosa potrebbe succedere nel caso in cui gli ordinativi scendessero è facilmente intuibile.
Con questa valutazione, la ritirata del gruppo dalla possibilità di rilevare una ulteriore unità produttiva d’eccezione, ovvero i cantieri navali di Saint Nazaire, potrebbe non essere stata una grande sconfitta per il nostro colosso nazionale. Ricordiamo che l’accordo per rilevare questo importantissimo polo della cantieristica a livello europeo (in grado di ospitare la costruzione di mega-navi da crociera) avvenne ben tre anni fa, quando la minaccia del Covid-19 era lontana, e il settore croceristico stava vivendo un periodo di grande espansione. All’epoca, l’acquisizione di questo grande cantiere, famoso per la costruzione durante gli anni Trenta del prestigioso transatlantico “Normandie”, vincitore del Nastro Azzurro, avrebbe consentito al gruppo la possibilità di incrementare notevolmente la propria quota di mercato, avendo a disposizione di uno dei cantieri navali più importanti d’Europa e del mondo. In realtà, questa operazione ha sempre nascosto gravi incognite.
La gestione del mega-cantiere alle foci della Loira non è mai stata facile per i suoi proprietari, tra cui si sono alternate diverse realtà francesi e internazionali. Tutti si sono dovuti arrendere al fatto che gestire un sito così imponente è di per sé difficile in momenti di espansione del settore, ma è addirittura impossibile in fase di contrazione economica. Un cantiere dimensionato alla costruzione di mega-transatlantici in termini di attrezzature e personale non può permettersi la costruzione di naviglio leggero poiché, in questo caso, il volume della produzione non sarebbe in grado di coprire tutti i costi fissi della struttura.
L’avvento della pandemia Covid e il conseguente stop forzato al settore croceristico hanno addensato ancor di più le nubi sul destino di una realtà industriale come il Saint Nazaire. E se il gruppo navalmeccanico italiano di per sé non ha riscontrato revoche di ordinativi come già abbiamo affermato, difficilmente ne otterrà altri a breve, men che meno per unità così imponenti da poter occupare appieno le maestranze del cantiere francese. Sul lungo periodo, insomma, l’avversione dello Stato francese, storicamente gelosissimo dei propri asset, potrebbe non essere stata una grande sconfitta per Fincantieri, in un momento in cui l’incertezza sul futuro del settore a causa Covid pone a rischio le condizioni per assicurare la produttività dello stabilimento.
Alcuni sentori di una possibile contrazione degli ordini si sono già avuti confrontando il volume degli ordinativi fatto al gruppo durante il 2020 contro quelli fatti nel corso dell’esercizio precedente. Se nel 2019 Fincantieri si era aggiudicato un volume di ordinativi di 8,7 miliardi, nel 2020 i nuovi ordini si sono dimezzati a 4,4 miliardi, prevalentemente da parte del settore militare. Questa tendenza, se venisse consolidata negli anni a venire, porrebbe il gruppo in una situazione difficilmente sostenibile dal punto di vista economico, trovandosi potenzialmente un giorno nella condizione di avere alcune delle sue innumerevoli unità produttive sottoutilizzate o addirittura inutilizzate. Non a caso, per rafforzare la posizione del gruppo, nel corso del 2021 sarà richiesto un nuovo aumento di capitale ai soci.
Come per ogni realtà complessa, è estremamente difficile fare una valutazione globale sullo stato di salute del nostro campione nazionale delle costruzioni navali. Come abbiamo visto, vi sono fattori che lasciano sperare in un futuro luminoso del gruppo e fattori che ne ipotecano sensibilmente la sostenibilità economica. Sarà sicuramente interessante osservare come, e soprattutto se, Fincantieri sarà coinvolta nel processo di rinnovamento dell’economia nazionale che il Recovery Fund si propone e sarà altresì interessante capire se in futuro si assisterà a una razionalizzazione delle diverse unità produttive.