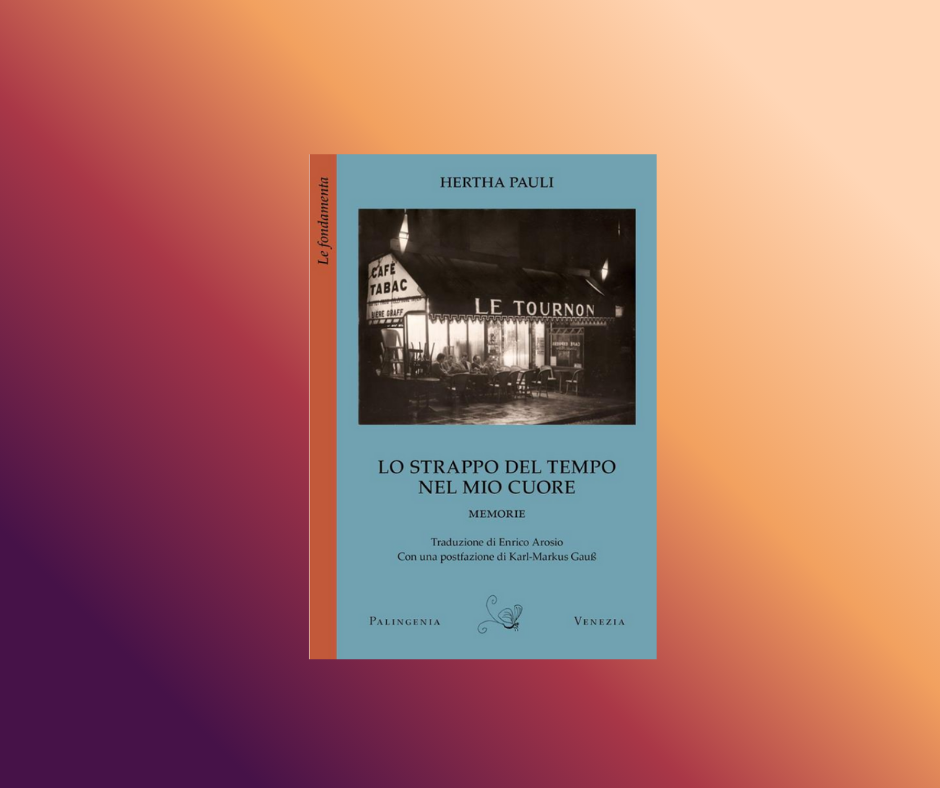«Tutta l’Europa, la piccola Europa, si ammanta di grossi, silenziosi fiocchi di neve (…) La neve attutisce il rumore dei passi e delle voci. Attutisce gli urti. Ha un sembiante di pace. Eppure alcuni, qua e là sono preoccupati, fremono impercettibilmente come se … Come se domani, scioltasi la neve e tornata nera e brulicante di vita la terra, dovessero correre verso frontiere di nuovo visibili. Ma questo non mi riguarda. Io sono partito con uno scopo più modesto, quello di vedere il volto dell’Europa di oggi. C’è stata un’Europa di prima del 1914, poi un’Europa squarciata dalle trincee e infine un’Europa del dopoguerra. Ma forse è ancora un’altra Europa questa Europa del 1933 che sonnecchia sotto la neve e che, come chi dorme male, è scossa da bruschi e terrificanti sussulti».
Così Georges Simenon presenta l’affresco dell’Europa nel 1933 che ci offre nei suoi reportage dal Baltico ai Balcani, dalla Germania hitleriana all’Unione Sovietica fatti per conto della rivista Voilà, fondata da Gaston Gallimard nel 1931 e dedicata al reportage d’autore.
Alcuni di questi reportage sono stati pubblicati da Adelphi con il titolo “Europa 33”. Il volume contiene quattro capitoli: Europa 33 (Europe 33), I grandi alberghi europei (Les grands palaces européens), Una visita a Trockij (Chez Trotsky), Popoli che hanno fame (Peuples qui ont faim) e una postfazione di Matteo Codignola. Gli articoli sono corredati da foto scattate dallo stesso autore o dalla moglie. A noi non sembra che aggiungano molto, quanto a informazione ed espressività, agli scritti. Forse perché, a differenza che in altri servizi del periodico, non sono state scattate da un fotografo professionista, forse sono penalizzate dal formato o risultano poco luminose perché troppo piccole e di scarsa definizione. O forse, semplicemente perché il testo scritto è così espressivo che non ha bisogno di supporti.
Quattro articoli straordinari, scritti con lo stesso stile dei romanzi della serie di Maigret e anche di quella delle opere “alte” (“les romans durs”), se vogliamo mantenere una classificazione artificiosa avallata peraltro dallo stesso Simenon: poche righe asciutte, osservazioni semplici, dirette, alternate a virgolettati altrettanto semplici, conclusi in genere con punti esclamativi. Uno stile straordinario, semplice solo all’apparenza. C’è chi ha misurato la lunghezza delle frasi degli scritti di Simenon: François Richaudeau ha concluso che la frase di lunghezza media dello scrittore belga è di 12,6 parole esclusi i dialoghi (Communication & Langages, année 1982, 53 pp. 11-32, “Simenon: une écriture pas si simple qu’on le penserait). Notazione interessante che comunque non spiega il mistero di come una scrittura così lineare renda in tanti romanzi e racconti la complessità dell’animo umano.
Qui non è l’animo delle singole persone a essere messo a nudo ma l’Europa tra le due guerre, l’Europa «che sonnecchia sotto la neve e che, come chi dorme male, è scossa da bruschi e terrificanti sussulti». Un affresco potente, realistico fino alla brutalità eppure profetico, fatto di immagini e brevi conversazioni.
Alcune pagine sono dedicate ai viaggi di Simenon nel Belgio, in Polonia, Romania, Ungheria, Cecoslovacchia, Lituania, Germania, Mar Nero, Unione Sovietica.
Il servizio dedicato ai grandi alberghi europei ci rappresenta con lieve ironia i grandi alberghi di lusso in cui soggiornano ministri, miliardari e avventurieri, principesse vere e false, sgualdrine e sgualdrinelle, e la principale preoccupazione dei gestori come dei portieri e dei camerieri in caso di delitti o suicidi nelle camere dell’albergo è di evitare gli scandali. Si tratta di temi che verranno ripresi e sviluppati in ogni racconto di Maigret ambientato in un grande albergo.
Il racconto della visita in un dormitorio di poveri a Varsavia è un pezzo di grande letteratura, dove l’asciuttezza dello stile non nasconde ma mette in luce la solidarietà dell’autore e trascina il lettore: «Se il mio racconto vi sembrerà angosciante consideratelo un brutto sogno», avverte Simenon prima di portarci in un labirinto di corridoi dove gli uomini non hanno più la forza di lottare per vivere. «Nessuno ride. Nessuno parla. Si vedono solo sguardi che non sono neanche minacciosi, ma sono vuoti e gelidi. È peggio!».
Nelle pagine dedicate alla Germania viene resa l’atmosfera inquietante – che ricorda l’Addio a Berlino di Christopher Isherwood – della fine della repubblica di Weimar, con «il nudismo, la speculazione, il freudismo, i ragazzini e le ragazzine, lo squilibrio e l’irrequietezza, lo sport, l’eroina, la cocaina e compagnia bella». E un gustoso accenno all’incendio del Reichstag, quando Hitler, alla ricerca di un pretesto per «galvanizzare i suoi sostenitori» e «mettere a tacere i comunisti prima delle elezioni», ha puntato sul Reichstag.
«Mancava poco alle elezioni, era sabato – si legge nell’articolo – ho telegrafato la notizia a Parigi, al giornale della sera. Non hanno avuto il coraggio di pubblicarla. Il mercoledì sera il Reichstag bruciava e nessun tedesco dava il minimo segno di stupore!
«Sfido io! E immaginate l’ingenuità dei corrispondenti esteri, che riempivano colonne cercando la “verità”!
«Hitler ha trionfato e quegli stessi corrispondenti sono rimasti stupefatti:
«È il fantoccio di Papen!
«È il fantoccio del Kronprinz!
«È il fantoccio di Hugenberg!
«È un burattino!
«È il nuovo Sigfrido!»
Secondo Simenon «i tedeschi, che Hitler rimetterà a nuovo da cima a fondo», «torneranno a essere quelli che ho visto irrompere nelle strade, sicuri di sé, fiduciosi nel loro destino e nei loro caporali, nel 1914». Per alcuni si tratterebbe di un elogio, o quanto meno di un riconoscimento positivo, del regime hitleriano. A noi sembra piuttosto una previsione, formulata nello stile asciutto e a-ideologico dell’autore, della guerra che presto devasterà l’Europa. Previsione azzeccata, peraltro non dal solo Simenon.
Una gioiellino, e uno scoop, è l’intervista con Trockij, che era molto parco con gli incontri con i giornalisti. Simenon lo va a trovare nella sua villa sull’isola di Prinkipo, vicino Costantinopoli, in cui il vecchio rivoluzionario trascorreva le sue giornate leggendo, scrivendo, studiando. E durante l’incontro, mentre prevede uno spostamento degli equilibri internazionali dall’Europa agli Stati Uniti, afferma: «In una prospettiva non di mesi ma di anni – non certo però di decenni – ritengo assolutamente inevitabile lo scoppio di una guerra scatenata dalla Germania fascista».
Forse dal punto di vista giornalistico i pezzi più notevoli, per grado di comprensione della realtà, sono quelli che riguardano i rapporti economici tra paesi europei e quelli che cercano di penetrare nella realtà per molti misteriosa dell’Unione Sovietica.
Siamo agli inizi degli anni Trenta, quando nella pubblicistica e in politica hanno successo teorie per cui i paesi si arricchiscono con l’estensione territoriale e l’autonomia produttiva. L’Italia e il Giappone vogliono il loro impero, la Germania ritiene essenziale per la propria sopravvivenza conquistare spazio a Est, il Lebensraum, e tutti vogliono produrre ed esportare. Meno di vent’anni dopo l’Italia e il Giappone avranno perso il loro impero, la Germania un terzo del suo territorio, e diventeranno tra i paesi più ricchi del mondo, dopo gli Usa, e i governi e progressivamente le popolazioni di tutto il mondo conosceranno i vantaggi del libero scambio e della specializzazione produttiva. Nei reportage di Simenon è costante ed esplicita, anche se priva di argomentazioni teoriche, l’ironia verso le pretese dei Governi di imporre sacrifici ai loro popolo nel nome di una futura sovranità industriale. («Ora tutti vogliono fabbricare i loro cannoni e le loro macchine da cucire. Pretendono di educarsi da soli e parlano di rinascita nazionale, il mondo ne è pieno, di rinascite nazionali che cozzano tra loro con un frastuono più o meno minaccioso»). Del resto, ancora oggi, da noi, si parla di acciaio italiano, di compagnia di bandiera…
Quanto alla realtà sovietica, per valutare il lavoro di Simenon conviene tenere presente che i suoi articoli sono usciti prima del viaggio in Urss di André Gide e del suo famoso libro-denuncia “Retour de l’Urss” (1936) sul fallimento del socialismo sovietico. Obiettivamente, all’inizio degli anni Trenta, l’Urss per molti era ancora un mistero. Ma comunque, anche dopo la denuncia di Gide, e persino dopo la denuncia degli orrori staliniani da parte di Kruscev nel 1956 l’Unione Sovietica è stata a lungo meta di pellegrinaggi devoti di scrittori e giornalisti che tornavano incantati da un paese in cui gran parte della popolazione viveva nella fame e nel terrore.
 Sarebbe bene accompagnare la lettura di “Europa 1933” con quella di “Pellegrini politici- Intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba” di Paul Hollander (Società editrice il Mulino), dove si documentano le sciocchezze scritte o riferite dagli ospiti occidentali (non solo scrittori e giornalisti, scrive Hollander che «se si dovesse fare una classifica dei vari gruppi di turisti politici in base al loro grado di credulità, probabilmente le celebrità hollywoodiane e le persone legate alle Chiese si spartirebbero il primo posto alla pari») facilmente ingannati nei vari Paesi che si sono riproposti come paradisi in terra, Unione Sovietica, Cina, Cuba, Nicaragua…
Sarebbe bene accompagnare la lettura di “Europa 1933” con quella di “Pellegrini politici- Intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba” di Paul Hollander (Società editrice il Mulino), dove si documentano le sciocchezze scritte o riferite dagli ospiti occidentali (non solo scrittori e giornalisti, scrive Hollander che «se si dovesse fare una classifica dei vari gruppi di turisti politici in base al loro grado di credulità, probabilmente le celebrità hollywoodiane e le persone legate alle Chiese si spartirebbero il primo posto alla pari») facilmente ingannati nei vari Paesi che si sono riproposti come paradisi in terra, Unione Sovietica, Cina, Cuba, Nicaragua…
Simenon non si è lasciato fuorviare da sentimenti o risentimenti personali o illusioni ideologiche. E neppure dalle tecniche di accoglienza condizionante adottate nei suoi confronti come nei confronti degli altri visitatori: controllo costante da parte di guide che sono anche spie, tentativi di impedirgli contatti con la popolazione. Lo scrittore-giornalista sfugge ai controlli, interroga le persone e, soprattutto, tiene gli occhi bene aperti. Odessa e Batum ci appaiono così località da incubo, dove fabbriche e scuole modello, in un clima di sospetto e di paura, non possono nascondere, a chi vuole vedere, negozi chiusi e gente affamata. «Ma ora capisco – scrive Simenon – quella specie di cordone sanitario teso intorno alla Russia, il divieto di fare entrare giornali e libri stranieri, e perfino la sorveglianza di cui sono oggetto. Certo, preferiscono che io non veda determinate cose. Ma quello che soprattutto non deve accadere è che io ne racconti delle altre».
Quello che il visitatore non doveva vedere, e che Simenon aveva scoperto semplicemente insistendo nel voler capire, senza accesso a fonti privilegiate, era l’Holodomor, la strage degli innocenti uccisi dalla fame a causa della carestia volutamente provocata dal regime sovietico che colpì l’Ucraina tra il 1932 e il 1933 causando milioni di morti. In tutta l’Urss circa cinque milioni di persone – deliberatamente private dei mezzi di sostentamento – morirono di fame. Di questi, secondo le stime, quattro milioni erano ucraini. Kulaki, cioè contadini possidenti, ex borghesi e nobili, in tutta l’Unione Sovietica, non potevano lavorare e di conseguenza ricevere le tessere per ottenere i viveri. Condannati a morte. Potevano sopravvivere soltanto finché avevano qualcosa da vendere dei beni di una volta: «Nessuno li guarda. La folla li ignora. Vanno e vengono. Dormono nel fango o nella polvere. Si spulciano a vicenda. Vivono in venti in una camera o dormono sui marciapiedi… Vivono dove possono, come possono. C’è lavoro per tutti ma non per quelli che non hanno capito niente né della rivoluzione né dei principi della standardizzazione. Nel mondo nuovo non c’è bisogno di questi selvaggi. Allora a che pro nutrirli?» .
«Che ci fa qui questa bambina» chiede Simenon alla sua guida indicando una piccola di cinque anni che dorme per terra in una strada di Batum.
«Dorme».
«Lo vedo. Ma non ha i genitori?»
«Evidentemente no».
«Morti?»
«O persi…Le persone che viaggiano sempre si perdono, a volte a bella posta…»
«E questa piccina che farà?»
«Niente di buono… Sono sicura che ruba e si lascia guardare dagli uomini e dai suoi amichetti…»
«Sono tanti i bambini come lei?»
«Ce ne sono dappertutto… Dormono dove possono… Mangiano quello che trovano…Sono mele marce… Ch cosa ci si può aspettare dai figli dei kulaki che vagano da una regione all’altra nella speranza di trovare da mangiare?».
Pagine splendide e terribili. Più tardi, nel 1954, quando le cose sarebbero già dovute apparire più chiare, Jean Paul Sartre, di ritorno dall’Urss, dichiarerà di avere potuto avere con il popolo russo un tipo di contatto «largo, aperto, facile», poiché il cittadino sovietico disponeva di «un’assoluta libertà critica» e la società sovietica era strutturata in modo tale che la vita di ogni uomo avesse uno scorrimento lineare e felice per l’intera esistenza». In Italia l’Unità e l’Avanti pubblicheranno montagne di articoli elogiativi delle conquiste sovietiche; Sandro Pertini, uno dei padri della democrazia italiana, nel 1950 scriveva sull’Avanti di guardare, al ritorno dalla Russia, con rinnovata speranza «alle rosse stelle che brillano sul Cremlino». Ma non saranno solo l’Unità e l’Avanti a elogiare il nuovo paradiso sovietico, anche scrittori e giornali “borghesi” non faranno mancare sciocchezze e insulsaggini. E, poi, delusi dall’Urss, si rifugeranno (idealmente, s’intende) a Cuba, in Cina, in Nicaragua …
Oggi i paradisi ideali scarseggiano, l’alternativa ai regimi liberaldemocratici è offerta solo dagli estremismi islamici. Un po’ troppo, anche per i più stupidi tra i nostri “opinion maker”, più o meno acculturati e/o tatuati. Per quanto, di recente, si sia sentito esprimere una netta preferenza per Hamas rispetto a Israele da parte di chi rivendica la liberazione della donna dall’oppressione maschile. Forse il libro di Hollander meriterebbe un seguito.