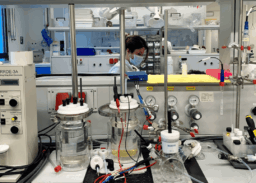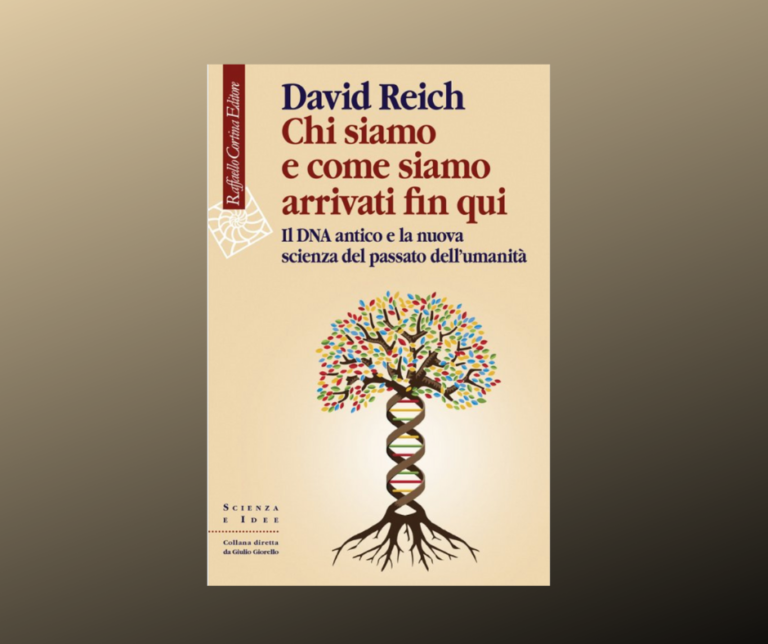“Chi siamo e come siamo arrivati qui -Il dna antico e la nuova scienza del passato dell’umanità” di David Reich (Raffaele Cortina Editore) è stato ispirato da Luca Cavalli Sforza, il fondatore degli studi genetici sul passato dell’uomo. David Reich è stato suo studente, si sente parte della sua scuola. Professore di Genetica alla Medical School di Harvard, è uno dei pionieri a livello planetario dell’analisi del Dna umano antico. Nel 2015 Nature l’ha inserito tra le dieci persone più influenti nel panorama delle scienze per il suo contributo alla trasformazione dell’analisi del Dna antico “da ricerca di nicchia a processo su scala industriale”.
Cavalli Sforza nel 1994 pubblicò “Storia e geografia dei geni umani”, il risultato di anni di studi in cui lo scienziato aveva cercato di ricostruire le grandi migrazioni del passato basandosi sulle differenze genetiche tra le popolazioni odierne. Con le sue ricerche la genetica si affiancava all’archeologia, alla paleoantropologia e alla linguistica, alleanza decisiva per conoscere il nostro passato. Però, se è vero che l’attuale genetica delle popolazioni rispecchia alcuni grandi eventi del passato, è anche vero che non può recuperare i dettagli degli eventi antichi, la gente si è mescolata in continuazione, le persone che vivono in un dato posto non discendono quasi mai esclusivamente da coloro che vivevano nello stesso posto nel lontano passato. Lo sappiamo grazie allo studio del Dna antico, possibile da pochi anni. Cavalli Sforza con gli strumenti tecnico-scientifici dell’epoca non poteva analizzare il Dna antico ed era in grado di studiare quello delle popolazioni attuali in misura limitatissima.
La svolta decisiva si è avuta nel primo ventennio del Duemila, quando studiosi come lo stesso Reich, Svante Pääbo e altri del Max Planck di Lipsia hanno hanno messo a punto gli strumenti in grado di farci conoscere la genetica dell’antico Dna. Svante Pääbo ha sequenziato il genoma del neandertal, nel 2009-2010. Da allora è una rivoluzione continua, e oggi, osserva Reich, stiamo sfornando informazioni a una velocità tale che lo sfasamento temporale tra la produzione dei dati e la loro pubblicazione è più lungo del tempo che ci vuole a raddoppiare i dati dell’intero settore di studi.
Reich fa quindi il punto su quanto si sapeva al momento in cui ha scritto la sua opera, pubblicata la prima volta nel 2018: in quel momento non esisteva un libro scritto da un genetista ancora in attività che illustrasse l’impatto della nuova scienza. Se ne sentiva il bisogno. Archeologi, linguisti, paleoantropologi non hanno studiato genetica e i genetisti non sono preparati anche in archeologia, antropologia e linguistica. Le quattro discipline devono collaborare e opere come quella di Reich possono facilitare l’incontro, e fare luce sul passato anche per il lettore che non ha una preparazione formale in nessuna di questi ambiti ma è disposto a impegnarsi per capire.
Che cosa ci fa sapere il libro di David Reich? Molto, sulle prime vicende dell’homo sapiens, sulle migrazioni dei popoli, tra l’altro su questioni molto dibattute come l’origine dei cosiddetti indoeuropei, sulle popolazioni dell’india e sui nativi americani.
Ma le scoperte che possono sorprenderci, minando convinzioni sedimentate nel tempo, sono due: l‘ibridazione tra homo sapiens e neandertal e altri non sapiens e l’esistenza di differenze genetiche sostanziali tra le attuali popolazioni umane, differenze che peraltro non conosciamo ancora ma possono riguardare non solo l’aspetto fisico ma, questione potenzialmente esplosiva, anche attitudini cognitive e comportamentali.
Per chiarire i rapporti tra sapiens e altri tipi umani Reich ne ricostruisce la storia.
I primissimi scheletri umani con tratti “anatomicamente moderni” datano da 200 mila a 300 mila anni e provengono tutti dall’Africa. Fuori dall’Africa e dal Medio Oriente non ci sono prove convincenti di umani moderni in senso anatomico più antichi di 100 mila anni. Questo farebbe pensare che l’uomo moderno sia rimasto in Africa 100-200 mila anni e poi una parte di esso abbia lasciato il continente per diffondersi in Europa, in Asia, nelle Americhe e nel Pacifico
I neandertaliani si sono evoluti in Europa circa 400 mila anni fa, dove si sono estinti 41 mila-39 mila anni fa, nell’arco di pochi millenni dall’arrivo degli umani moderni. Gli utensili in pietra di questi ultimi indicano un grosso progresso tecnico avvenuto proprio in quegli anni, circa 50 mila anni fa. Quindi una popolazione umana anatomicamente moderna che possedeva una nuova cultura sofisticata avrebbe rimpiazzato coloro che vivevano in precedenza in Europa e Asia.
Reich e i suoi colleghi nel 2016 hanno confrontato il Dna delle popolazioni di tutto il mondo con quello dei cacciatori raccoglitori del popolo San che abita nella punta meridionale dell’Africa e che discende da quel gruppo di homo sapiens che non hanno lasciato l’Africa. Lo studio ha appurato che la separazione era iniziata circa 200 mila anni fa ed era quasi del tutto completata già oltre 100 mila anni fa, come dimostra la densità uniformemente alta delle mutazioni che separano i genomi san dai non san. Le maggiori differenze sono tra chi ha lasciato l’Africa e chi vi è rimasto.
Chi ha lasciato l’Africa ha incontrato esseri simili a lui ma che non erano homo sapiens.
Fino a circa 40 mila anni fa il mondo era abitato da vari gruppi umani arcaici che erano diversi da noi nel fisico ma condividevano tante delle nostre capacità. Per quanto riguarda i neandertaliani sappiamo che oltre 100 mila anni fa erano sofisticati dal punto di vista comportamentale quanto i nostri diretti antenati, “producevano utensili in pietra utilizzando una tecnica che esige capacità cognitive e destrezza, curavano i malati e gli anziani, concepivano simboli come rivelano i gioielli realizzati con artigli d’aquila 130 mila anni fa e i cerchi di pietra costruiti dentro grotte intorno a 180 mila anni fa”. Quali rapporti ci sono stati tra noi e loro? Le due popolazioni si ibridarono? L’archeologia non può rispondere a questa domanda, la genetica sì.
Grazie ad alcuni scheletri, di cui è stato possibile analizzare il Dna, abbiamo la prova dell’ibridazione.
Svante Pääbo ha sequenziato l’intero genoma dei neandertal. Che sono vicini a europei, est asiatici e abitanti della Nuova Guinea più che alle popolazioni dell’Africa occidentale e ai san. Come ci si aspettava, visto che l’incontro è avvenuto in Europa e in Asia. Genomi neandertal presenti nei sapiens non africani attuali sono dell’1,5 – 2,1%. La mescolanza tra sapiens e neandertaliani è avvenuta soprattutto in Medio Oriente ma anche in Europa. Il contributo neandertaliano al Dna delle persone che vivono oggi potrebbe essere ridotto anche a causa dalla bassa fertilità degli ibridi. I due tipi umani quando si incontrarono erano all’estremo limite della compatibilità biologica. Comunque oggi sappiamo che in Europa e in Asia vissero popolazioni ibride di neandertaliani/umani moderni e che alcune sopravvissero e diedero origine alle moltitudini oggi in vita.
L’ibridazione non è avvenuta solo tra sapiens e neandertaliani.
Nel 2008 alcuni archeologi russi disseppellirono un osso del mignolo nella grotta di Denisova in Siberia. Dal suo genoma risulta che i neandertaliani e i denisoviani erano molto più imparentati reciprocamente di quanto gli uni e gli altri fossero imparentati con gli umani moderni. La separazione tra le popolazioni ancestrali neandertal e denisoviani era avvenuta tra i 470 mila e i 380 mila anni fa e la separazione tra le popolazioni comuni di entrambi questi gruppi arcaici dagli umani moderni era avvenuta tra i 770 mila e i 550 mila anni fa. Nonostante la lontananza della separazione, denisoviani e umani moderni erano ancora interfertili, perché dalla genetica risulta che gli antenati dei neoguineani si sono incrociati con i denisoviani, tra i 59 mila i 44 mila anni fa. Circa il 3-6% dell’ascendenza neoguineaiana deriva dai denisoviani. L’ibridazione deve essere avvenuta nella Cina meridionale o in Indocina.
L’esplorazione delle le differenze biologiche tra le popolazioni umane attuali suscita, comprensibilmente, preoccupazioni. Nei decenni scorsi biologi e antropologi si sono trovati d’accordo nel sostenere che le “razze” non esistono, sono costruzioni culturali, quando non politiche, prive di realtà biologica. Il baluardo dell’antirazzismo è stato lo studio pubblicato nel 1972 da Richard Lewontin sulla valorizzazione delle proteine del sangue: una volta raggruppate le popolazioni analizzate in sette “razze”, euroasiatici occidentali, africani, est-asiatici, asiatici del sud, nativi americani, oceanici e indigeni australiani, Lewontin scoprì che l’85% delle variazioni dei tipi di proteine era costituito da quella tra individui entro le singole razze, e solo il 15% dalla variazione tra di esse, concludendo: “le razze e le popolazioni sono notevolmente simili tra loro, con la parte di gran lunga superiore di variazione rappresentata dalle differenze tra individui. La classificazione razziale degli umani non ha alcun valore sociale ed è sicuramente lesiva dei rapporto sociali ed umani”. Conclusione rassicurante.
Però, osserva Reich, oggi “gli studi sul genoma producono prove concrete di differenze sostanziali tra le popolazioni”. “Che piaccia o no, non è possibile bloccare la rivoluzione del genoma. I risultati che sta fornendo rendono impensabile difendere ancora la visione ortodossa”.
Lo studioso teme che “Le persone che negano la possibile esistenza di concrete differenze biologiche tra popolazioni per tutta una serie di caratteristiche si stiano ponendo in una posizione indifendibile, che non sopravviverà all’attacco della scienza”. Perché “Non possiamo negare l’esistenza di differenze genetiche sostanziali tra le popolazioni non solo nelle caratteristiche come il colore della pelle ma anche nelle dimensioni fisiche, nella capacità di digerire con efficienza gli amidi e gli zuccheri del latte o di respirare facilmente ad alta quota oppure nella suscettibilità a determinate malattie. Le differenze sono solo all’inizio”.
Il punto cruciale è se le differenze riguardano anche i tratti cognitivi e comportamentali. Ebbene, “Il tempo medio di separazione di coppie di popolazioni umane da quando si sono distaccate dalle popolazioni ancestrali comuni, che arriva fio a 50 mila anni per alcune coppie non africane e fino a 200 mila anni e più per alcune coppie di popolazioni subsahariane è tutt’altro che trascurabile nella scala dell’evoluzione umana. Se possiamo riscontrare gli effetti della selezione sull’altezza e sulla circonferenza delle teste dei neonati nell’arco di un paio di millenni, sembra insensato affermare che non possono esserci simili disparità medie nei tratti cognitivi e comportamentali”. Quindi “La scelta di fare finta di nulla, di lasciar credere all’opinione pubblica e ai colleghi che probabilmente non esistono sostanziali diversità nei caratteri tra popolazioni è una scelta strategica che noi scienziati non possiamo più permetterci, e nella pratica è chiaramente controproducente. Se come scienziati ci rifiuteremo cocciutamente di approntare un impianto razionale per la discussione delle differenze nell’umanità, lasceremo un vuoto pneumatico che alla fine sarà riempito dalla pseudoscienza”. Bisogna partire dal fatto che “Non abbiamo ancora campioni di dimensioni sufficienti per svolgere studi convincenti su quasi tutti i rami cognitivi e comportamentali ma ormai la tecnologia c’è, è disponibile e, una volta che saranno stati portati a termine studi altamente qualitativi – e lo saranno da qualche parte del mondo, che ci piaccia o no – qualsiasi associazione genetica scopriranno sarà incontestabile. Dovremo adeguarci a questi studi e reagire in maniera responsabile quando saranno presentati, però possiamo essere certi fin da ora che alcuni risultati ci stupiranno”.
Tali risultati non porteranno affatto al trionfo delle teorie razziste. Intanto “non abbiamo la minima idea al momento di quale sarà la natura o la direzione delle differenze tra popolazioni codificate nei geni”. Reich non vi fa accenno, comunque è presumibile che il timore principale di scienziati e politici riguardi l’eventualità che si scoprono differenze a svantaggio delle popolazioni che Reich definisce subsahariane, e che sono poi quelle dalla pelle nera, o meglio, alcune di esse. Ma non è detto che i risultati della genetica debbano confermare determinati stereotipi. Non si possono indovinare differenze genetiche medie basandosi sui tradizionali stereotipi razzisti. Del resto messi in crisi già oggi, senza l’apporto della genetica. Le start up tecnologiche stanno cambiando il profilo economico dell’Africa, il continente sembra abbia iniziato una rivoluzione digitale, attirando i colossi dell’hi tech: Microsoft ha aperto due centri di sviluppo tecnologico in Kenya e in Nigeria, Google uno di ricerca sull’intelligenza artificiale in Ghana. Per non parlare dell’esplosione di creatività artistica e culturale in atto in Nigeria. I subsahariani non sembrano affatto sfavoriti nelle capacità cognitive.
Si scopriranno differenze sostanziali tra le popolazioni ma non sappiamo ancora quali saranno. E comunque, come dovremo affrontarle?
Conclude Reich: “A parte l’imperativo di rispettare tutti in pari grado, è anche importante ricordare che c’è una grande diversità nei tratti umani, non solo in quelli cognitivi e comportamentali ma anche nelle capacità atletiche, nelle abilità manuali e nelle doti di empatia e interazione sociale. Per quasi tutti i tratti il livello di variazione tra individui è talmente grande che qualsiasi individuo di qualsiasi popolazione può eccellere in qualsiasi caratteristica indipendentemente dalle proprie origini, anche se certe popolazioni hanno diversi valori medi dovuti a un mix di influenze culturali e genetiche”. Perché “La cosa veramente offensiva del razzismo, in fin dei conti, è che giudica gli individui in base a un presunto stereotipo di gruppo, ignorando il fatto che gli stereotipi sono quasi sempre fuorvianti se applicati agli specifici individui”.