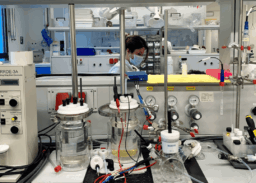Una strategia aziendale ispirata alle tematiche Esg ben definita, chiara, e perseguita con coerenza, non soltanto produce un impatto sociale e ambientale positivo, ma contribuisce in misura determinante allo stesso sviluppo del business dell’azienda. È uno dei temi emersi dal convegno “Why Liguria | Il bello e il buono-Obiettivo: la creazione del valore”, organizzato a Genova il 27 gennaio scorso da Deloitte e Gabetti (vedi qui).
A una delle due tavole rotonde del convegno è risultato esemplare il caso di Premuda, la compagnia di navigazione genovese che sta rinnovando e razionalizzando la propria flotta dotandola di navi sempre più “eco” e “super eco”. Abbiamo approfondito il tema con l’amministratore delegato Marco Fiori e il direttore finanziario Enrico Barbieri.
Fondata a Trieste nel 1907, che a quei tempi faceva parte dell’impero austroungarico, diventata “genovese” nel 1973 con il passaggio alla Nai della famiglia Lollighetti, poi acquisita dalla Navigazione Italiana (con la famiglia Rosina principale azionista-gestore, insieme ad Assicurazioni Generali e Duferco Italia Holding), Premuda è entrata in difficoltà nel 2013, come molte altre compagnie armatoriali italiane che hanno sofferto i postumi della crisi globale. La svolta è avvenuta nel 2017, quando il fondo Pillarstone ha rilevato le posizioni creditorie dei tre istituti maggiormente esposti, Unicredit, Intesa e Carige e, con un aumento di capitale riservato, è arrivato a detenere il 100% delle azioni di Premuda, che successivamente è uscita dalla Borsa. Il fondo fin da subito ha avviato in parallelo sia un processo di rinnovamento della flotta sia di consolidamento settoriale, compiuti nel set-up del Gruppo Finav, che insieme a Premuda costituisce una piattaforma unica nel suo genere in Italia. Nel 2019 sono entrati nella compagnia Marco Fiori (ad di Premuda e Chairman di Finav) ed Enrico Barbieri (cfo di Premuda e a.d. di Finav Holding). I due manager hanno guidato un articolato processo di revisione del modello di business di Premuda e di ammodernamento della flotta. I ricavi su base timecharter equivalent (tce) dell’intera piattaforma gestita da Premuda sono passati da circa 40 milioni di euro nel 2019 a circa 110 milioni di euro nel 2021. Nel 2022 è previsto un ulteriore incremento. Tra il 2019 e oggi la consistenza della flotta è passata da 13 a 29 navi. Nel settore tanker, quello in cui si sono concentrati gli investimenti, da 3 navi (11 anni di età media) a 20 navi (9,5 anni di età media).
– Perché la sostenibilità è importante per il business anche per chi non vende prodotti di largo consumo?

Barbieri. «In certi settori, in effetti, l’attenzione verso la decarbonizzazione e il cambiamento climatico viene anche dai consumatori e dal mercato. Noi questa pressione non la sentiamo direttamente, però siamo parte integrante di una filiera logistica in cui sono presenti stakeholder globali. Onestamente non tutti hanno lo stesso livello di attenzione ai temi della sostenibilità; alcuni, soprattutto gli operatori di prima fascia – come certe oil major o certi primari trader – esprimono già oggi una fortissima attenzione a questi temi. Altri, magari operanti nei paesi emergenti, dimostrano minore sensibilità. Premuda comunque non ha aspettato di essere sollecitata dagli stakeholder più esigenti in fatto di sostenibilità ma si è mossa in tempi nono sospetti anche alla luce dei cambiamenti regolatori previsti, come l’inclusione del settore marittimo nel Eu-Ets».
– Come?
Barbieri. «Nel nostro business è determinante, dal punto di vista delle emissioni, lo status quo della flotta, e in primis l’efficienza nei consumi. Rinnovare, cioè immettere in flotta navi più performanti, per un armatore è una cosa buona a prescindere ma è anche il fattore chiave quando si parla di strategia Esg. Le navi più moderne sono più performanti ed ecologiche perché producono minori emissioni. Il nostro progetto prende le mosse da un consolidamento settoriale che ha riunito in capo a Premuda navi di seconda mano, non progettate e non costruite da noi. A valle di un attenta review tecnica-commerciale di questo naviglio, nel tempo abbiamo individuato varie aree di miglioramento, che vanno dal semplice studio di un retrofit fino all’eventuale decisione di dismettere tonnellaggio obsoleto per reinvestire in qualcosa di più moderno. Questo processo da un punto di vista commerciale ci permette oggi di essere più appetibili, perché gli operatori di primo standing oggi, quando pianificano le loro coperture in termini di capacità e di logistica, danno priorità assoluta a navi “eco” o “super-eco”. Inoltre, nel nostro settore come in altri, anche il settore finanziario si dimostra sempre più attento a queste tematiche e infatti abbiamo da poco perfezionato un finanziamento in pool da 65 milioni con due primarie banche europee che hanno sostenuto il nostro progetto nella misura in cui esso era finalizzato a rinnovamento della flotta e ad un miglioramento del suo profilo Esg».
– In che modo avete attuato il rinnovo della flotta?
Barbieri. «Per esempio grazie ai rapporti di Marco con la cantieristica giapponese, forse la migliore al mondo nel settore delle product carrier, abbiamo avuto accesso a un mercato di navi molto ambite».
– Che cosa rende una nave più performante ed ecologica?
Fiori. «In primo luogo il disegno e il motore. E la variabile determinante è quella del consumo: una nave costruita prima del 2013, una cisterna da 50 mila tonnellate, carica, a tredici nodi può consumare ventisette tonnellate al giorno di bunker; una moderna “eco” scende a diciannove-diciassette. Dieci tonnellate in meno al giorno. C’è di sicuro un vantaggio economico, ma è anche un vantaggio ecologico: meno carburante bruciato, meno emissioni, meno inquinamento. Da quando abbiamo iniziato il nostro percorso di ricostruzione e rinnovamento nel segmento delle cisterne siamo riusciti nell’impresa di portare la nostra flotta sotto la soglia dei 10 anni di età media della flotta».
Barbieri .«Negli anni scorsi ci siamo espansi rapidamente, senza perdere mai di vista l’obbiettivo di migliorare il nostro profilo commerciale, in modo da renderlo immediatamente riconoscibile all’esterno. Oggi, parlando coi nostri noleggiatori, possiamo spenderci una decina di petroliere medium range di età inferiore a 5 anni: questo significa avere un posizionamento di mercato chiaro. Per rinnovare una flotta servono fondi, ma serve soprattutto una visione di mercato. Al convegno Why Liguria abbiamo discusso alcuni fattori trasversali che sembrerebbero ricorrenti nelle società che crescono, e uno di questi era la propensione a “giocare in attacco”. Ebbene io penso che noi, senza mai prendere rischi eccessivi, perché nei propri programmi bisogna sempre contemplare anche gli scenari peggiori, in questi anni abbiamo sempre attaccato, sempre investito, dall’inizio e fino a oggi. La prima cisterna del nuovo corso l’abbiamo comprata a settembre 2019, l’ultima a inizio gennaio 2023. Nel mezzo c’è stata una grande variabilità di mercato. Noi però abbiamo sempre cercato di proteggere la nostra visione e il nostro posizionamento, pur in presenza di picchi e flessi. Fin da subito, col fondamentale supporto del nostro azionista, abbiamo assunto una postura proattiva. Abbiamo venduto e comprato tanto, lavorando in primis sul mix di stiva, alleggerendo il dry ed espandendoci nelle cisterne; e all’interno del settore cisterne, a esito di quella review analitica che abbiamo descritto prima, abbiamo identificato le navi “non core” e pianificato una loro sostituzione con navi più moderne e performanti».
Fiori. «Diciamo che abbiamo sempre cercato di giocare in anticipo e il mercato è complessivamente andato in una direzione coerente con la nostra visione del 2019. Giocare in anticipo in questo settore vuol dire tantissimo».
Barbieri. «Per noi è fondamentale qualificare correttamente il punto d’ingresso di un investimento navale. Non è mai facile prevedere a un dato momento del ciclo se una nave salirà ancora di valore o scenderà, e quanto. Aiutati anche dal dna finanziario del nostro azionista, abbiamo elaborato un processo decisionale legato in primis a un’analisi statistica e delle evidenze storiche. Se in sede di compravendita navale paghi un prezzo in linea con la serie storica dei valori medi, o meglio ancora mediani, non puoi sbagliare di molto, anche se devi essere consapevole che durante la durata dell’investimento potrai incontrare dei flessi. Se invece paghi un prezzo più alto, nulla vieta che il valore salga ancora e concorra a generare un rendimento positivo, ma devi essere pienamente consapevole e informato dei rischi che stai assumendo».

Fiori. «Le farò un parallelismo. Quando uno decide di comprare un’opera d’arte, deve cercare di comprare qualcosa di bello e di valore, pagando il giusto prezzo. Per le navi può dirsi la stessa cosa. Quello che ha detto Enrico è giustissimo, io vorrei aggiungere solo due cose. La prima è che il mondo delle cisterne, secondo me, si divide in modo netto tra player di Serie A e player di Serie B, e noi sicuramente vogliamo essere collocati tra i primi. Lavoriamo solo coi top, tutti colossi. Non possiamo e non vogliamo trascurare il fatto che queste società cercano partner in grado di offrire soluzioni di trasporto competitive, e soprattutto ecologiche. Il mercato si sta polarizzando, gli operatori top cercano partner top. Ci tengo comunque a sottolineare che lo shipping rappresenta qualcosa come il 4-5% delle emissioni di CO2, anche se via mare passa oltre il 70% delle merci. Il trasporto via mare è nettamente quello che offre le maggiori economie di scala».
– Che impatto ha avuto il Covid sui traffici?
Fiori. «Il Covid in primis ha evidenziato quanto sia lunga e fragile la filiera. La gente si è improvvisamente resa conto che la merce non viene prodotta sotto casa o dietro al negozio. Durante la pandemia la nostra attività non è diminuita, le navi non si sono mai fermate. A livello operativo ci sono state enormi complicazioni. Le faccio alcuni esempi di vita vissuta: la gestione logistica degli equipaggi e i loro spostamenti in tutte le parti del mondo; le navi messe in quarantena in caso di contagi di uno o più membri dell’equipaggio; le inefficienze portuali in sede di discarica, con incredibili effetti di congestione. In questo senso molte attività all’interno del nostro business sono rallentate considerevolmente. Alcune nostre navi sono rimaste bloccate in un cantiere cinese che, dall’oggi al domani, è stato posto in quarantena e chiuso dalle autorità locali. Una sosta programmata di 25 giorni è durata 90, con un significativo aggravio di costi. Però, ripeto, i traffici marittimi nella loro globalità non si sono mai fermati. Le nostre navi hanno ininterrottamente garantito il servizio. Certo, i noli hanno subito delle variazioni. Nel carico secco appena esplosa la pandemia, si è avuto un down, in primis a causa dei ripetuti lockdown in Cina. Poi, piano piano, si è assistito a una ripresa anche grazie al traino indiretto dei container. Noi, però, nel frattempo ci eravamo posizionati sulle cisterne. Quando la pandemia è scoppiata si è avuto un forte sbilanciamento tra domanda e offerta di petrolio e i noli ne hanno tratto un beneficio immediato, anche grazie al gran numero di navi che nel frattempo avevano trovato impiego come unità di stoccaggio. Poi, nel quadro di un complessivo ribilanciamento tra domanda e offerta, e di un rallentamento della domanda di petrolio proveniente dall’economia reale, i noli sono scesi. Nel settore petrolifero, i maggiori consumi riguardano il diesel, che viene utilizzato per le auto, il riscaldamento e per i generatori di energia. Poi vengono gli aerei e in effetti durante la pandemia la domanda di jet fuel è crollata. Idem dicasi per la benzina nel contesto di una riduzione generalizzata della mobilità. È quindi evidente che il nostro settore abbia subito un impatto.
– E la guerra che impatto ha avuto sull’economia globale e sui vostri traffici?
Fiori. «Il conflitto russo-ucraino, quasi come un catalizzatore, ha accelerato un trend che secondo noi era già era in essere. L’ha reso certamente più drammatico, ci fatto scoprire che bisognava diversificare le fonti di approvvigionamento, la gente si è spaventata, poi sono aumentati gli stoccaggi in certe parti del mondo e soprattutto, per quanto riguarda noi, le rotte sono state completamente stravolte. Al pari di altri armatori, avevamo navi normalmente impiegate in traffici da e per la Russia. Da un giorno all’altro per armatori come noi quel mercato si è congelato. Tuttavia la Russia è un esportatore formidabile di petrolio e non ha smesso di esportare, anzi. Il prodotto russo ha cambiato destinazione, rivolgendosi perlopiù verso Cina e India. Ora, un driver importantissimo per il nostro business, è il rapporto tonnellate/miglia. Se lo stesso prodotto deve essere trasportato per distanze maggiori è normale che ciò si traduca in una maggiore domanda di trasporto. Anche perché la velocità delle navi ha un limite. Se per far arrivare nei nostri porti una determinata quantità di prodotto una nave impiega cinque giorni, ma poi il tempo di trasporto si allunga a 20 giorni, per mantenere lo stesso ritmo di approvvigionamento occorrerà un numero maggiore di navi. Questo globalmente si traduce in un aumento della domanda di trasporto. E infatti l’attuale livello dei noli riflette questa dinamica e a beneficiarne è tutto il sistema, anche chi come noi non tocca porti russi».
Barbieri. «In concomitanza c’è da considerare la scarsità di nuove navi cisterna in costruzione. Questo è importante».
– Perché poche navi cisterna in costruzione?
Barbieri. «In primo luogo, perché c’è stata una corsa agli ordini in altri settori, che hanno saturato la capacità produttiva della cantieri del Far East. Pensiamo solo al boom di ordini di navi portacontenitori. La carenza di ordini non è legata alla guerra ma soltanto a dinamiche interne al settore».
– La carenza di navi cisterna ha comportato un rincaro dei noli che vi ha giovato? E in quale misura?
Barbieri. «Questa carenza è soprattutto prospettica, quindi è più un fattore che consideriamo positivo per il futuro. Il rallentamento degli ordini è legato anche a un altro fattore che abbiamo toccato brevemente durante i lavori del convegno Why Liguria, che è la grossa incertezza sui carburanti del futuro. Questo è il vero fondamentale tema di riflessione ESG, perché le navi “super-eco”, per quanto virtuose, non possono essere considerate il punto d’arrivo. Quale sarà la nave del futuro? Il settore non ha una risposta e quindi oggi ordinare una nave e impegnarsi finanziariamente per 15-20 anni senza certezze è una scommessa».
– Eppure non mancano tecnologie e carburanti da fonti non fossili
Fiori. «Ci sono diverse tecnologie, ma non ce n’è una vincente. Si parla di idrogeno, ammonio, metanolo. Si parla addirittura di nucleare, ma tutte hanno dei problemi. L’idrogeno è altamente pericoloso, l’ammoniaca è corrosiva. Poi nel valutare un fuel alternativo c’è il grosso problema del peso specifico rispetto al potere calorico: ove più basso di quello del petrolio, si avrebbe bisogno di serbatoi molto più grandi, con una riduzione della stiva. Non ci sono soluzioni perfette. Anche il nucleare potrebbe funzionare ma ci sono timori per la sicurezza. Ognuno ha pro e contro e il dibattito è aperto. Bisogna anche considerare un fattore importante: pensare a carburanti alternativi è facile se pensiamo a una grossa nave portacontenitori che fa servizio di linea e tocca primari porti internazionali. A una nave del genere bastano tre o quattro punti di raccolta per il carburante, e allestire tre o quattro punti di raccolta non è difficile. Ma le navi più piccole, che toccano tantissimi porti, hanno bisogno di molti più siti di stoccaggio. Ecco allora che il problema si sposta alla catena di distribuzione di questi nuovi carburanti. E qui il discorso cambia. È un grosso progetto questo delle energie alternative, ed è virtuoso. Ma il petrolio rimarrà protagonista ancora per diversi anni. Molti settori non possono farne a meno dall’oggi al domani, serve una transizione controllata».
– C’è anche la propulsione elettrica
Fiori. «Sì ma sulle lunghe distanze non funziona. Gli aerei elettrici è impossibile farli! Dove forse la transizione è più facile è sui veicoli di terra, anche se il problema della catena distributiva permane. Per tornare al trasporto marittimo, teniamo presente che le navi hanno una vita utile di circa vent’anni, più un paio d’anni di costruzione. Chi compra una nave investe capitali enormi da ammortizzare in un futuro che è difficile da prevedere».
– Dovete affrontare incognite che riguardano in pratica tutto lo scenario globale, carburanti, tecnologie, e rotte che a loro volta dipendono da fattori geopolitici e sociali difficilmente prevedibili. Quattro anni fa nessuno o ben pochi si aspettavano una pandemia e una guerra nel cuore dell’Europa…
Barbieri. «In questo contesto pieno di incertezze un altro elemento chiave per chi, come noi, opera in un business ad alta intensità di capitali è la capacità di ottimizzare la propria struttura finanziaria. Se non sei attentissimo al costo del funding, distruggi valore, o comunque ne generi meno di quanto potresti. Anche la resilienza finanziaria è molto importante. Avendo mantenuto costantemente un adeguato buffer di sicurezza siamo riusciti a passare indenni attraverso un paio di cicli negativi, prima sul dry e poi sulle cisterne, tenendoci pronti per il successivo rimbalzo. Nel nostro settore, contrariamente ad altri, non si muore di redditività ma per mancanza di liquidità».
Fiori. «La pandemia ci ha colti in pieno sviluppo. Quando il mercato è andato nella direzione opposta alla nostra abbiamo avuto la forza di resistere. Se hai una struttura fragile e sei costretto a smobilizzare nel momento sbagliato del ciclo distruggi per forza valore. Se invece hai la forza di aspettare, non solo recuperi, ma ottieni anche il tuo rendimento atteso».
– Le tematiche Esg riguardano, oltre ai fattori ambientali quelli sociali e di governance
Fiori. «In questi anni non ci siamo limitati a rinnovare la flotta. Abbiamo rinnovato profondamente la struttura di Premuda, assumendo una ventina di persone di età media intorno ai trent’anni. Tra essi tantissimi ragazzi genovesi e liguri, formati dall’Università locale, che avevano studiato materie affini al nostro business e avevano una forte motivazione a lavorare nello shipping. Non di rado ai colloqui incontriamo ragazzi che ci dicono cose del tipo ‘mio nonno lavorava sulle navi’ oppure ‘la mia famiglia è legata al mare’… I nuovi ingressi hanno portato in azienda un’energia favolosa. In tanti poi vi è l’orgoglio di lavorare per un nome come storico come Premuda e questa per noi è un enorme soddisfazione. Il vero legame di Premuda con questo territorio sono loro, sono le nostre persone. Nel frattempo noi continuiamo a evolvere e ad assumere. La ricerca di personale per il nostro team è sempre aperta».