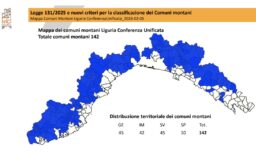I cigni, in Europa, si è pensato per secoli che fossero bianchi, finché, nel 1697, l’esploratore olandese Willem de Vlamingh, scoprì dei cigni neri in Australia. Questa smentita improvvisa di una credenza consolidata nel tempo è stata presa come esempio da Nassim Nicholas Taleb per spiegare l’importanza nella storia e nella vita dell’uomo di eventi di grande impatto, difficili da prevedere e molto rari: «una sola osservazione può confutare un’asserzione generale ricavata da millenni di avvistamenti di cigni bianchi».
 Partendo da questa constatazione Taleb, filosofo, matematico e trader a Wall Street, nel 2007 ha pubblicato “The Black Swan”, diventato un best seller internazionale, inserito dal Sunday Times tra i libri che hanno cambiato il mondo e pubblicato in Italia dal Saggiatore.
Partendo da questa constatazione Taleb, filosofo, matematico e trader a Wall Street, nel 2007 ha pubblicato “The Black Swan”, diventato un best seller internazionale, inserito dal Sunday Times tra i libri che hanno cambiato il mondo e pubblicato in Italia dal Saggiatore.
In questo saggio l’autore sostiene che la storia sia segnata da avvenimenti sorprendenti – i cigni neri – a cui si danno spiegazioni che spesso si dimostrano inefficaci. Taleb definisce così un cigno nero: «In primo luogo, è un evento isolato, che non rientra nel campo delle normali aspettative, poiché niente nel passato può indicare in modo plausibile la sua possibilità. In secondo luogo, ha un impatto enorme. In terzo luogo, nonostante il suo carattere di evento isolato, la natura umana ci spinge a elaborare a posteriori giustificazioni della sua comparsa, per renderlo spiegabile e prevedibile». Di conseguenza il futuro non è prevedibile.
L’autore spiega che per natura impariamo dall’esperienza e dalla ripetizione, ci concentriamo su cose che già sappiamo e trascuriamo sistematicamente ciò che non conosciamo. Così siamo indifesi di fronte all’imprevisto, si tratti di mercati finanziari o vita quotidiana.
Si potrebbe osservare che imparando dall’esperienza siamo indifesi di fronte ai cigni neri, ma ce la siamo cavata sempre abbastanza bene con quelli bianchi. E gli schemi di semplificazione possono portare all’errore ma anche a salvarci la vita se, per esempio, udendo degli spari corriamo immediatamente a ripararci dietro qualcosa di solido anziché meditare sulle leggi della balistica o dell’acustica. I nostri antenati hanno imparato che a una certa impronta corrisponde un certo animale il quale – differenza sostanziale – può essere preda o predatore – e che l’aspetto del mare, la direzione e la forza del vento oggi possono sconsigliare di andare a pesca domani, e così via. È grazie ai molti cigni bianchi azzeccati che l’homo sapiens è riuscito a sopravvivere ai pochi cigni neri imprevedibili. Inoltre, alcuni presunti cigni neri sono soltanto cigni bianchi che, per così dire, abbiamo lasciato in ombra. Lo scoppio della prima guerra mondiale ha sorpreso l’Europa, ma non risponde al secondo requisito formulato da Taleb («niente nel passato può indicare in modo plausibile la sua possibilità»): parte della gioventù intellettuale europea tra fine Ottocento e inizio Novecento aspirava al rinnovamento e alla catarsi in un bagno di sangue, il nazionalismo aveva avvelenato i popoli, e gli Stati erano incatenati da impegni solenni e trattati di alleanze e controalleanze che hanno reso automatico il loro coinvolgimento nel conflitto. Per non parlare della seconda guerra mondiale, prevista da Churchill (e non solo) che aveva denunciato in ogni modo possibile l’avvicinarsi della catastrofe. Molti altri eventi no, non stati previsti, non solo quello delle Torri gemelle, opera di poche menti allucinate, ma anche un fenomeno giunto al termine di un lungo sviluppo, sotto gli occhi di tutti, il crollo del comunismo, e invenzioni che hanno cambiato il mondo come il personal computer e Internet e da fatti straordinari sono entrati a far parte della nostra vista quotidiana
Ha quindi ragione Taleb, non possiamo conoscere il futuro pensando solo al passato. Ma allora come possiamo fare per ridurre i rischi e, possibilmente, cogliere delle opportunità? Intanto, ci spiega il filosofo-finanziere, rinunciamo a trovare sempre una spiegazione a qualcosa accaduto in base a spiegazioni elaborate a posteriori, escludendo le casualità. Manteniamo la mente aperta, pensiamo fuori dagli schemi. Guardiamo oltre l’ovvio e le teorie consolidate e, soprattutto, evitiamo il dogmatismo.