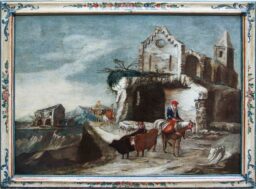Tutti gli aspetti ambientali riconducibili all’esercizio della raffineria Iplom di Busalla (foto di apertura di Riccardo Parigi/Must) e le attività di gestione e mitigazione adottate dall’azienda nel rispetto delle autorizzazioni ambientali e di sicurezza sono diventati oggetto di studio al corso di perfezionamento universitario “Inquinamento e salute: la valutazione di impatto sanitario” organizzato da Ticass, Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile.
Ticass è una società consortile senza fini di lucro costituita nel 2010. Riunisce 47 tra pmi, grandi imprese e centri di ricerca, inclusa l’Università di Genova.
A illustrare la strategia di Iplom nella salvaguardia della salute e dell’ambiente è intervenuto il suo hse manager (health, safety & environment), Gianfranco Peiretti.
 I partecipanti hanno avuto modo di valutare i singoli aspetti attraverso la discussione diretta dei report ambientali e dei risultati delle specifiche indagini ambientali. Dall’esperienza deriverà una tesi realizzate da alcune ricercatrici del team del prof. Alberto Izzotti.
I partecipanti hanno avuto modo di valutare i singoli aspetti attraverso la discussione diretta dei report ambientali e dei risultati delle specifiche indagini ambientali. Dall’esperienza deriverà una tesi realizzate da alcune ricercatrici del team del prof. Alberto Izzotti.
Iplom si è resa disponibile a costituire una case study con simulazione di un progetto di realizzazione di un nuovo sito di processo connesso alla raffineria di Busalla su cui impostare ed elaborare una Viias (Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario) che contempla in un’unica metodologia l’analisi delle componenti salute e ambiente. Ciò ha comportato la necessità di presentare ai partecipanti al corso la gestione ambientale dell’azienda rendendo fruibili tutti i dati dei monitoraggi condotti. Un’occasione per poter condividere il complesso delle attività di monitoraggio condotte sia per ottemperare alle autorizzazioni (Aia, Autorizzazione integrata ambientale) che per far fronte a tutti gli altri adempimenti richieste dalle altre normative applicabili, primi fra tutti la legge Seveso sulle attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, nonché tutte le iniziative promosse volontariamente dall’azienda per la prevenzione ed il controllo della salute dei lavori.
L’approfondimento dei singoli impatti ambientali è stato condotto a partire dai dati disponibili, per esempio dal monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera assicurato dagli analizzatori in continuo presenti su ogni singolo camino (Sme), con l’applicazione di modellistica di simulazione che riproduce le ricadute spazio-temporali sul territorio, con validazione delle distribuzioni ottenuto da parte delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria presenti sul territorio comunale gestite dall’Arpal.
L’approccio adottato ha consentito quindi di trasformare una testimonianza in un momento di condivisione e riflessioni sui temi della sostenibilità, nonché sull’imprescindibile necessità che le organizzazioni siano sempre più affidabili e resilienti, comunicando con la massima trasparenza le proprie performance ambientali, anche e soprattutto in caso di incidenti in cui possono incorrere, dando dimostrazione della capacità di reazione e gestione delle crisi anche di fronte a situazioni emergenziali.