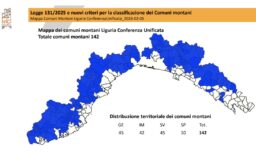Natale è alle porte e, insieme ai regali, in questi giorni si pensa al menù del pranzo del 25 dicembre. Una volta c’era poco da pensare, ogni territorio, città, paese aveva le sue tradizioni, il menù non lasciava spazio a tante varianti, e per molte famiglie il problema non era scegliere i cibi ma trovare i soldi per pagarli. Può essere interessante vedere quali erano le nostre tradizioni natalizie, così, per conoscerci meglio (e magari trovare qualche spunto interessante da riprendere).
Natale è alle porte e, insieme ai regali, in questi giorni si pensa al menù del pranzo del 25 dicembre. Una volta c’era poco da pensare, ogni territorio, città, paese aveva le sue tradizioni, il menù non lasciava spazio a tante varianti, e per molte famiglie il problema non era scegliere i cibi ma trovare i soldi per pagarli. Può essere interessante vedere quali erano le nostre tradizioni natalizie, così, per conoscerci meglio (e magari trovare qualche spunto interessante da riprendere).
Anche in Liguria ogni microterritorio aveva il suo menù natalizio, oggi cerchiamo di conoscere meglio la tradizione più diffusa, quella di Genova capoluogo. E poiché le tradizioni non sono affatto immutabili, dobbiamo fare un’altra scelta, quella del tempo: puntiamo su fine Ottocento, un periodo abbastanza vicino a noi da permettere dei confronti ma antecedente agli sconvolgimenti portati dall’industrializzazione e dalle due guerre mondiali.
Forse la differenza fondamentale tra le feste natalizie di allora e quelle di oggi è la scomparsa, in molte famiglie, della separazione tra i piatti di magro della vigilia e quelli di grasso riservati al 25 e ai giorni successivi. Separazione vigente in tutta Italia, però in altre parti della penisola la cena della vigilia era, sì, di magro, ma piuttosto ricca. Nel vicino Oltrepò pavese, per esempio, erano previste sette portate: insalata di barbabietole, peperoni e acciughe, torta di zucca, cipolle ripiene, “fasce del Bambino con l’agliata” (cioè lasagne condite con un pesto di aglio, noci, mollica di pane, cagliata, burro), merluzzo con l’uvetta, formaggetta con mostarda, pere ghiacciolo cotte con le castagne. Le “sette cene”, tra le quali in genere, nel centro-sud figura il capitone (femmina dell’anguilla) si ritrovano in altre parti della penisola, A Genova rimane il ricordo di una zuppa di cavolo nero che interrompeva il digiuno della vigilia, i pranzi e le cene si facevano dal 25 in poi.
Uno dei piatti comuni più comuni oggi sulle tavole dei genovesi il giorno di Natale, insieme al pandolce, è quello dei ravioli. A fine Ottocento i ravioli compaiono ma non sempre. Indispensabili, per fare Natale, sono i natalini, lunghi, lisci maccheroni in brodo di cappone.
Anche i berodi, i sanguinacci, sembra fossero una presenza costante, probabilmente più di cibi molto costosi come cappone, tacchino, aragosta che vediamo elencati nei menù di una volta.
Una dettagliata descrizione del pranzo natalizio delle famiglie benestanti troviamo nella poesia “O tondo de Natale” (Sagep, 1968) del poeta dialettale Nicolò Bacigalupo (1837 – 1904), autore, tra l’altro, della famosa commedia inscenata da Gilberto Govi, “Manezzi per maia ‘na figgia”. O tondo de Natale è stato pubblicato agli inizia del Novecento.
Riportiamo qui testo e traduzione, ripresi dal sito del Comune di Genova
O tondo de Natale
Töa missa in moddo splendido,
O da poei fâ dö sciäto,
E tanto ciû ne-o popolo,
Ciû dö so proprio stato,
Quanto a-o menû, ö lé d’obbligo,
Nö ghe raxön, ne scûsa;
Coscì và faeto e s’ûsa,
Pe antiga tradiziön.
Minestra: ö natalizio
Tipico maccarön,
Chêutto c’ûn pö de sellao,
Ne-o broddo de cappön.
Questo ö lé de prammatica,
Nö sae manco Natale,
Se ûnn-a minestra uguale
A fösse eliminâ.
Natûralmente, seguita
Questo cappön buggïo,
Ma chêutto in punto e virgola
Ne fatto ne savöio,
O quae, ö deve ëse tenio,
Co-a pelle bella gianca,
Che ö pëto, a chêuscia e l’anca
Nö saccian de pollâ.
Poi ven ûn piatto d’ûmido:
Cioè, fracassâ de creste,
De colli, chêu, pellantega,
Pevë, fighaeti e teste
De pollo, con lûganega,
Che l’aggie so bagnetta
Pe poei bagnâ a maoletta
Con di cröstin de pan;
Un atro piatto d’obbligo
O saèiva l’aragösta
Pe quelli che pêuan spendighe
Tûtti i dinae che a cösta;
Ma anchêu nö se tia a laexina,
Voei a ghe vêu, n’importa
Che a seggie chêutta morta,
Per quelli che nö san.
Poi, ven l’indispensabile
Berodo e tûtt’intörno,
di tocchi de lûganega
Pe scorta e pe contörno
Unico a-ö palato e satûro
De pessi de çervella
De fietti de vitella,
Festecchi e de pignêu ;
O rosto indispensabile
Pei ricchi e i fradellin
O lé, besêugna dïvelo?
O classico bibbin;
Se a lé bibinn-a zövena
A molti a pâ ciû bönn-a
Mettendola â storiönn-a,
Ma a regola a nö vêu.
Un atro piatto indigeno:
Radicce pe insalata,
Che ö troppo grasso ö mitiga
E a-o stêumago ö s’addatta,
Tenie, che perdan l’anima,
C’ûn gûsto d’amaretto,
Tant’êuio, ûn pö d’aggetto
E quaexi senza axioû.
O döçe ö lé ad libitum;
Törte de pasta frolla,
Laete de tûtte e specie,
A rosto ed â spagnola,
Croccante con l’amandoa,
Meringhe, cobelletti,
Pasta sfêuggiâ, bönetti
De laete e zabaion.
Secöndo i gûsti; a regola
Esplicita, formale,
A veu ö caratteristico
Pan döçe de Natale,
De forme mastodontiche
Perché ö soddisfe l’oeûggio,
Co-a ramma de l’ofeûggio
Ciantâ in sce-a sömmitae.
A questo nö se deroga,
E ö Cappo de famiglia,
Pe sacro ed inviolabile
So privilegio, ö piggia
L’arma dö sacrificio,
E sûbito ö se mette
A fâne tante fette,
Con tûtta serietae.
Pan döçe dunque, amandôe,
Festecchi, cannellette,
Frûta candìa, damaschine,
Nespöe, çetröin, sëxette,
Uga, zibibbo, dattai,
Amandôe, fighe secche,
Mostarda, nöxe becche,
Vegette, mandarin,
Törrön, frûta in tö spirito,
Peie bûrê e martinn-e,
Mei carli, meie rûzzene,
E meie canellinn-e,
Beschêutti d’ogni genere,
Rechêutto de Voltaggio
E in ûltimo, ö formaggio
Cho ö deve ëse Stracchin.
E questa miscellanea,
A forma ö materiale,
Secöndo l’ûso classico,
Dö tôndo de Natale,
Che i figgi, i nevi, i zenei
E tûtta a compagnia,
Se devan portâ via,
Secöndo a tradiziön.
Se saera cö Rosolio
E ö döçe d’Alicante,
O vin dell’Arçipelago
E l’Asti spumeggiante;
E quarchedd’ûn, all’ûltimo,
O termina a demôa,
Con fâ portâ in sce-a töa
E beive a-o böttigiön.
Il piatto di Natale
Tavola apparecchiata in modo splendido/ da poter fare bella figura/ e quanto più è popolare/ quanto è più bella del solito/ In quanto al menù, è d’obbligo,/ non c’è ragione né scuse;/ Così va fatto e si usa,/ per l’antica tradizione./ Minestra: il tipico maccherone natalizio,/cotto con un pò di sedano,/ nel brodo di cappone,/ questo è d’obbligo,/ non sarebbe neanche Natale,/ se una minestra uguale/ fosse eliminata./ Naturalmente, segue/ questo cappone bollito,/ ma cotto “in punto e virgola”, /né scotto né salato/ che deve essere tenero,/ con la pelle bianca, che il petto, la coscia e l’anca/ non sappiano di “pollame”. Poi viene un piatto d’umido:/ cioè fricassea di creste,/ di colli, cuore, pelle, zampe, fegati e teste/ di pollo con la salsiccia, che abbia il suo sughetto/ per poter bagnare la mollica/ con dei crostini di pane;/ un altro piatto d’obbligo/ sarebbe l’aragosta/ per quelli che possono spendere/ tutti i soldi che costa;/ ma al giorno d’oggi non si stia a lesinare,/ esserci ci deve essere, non importa/ che sia cotta già morta/ per quelli che non lo sanno./ Poi, viene l’indispensabile sanguinaccio e tutto intorno,/ pezzi di salsiccia,/ per “scorta” e per contorno/ unico al palato e ripieno di pezzi di cervella, di filoni di vitello/ pistacchi e di pinoli;/ l’arrosto indispensabile per tutti,/ c’è bisogno di dirlo?/ il classico tacchino;/ se è una tacchinella giovane,/ a molti sembra più buona/ mettendola alla “storiona”/ ma per regola non ci vuole./ Un altro piatto tipico:/ radici in insalata/ che mitiga il troppo grasso/ e si adatta allo stomaco,/ tenere che perdano l’”anima”, con un gusto d’amaretto,/ tanto olio, e un po’ d’aglio/ e quasi senza aceto./ Il dolce è “ad libitum”;/ torte di pastafrolla,/ latte di ogni specie,/ al forno e alla spagnola,/ croccante con la mandorla,/ meringhe, pasta sfoglia. budini di latte e zabaione./ Secondo i gusti; la regola/ esplicita e formale,/ vuole il caratteristico pandolce di Natale,/di forme mastodontiche/ perché soddisfi l’occhio,/ con il ramo di agrifoglio/ piantato sulla cima./
A questo non si rinuncia,/ e il capo famiglia,/ per sacro e inviolabile/ suo privilegio, prende / l’arma del sacrificio,/ e subito inizia/ a farne tante fette,/ molto seriamente./ Pandolce, quindi mandorle,/ pistacchi, confetti di cannella,/ frutta candita, / nespole, arance, ciliegine,/ uva, zibibbo, datteri,/ mandorle, fichi secchi, / mostarda, noci,/ mandarini/ torrone, frutta sotto spirito,/ pere butirro e martine,/ mele carle, mele ruggine,/ mele cannelline,/ biscotti di ogni genere,/ ricotta di Voltaggio/ E in ultimo, il formaggio/ che deve essere Stracchino./ E questo insieme/ forma gli ingredienti,/ secondo l’uso classico,/ del pranzo di Natale, che i figli, i nipoti, i generi,/ e tutta la famiglia/ devono consumare/ secondo la tradizione./ Si chiude con il Rosolio/ e il vino dolce d’Alicante, Il vino dell’Arcipelago/ e l’Asti spumeggiante;/ e qualcuno, all’ultimo,/ termina il divertimento,/ facendo portare in tavola/ e bevendo al bottiglione.
Placet experiri!