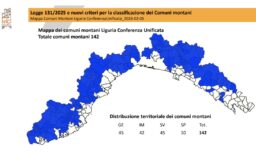Uno studio della Fondazione Cima ha stabilito che, a Genova, con la nuova copertura sul Bisagno e lo scolmatore del Fereggiano, i danni economici e le persone a rischio in caso di esondazione, sarebbero molto ridotti rispetto alla situazione attuale: prendendo come riferimento l’alluvione del 2014, l’ammontare dei danni sarebbe passato da 100 milioni a 10 e le persone coinvolte da oltre 12 mila a “solo” 760 veramente a rischio.
Lo studio è l’applicazione a una realtà locale di una piattaforma per analisi multirischio chiamata Rasor (finanziata dall’Ue), che è stata già usata per Haiti e Malawi, solo per fare qualche esempio. Rasor, acronimo di “Rapid analysis and spatialization of risk”, consente di partire dai rischi (terremoto, alluvione, eruzione vulcanica eccetera), selezionare l’esposizione (popolazione, edifici, agricoltura eccetera) per arrivare alla stima del danno (su ambiente, persone eccetera).
«Le persone coinvolte in disastri naturali nel mondo – dice il professore della Fondazione Cima Luca Ferraris – sono 4,4 miliardi, il 64% del totale, i danni ammontano a 2 trilioni di dollari, pari a 25 anni di aiuti internazionali, 1,3 milioni sono le vittime, pari a 1500 disastri aerei, si tratta di cifre che i governi non possono ignorare».
Per Genova è stato considerato solo il rischio alluvione e come esposti gli edifici e la popolazione, la valutazione è stata fatta solo sugli impatti fisici umani ed economici: «È stato difficile modellare la piena a causa della “porosità” della città – spiega Ferraris – quasi 1/2 del volume è finito in scantinati e parcheggi sotterranei».
Lo studio ha mostrato come ogni tipo di struttura abbia una propria curva di danno: dalla scuola al museo, dall’esercizio commerciale alla semplice abitazione: «La stessa cosa riguarda le persone – aggiunge Ferraris – in questo caso abbiamo dovuto considerare non solo il livello, ma anche la velocità dell’acqua».
Nella mappa elaborata dal sistema Rasor è evidenziata una zona in rosso, la più pericolosa: il sottopasso di Brignole. Con la nuova copertura del Bisagno e lo scolmatore del Fereggiano quella zona diventerebbe arancione, ma soprattutto anche tutta l’area circostante sarebbe molto più sicura.
Fondazione Cima ha anche spiegato che prevedere con certezza un evento atmosferico come quello del 2014 è oggi praticamente impossibile: «Abbiamo usato la piattaforma Drihm, anche questa finanziata dall’Ue. Simulando ex-post in scala finissima sul decimo computer più potente al mondo, non siamo riusciti a individuare l’evento della sera che ha provocato l’esondazione del Bisagno e ci sono volute 20 ore di calcolo per arrivare a 24 ore di previsione».
Quello che Fondazione Cima ha in qualche modo compreso è che il Bisagno va in crisi quando le precipitazioni si concentrano sul Geirato: i dati disponibili e i racconti tramandati dagli osservatori prima che ci fossero misurazioni precise, mostrano che è quel bacino che contribuisce ad accelerare i tempi di risposta del Bisagno.
In termini di costi-benefici Ferraris ha fatto una proiezione basandosi sull’ipotesi che i prossimi 50 anni potrebbero essere “sfortunati” come gli ultimi 50 in termini di eventi alluvionali, congelando il fatto che il clima subirà ulteriori scossoni: «Gli investimenti per le due opere costano 251 milioni, considerando un danno medio annuale di 6,5 milioni e avendo calcolato che con le opere il danno sarebbe invece di un milione all’anno, la copertura del Bisagno e lo scolmatore del Fereggiano si “ripagherebbero” in 50 anni, senza contare il beneficio per la riduzione del numero di persone coinvolte».