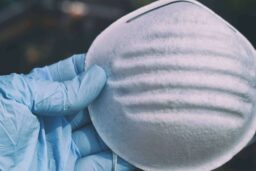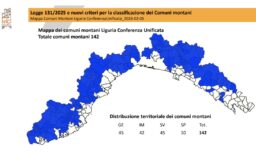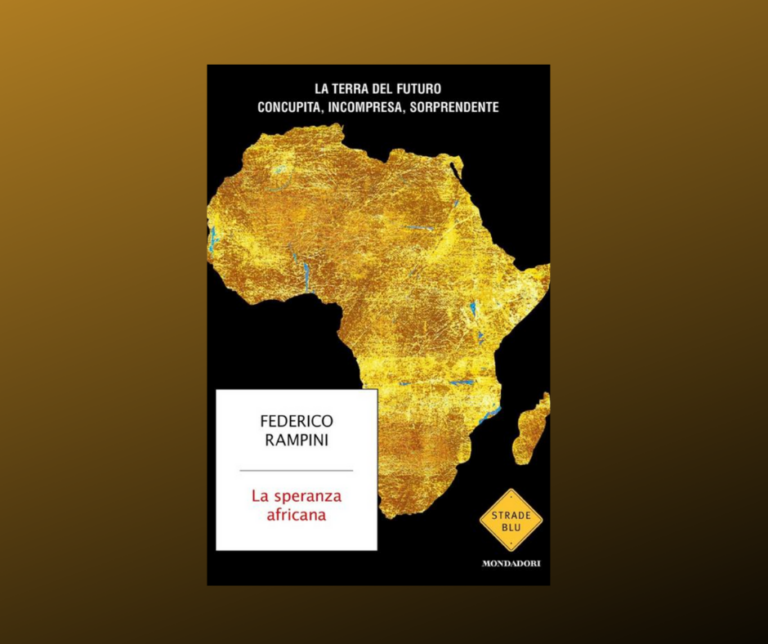“La terra del futuro concupita, incompresa, sorprendente”: ogni parola del soprattitolo del libro di Federico Rampini “La speranza africana” (Mondadori) ci rappresenta uno dei lineamenti dell’opera, e ci invita a leggerla. Chi si lascia sedurre dalle indicazioni sulla copertina e compera il libro fa un ottimo affare.
Rampini ci guida alla riscoperta di un continente che una spessa incrostazione di stereotipi ci impedisce di capire nella sua realtà, multiforme e contradditoria. Un terra dove la povertà è ancora diffusa ma in calo, ricca di risorse naturali e di energie, con aree di miseria ed economie in sviluppo e mercati in espansione, contesa da Usa, Cina, Russia, India e che noi europei vediamo solo attraverso le immagini di migranti sui barconi, della gente che fugge dalle fame e dalle guerre. Con la prospettiva di un’invasione dell’Europa, prospettiva che alcuni considerano con favore e altri con terrore. E che Rampini dimostra irrealistica.
Come irrealistica, e paternalistica, eurocentrica, è la convinzione di parte della cultura occidentale che i mali di cui l’Africa soffre siano tutti conseguenze dell’epoca coloniale e postcoloniale. Questo tema non solo è uno degli assi portanti dell’opera di Rampini ma è uno dei più ricchi di demolizioni di stereotipi. Come quello della filiera della schiavitù: la vulgata corrente ci rappresenta i bianchi a caccia di schiavi nel cuore dell’Africa nera, per portarli incatenati sulla costa dell’Africa Occidentale, dal Dahomey alla foce del fiume Niger, e imbarcarli sulle navi negriere dirette verso le Americhe. Con scarsi e rari riferimenti al ruolo dei sovrani africani in questo commercio. Eppure erano proprio i regni costieri africani a organizzare le spedizioni di cattura.
“Lo schiavismo – scrive Rampini a proposito dell’americana Critical Race Theory che si concentra sul “razzismo sistemico” della società americana e delle sue istituzioni – viene studiato come un peccato originale del Dna degli Stati Uniti (…) evocare l’autonoma tradizione schiavista degli africani è un’eresia. Eppure “L’Africa ebbe i suoi imperi locali prima che arrivassero i nostri a conquistarla; i loro sistemi economici erano fondati sullo schiavismo (…) Come scrive lo storico Martin Meredith in The Fortunes of Africa, lo schiavismo era un tratto distintivo di molte società africane da quando ne esiste traccia” (p. 63). E “La globalizzazione del traffico di schiavi dal continente nero si verifica durante il IX secolo (…) Gli arabi si erano inseriti a loro volta in tale tradizione, diventando intermediari nel business schiavista in un continente nero dove la loro influenza era poderosa (…) Gli europei e poi i loro discendenti americani continueranno comunque a controllare solo una parte del business schiavista, insieme con gli arabi: l’acquisto, il trasporto e la consegna con vendita ai proprietari finali. La cattura iniziale degli schiavi continuerà a essere gestita perlopiù dagli africani stessi, signori della guerra, capitribù, trafficanti locali, gli eredi di una tradizione di schiavismo millenaria”. (p. 64-65).
Alcune demolizioni di stereotipi effettuate dall’autore nelle 328 pagine del libro sono anche divertenti, come quella della “Cleopatra black” imposta dalla Hollywood politically correct: Netflix aveva deciso di fare della regina egiziana un’eroina dell’African Pride, impersonata dall’attrice black Adele James. Ma questo “antirazzismo totalitario versione 2023”, come lo definisce Rampini (p. 74) in Egitto ha suscitato indignazione a ogni livello, provocando un incidente diplomatico e un rigetto di massa. L’Egitto di oggi è una società multietnica, con egiziani di pelle chiara e di pelle scura (e comunque Cleopatra, della stirpe regnante dei Tolomei di origine ellenistica, era bianca). Sono state anche avviate azioni legali per vietare l’accesso a Netflix sul territorio nazionale.
Il conformismo e l’ignoranza della storia da parte dei dirigenti di Netflix, convinti di compiere un’opera virtuosa, oltre che redditizia, è importante come segno di un atteggiamento diffuso nella cultura occidentale nei confronti dell’Africa. Un atteggiamento che danneggia tanto l’Occidente quanto gli africani. Settant’anni di aiuti all’Africa, in parte ispirati dal rimorso, hanno prodotto nel continente corruzione, deresponsabilizzazione, inefficienza, mettendo in difficoltà i produttori locali e arricchendo classi dirigenti parassitarie e corrotte.
Il colonialismo non è un male incancellabile, in Africa ci sono paesi come Seychelles, Muritius, Botswana che hanno che hanno avuto risultati positivi sul piano economico, come anche, nonostante i loro punti di debolezza, Gabon, Malawi, Guinea Bissau. Per non parlare di ex colonie non africane, come Singapore… Un fenomeno che non deve indurci a facili ottimismi ma che confuta la visione di un intero continente afflitto dalla miseria, perlopiù causata dallo sfruttamento da parte dei bianchi.
L’episodio di Cleopatra black riguarda la sfera dei “diritti”, che per gli americani comporta l’imposizione dei gender rights, compreso il diritto di modificare il proprio orientamento sessuale e che gli africani vedono spesso come una minaccia ai loro sistemi di valori tradizionali. Per una buona parte delle classi dirigenti africane questo è un altro modo di praticare il neocolonialismo: l’imperialismo dei valori” (p. 137). Cina e Russia non hanno questi problemi. E non li hanno neppure in un ambito economicamente strategico, quello dell’ambientalismo e dello sfruttamento delle risorse naturali.
Il capitolo VIII “L’ambientalismo dei ricchi visto dal Sud” è fondamentale. Ci fa riflettere non solo sull’assurdità di imporre la decarbonizzazione immediata, la rinuncia al nucleare e perfino all’idroelettrico (niente dighe! Turbano l’equilibrio ecologico) a popoli che stanno uscendo o cercano di uscire dalla povertà, raccomandando loro l’agricoltura biologica e la decrescita felice, ma ci mette in guardia dai pericoli che corre la nostra economia con l’imposizione a breve termine dell’auto elettrica, che comporterebbe la nostra dipendenza dalla Cina, quasi monopolista delle materie prime, come il litio, necessarie per le batterie. Quasi monopolista almeno per ora, perché i governi dei paesi dove i cinesi si riforniscono stanno pensando di riconquistare il controllo delle loro risorse minerarie. Ma la Cina è anche produttrice di pannelli solari e impianti fotovoltaici. E, come l’India, è grande consumatrice di carbone e non ha nessuna intenzione di metterlo al bando, né a breve né a lungo termine. Se consideriamo che la produzione (e lo smaltimento) di batterie e l’estrazione di cobalto e litio comporta costi ambientali che in gran parte sfuggono al nostro controllo, c’è da domandarsi se il colpo inferto alla nostra industria (non solo a quella dell’auto, pensiamo alle acciaierie europee) sia compensata da effettivi vantaggi ambientali.
Per quanto riguarda l’Africa, in ogni caso, l’ambientalismo dottrinario viene imposto non solo dai governi di Usa e Ue e da istituzioni internazionali come la Banca Mondiale ma anche in pratica dalle banche e dagli altri istituti finanziari che introducono i parametri green nelle valutazioni del merito creditizio. “Agli occhi degli africani colti – sottolinea Rampini – che sanno guardare oltre le apparenze e la propaganda, la nostra infatuazione per l’auto elettrica è discutibile: sanno di quali materiali è composta una batteria elettrica, visto che in parte vengono estratti dal loro sottosuolo, con processi che comportano abbondanti emissioni di CO2”.
Al contrario Cina e Russia non impongono nulla, badano ai loro affari.
Forse la nostra politica energetica va ripensata. Rampini cita Larry Fink − capo del più grande fondo di investimento americano, BlackRock − che, dopo essere stato per anni il guru della “finanza sostenibile” Esg a Wall Street, di colpo ha ammesso: ‘Quello che avevo detto contro il carbone era sbagliato. Disinvestire dalle energie fossili è un errore‘”.