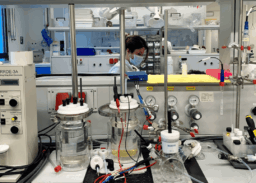Le professioni sono in costante evoluzione, ma con l’arrivo di big data e intelligenza artificiale è ancora più necessario avere come punto di riferimento la deontologia professionale e per questo i geologi si sono confrontati nella sede Camera di Commercio di Genova nel seminario formativo “Il ruolo del geologo tra etica, competenze e welfare professionale: dal sapere alla tutela”, promosso dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria con il patrocinio della stessa Cciaa, del Consiglio Nazionale dei Geologi e dell’Epap, la cassa previdenziale.

Il seminario ha affrontato questioni cruciali per la categoria: dalla sostenibilità ambientale alle pari opportunità, dalla normativa sui contratti pubblici al principio dell’equo compenso, fino alla programmazione previdenziale. Proprio sull’equo compenso il presidente dell’Ordine ligure Alessandro Scarpati, spiega: «C’è molto lavoro da fare per i geologi, che, bisogna ricordare, devono essere pagati in modo equo, dignitoso e rispettoso del lavoro che si fa che è di grossa responsabilità».
Scarpati, da poco diventato presidente, impronterà parte del suo mandato sul tema della geoetica, che comprende e studia tutte le implicazioni etiche, sociali e culturali che le scienze della Terra portano con sé. Quindi i rischi naturali e antropogenici, le risorse naturali e la sostenibilità, l’inquinamento e i cambiamenti climatici, la salvaguardia della geodiversità e del patrimonio naturale, ma anche l’educazione e la comunicazione delle geoscienze, l’integrità della ricerca e, soprattutto, il ruolo della scienza e degli scienziati nella trasmissione delle conoscenze scientifiche che influenzano la vita dei cittadini.
«La terra è stata un po’ violentata − dice Scarpati − anche se negli ultimi anni rileviamo una maggiore attenzione a tutte queste problematiche. È da almeno 20 anni che non si costruisce più nelle aree a rischio dei corsi d’acqua, nelle aree inondabili, nelle aree a rischio di frana. Ci sono dei vincoli urbanistico-edilizi. Si è fatto molto, ma tanto c’è ancora da fare. Per questo è che vogliamo spingere su questo argomento».
La categoria oggi, con le nuove tecnologie ha anche esigenze di formazione continua, per interpretare tutti questi dati: «Assolutamente sì. Oggi sono tantissimi i dati su cui si poggia la città, ma anche l’ambiente naturale e bisogna saperli leggere, saperli interpretare e utilizzarli per prendere delle decisioni. Ora, chiaramente oggi il nostro territorio è monitorato in modo importante, in tempo reale. Sono monitorate situazioni di pericolosità, come le piogge e i livelli idrometrici dei corsi d’acqua».
Il consiglio dei geologi: come attuare difesa del suolo e prevenire allagamenti con piccole opere
In caso di evento intenso e anche breve il sistema reagisce in modo veloce. «Qui in Liguria è il posto dove bisogna agire, siamo forse in Italia la situazione più difficile, dove bisogna agire in tempi brevissimi», ricorda Scarpati, che è comunque ottimista: «C’è un miglioramento di tutto il sistema, le norme che ci coinvolgono, ma anche l’attenzione della popolazione su certe tematiche, la consapevolezza. Le cose sono migliorate molto. Certo che è sempre poco. Faccio un esempio: nei primi anni del 2000 sono stati adottati i piani di bacino. Facevano una fotografia delle zone inondabili sul territorio. Oggi, se guardiamo queste carte, non sono diversissime da allora, dovrebbero essere diventate bianche in 20 anni, di interventi in cui metti a posto i corsi d’acqua. Non è così. Si sono un po’ ridotte, la situazione è migliorata, però c’è ancora tantissimo da fare. Per cui voglio essere ottimista, ma dico anche che c’è ancora tanto da fare per cui bisogna impegnarsi. Poi c’è tutta la tematica di questi eventi brevi e intensi».
Il problema è che le città sono ormai diventate delle distese impermeabili. Quali consigli possono dare i geologi? «Fare in modo che le acque vengano rallentate nel finire nelle fognature, quindi serve più verde: tetti verdi, coperture verdi, vasche di accumulo, c’è tutta una gamma di interventi che all’estero è già una prassi, mentre purtroppo qui in Italia siamo indietro, sia a livello di lavori pubblici sia di lavori privati. Pensiamo ai condomìni. È chiaro che se cominciassero a fare i tetti verdi, l’acqua che cade in copertura non finirebbe direttamente nella fognatura. E poi il tetto verde porta dei benefici anche di altro tipo, dal punto di vista energetico dell’edificio, della biodiversità, del microclima, quindi è sicuramente un qualcosa che va a favore della salute e della sicurezza».
Scarpati cita la Città metropolitana di Milano che ha speso 50 milioni di finanziamenti Pnrr per interventi di “città spugna”: «Tolgono le pavimentazioni, quindi aumentano la permeabilità del suolo, realizzano vasche. L’Italia è indietro, ma stiamo iniziando anche noi su questo discorso. A Genova per esempio il parcheggio dell’Ikea non è asfaltato, ma realizzato con delle strutture permeabili su cui si può tranquillamente parcheggiare. Segnalo che tutti gli anni c’è un bando che scade a ottobre, che mette a disposizione parecchi soldi in tutto il Paese, anche in Liguria. È un bando che finanzia la depavimentazione, il famoso depaving che in certe località degli Stati Uniti è diventato quasi una filosofia. In Olanda fanno le gare a chi toglie più pavimentazioni. Il depaving è una tecnica che consente di aumentare la permeabilità dei suoli. Non è che lasci brullo o l’erba, ma realizzi delle cose permeabili».
Non solo problemi idrogeologici: Pfas e Radon
E poi c’è tutto il tema della salute: il geologo, l’ha detto anche il presidente nazionale, ha un ruolo sociale rivolto alla sicurezza e alla salute del cittadino: «Ultimamente sentiamo sempre parlare di Pfas nelle acque, è una delle novità che più ci preoccupa per la nostra salute».
I Pfas sono composti che, a partire dagli anni cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno però conseguenze negative sull’ambiente e a causa della loro persistenza e mobilità, questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi.
L’altro nemico nascosto è il Radon: «Siamo attentissimi alla problematica, faremo un convegno nei primi mesi del 2026, in cui incontreremo i politici, perché il gas Radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Ed è un gas inodore, insapore, che c’è anche in Liguria. È un gas che arriva dal sottosuolo, è presente nelle rocce che contengono delle percentuali di uranio, quindi decadimento dell’uranio, decadimento radioattivo. Le regioni in Italia che hanno questa problematica in misura maggiore sono il Lazio, la Campania e la Lombardia. Noi meno, ma non è un tema da trascurare. Ovviamente il gas Radon si riscontra nei locali interrati, nei piani terra. Adesso l’Arpal sta facendo delle misurazioni negli ultimi due anni, quindi immagino che nei primi mesi del 2026 rendano noti questi dati. Laddove si riscontra Radon ci sono delle tecniche per mitigare il problema. Però bisogna conoscerlo e noi vogliamo fare un’iniziativa insieme ai medici per sensibilizzare la popolazione su questa tematica. Perché effettivamente non si conosce».
Miniere di nuovi materiali e l’interesse della politica
Le cosiddette terre rare oggi sono in cima agli interessi politici di giganti come Usa, Russia, Cina. Anche l’Italia ha redatto un Pnr, il Piano Nazionale Estrazione e per la Liguria sono previste delle indagini sulla grafite in Valle Bormida e su rame e manganese nel Levante Ligure. «Per fortuna ha escluso la miniera di rutilo, ossia titanio, del Beigua − chiarisce Scarpati − questo è un esempio geoetico. Non si fa una miniera in un geoparco. Si valuterà invece l’altro discorso tenendo anche presente che nel Levante Ligure c’è anche una problematica legata ai rifiuti estrattivi che sono già esistenti, che rappresentano un problema per l’ambiente e che rappresentano anche una risorsa. Per cui, tra le tante cose che vogliamo fare nell’anno a venire, è anche un convegno su queste tematiche di attività estrattive coinvolgendo l’università e valutando i pro e i contro dal punto di vista economico, gli impatti ambientali e gli impatti sul paesaggio». La conoscenza del geologo potrebbe dunque servire e parecchio agli appetiti economici degli Stati ed è anche qui che si inserisce la geoetica.
La geoetica
Silvia Peppoloni, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e fondatrice dell’International Association for Promoting Geoethics che oggi ha 38 sedi in tutto il mondo, spiega: «In La geoetica cresce al crescere delle responsabilità del geologo. Il mondo cambia, le sfide ambientali sono sempre più complesse, la transizione energetica, il cambiamento climatico sono tutti argomenti in cui il geologo entra in prima persona, lo sappiamo bene, quindi al crescere di questa complessità ovviamente crescono le nostre responsabilità. Anche nell’uso delle tecnologie emergenti, dai sistemi informativi geografici fino all’intelligenza artificiale e big data, le nostre responsabilità cambiano e dobbiamo considerare nuovi doveri etici, come pure nel campo della comunicazione, della trasparenza, nel dialogo con le comunità locali». Il geologo influenza le catene decisionali per questo, secondo Peppoloni, la geoetica non è una moda, un’utopia, un accessorio: «È qualcosa che può guidarci nelle nostre scelte e nel nostro lavoro professionale quotidiano. È importante essere consapevoli che manovrare, utilizzare i dati dà delle responsabilità. Questi dati chi li utilizza? Come devono essere immagazzinati, comunicati, gestiti? Quale la loro provenienza? Bisogna garantire che siano sicuri, che non vengano utilizzati al di fuori dell’ambito attinente».
In ambito terremoti non c’è ancora la possibilità di previsione, ma sicuramente l’intelligenza artificiale consentirà di facilitare gli studi di certi eventi e anche rileggere la storia degli eventi, ma occorre ricordare anche che «questi discorsi vanno fatti anche a livello globale, perché c’è bisogno di standard».
A livello deontologico non c’è ancora una carta ufficiale sull’intelligenza artificiale, ma la commissione di geoetica dell’International Union for Geological Sciences, di cui Peppoloni è presidente, è stato creato un gruppo di lavoro che ha redatto delle linee guida su l’etica e l’intelligenza artificiale nelle geoscienze a cui hanno lavorato filosofi, esperti legali, geoscienziati, geologi ed esperti di intelligenza artificiale.