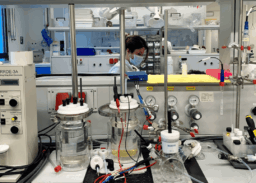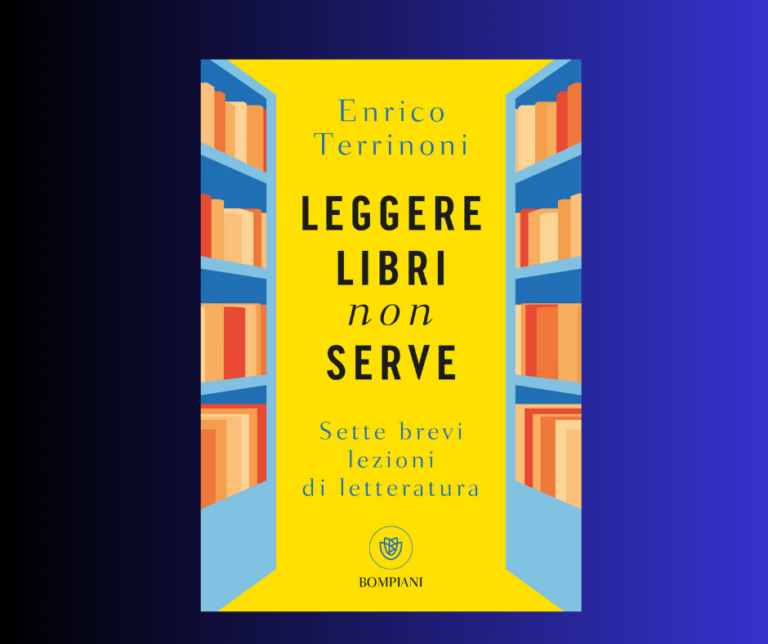“Leggere libri non serve-Sette brevi lezioni di letteratura” di Ennrico Terrinoni, pubblicato da Bompiani, è un titolo chiaramente paradossale e provocatorio. Leggere libri in realtà serve. Ma a che cosa? Non fa guadagnare e non fa fare carriera. Incontriamo sempre più spesso la figura dell’alto dirigente d’azienda e persino dello scienziato ignorante, che conosce tutto il conoscibile della sua disciplina ma è evidente che non ha letto neppure Pinocchio. Leggere libri al massimo può aiutare a essere brillanti in una compagnia di persone che i libri non li leggono ma conservano una sorta di timore reverenziale per la “cultura”. Magra soddisfazione, e pi queste persone sono sempre meno. No, la funzione, l’”utilità” del leggere è di altra natura: spiega Terrinoni, ci apre nuovi mondi, alimenta la nostra immaginazione e la nostra coscienza, ci aiuta a sviluppare il nostro senso critico: chi conosce altre realtà (anche immaginarie) oltre a quella della sua vita quotidiana ha gli strumenti intellettuali per chiedersi se e quanto sia bella e giusta la realtà in cui si trova immerso e se sia possibile cambiarla.
Per mostrarci la libertà che con la lettura possiamo conquistare Terrinoni ci guida in un viaggio attraverso la storia della letteratura, attraverso sette parole legate ciascuna a un autore: La profezia di Oscar Wilde, Il sogno ovvero William Blake, L’infinito ovvero James Joyce, L’eresia ovvero Giordano Bruno, la coscienza ovvero Italo Svevo, L’onda ovvero Virginia Woolf, Il silenzio ovvero William Shakespeare. Non si tratta di prescrizioni ma di suggestioni che aprono altri mondi. I sette autori diventano decine. Perché ciascun autore è collegato a molti altri, ognuno è il nodo di un’immensa rete che non ha confini. Così seguiamo l’autore lungo percorsi – almeno per alcuni di noi – sorprendenti, come quelli che ci fanno incontrare Shakespeare connesso con Giordano Bruno, Svevo con Joyce. Sentieri che davvero ci aprono mondi nuovi e ci mostrano il rapporto tra arte e scienza.
Di grande valore, a nostro avviso, è il post scriptum “Navigare tra letteratura e scienza” che invita a non assuefarci alla crescente distanza tra scienza e arti, e cita una lettera di Einstein del 4 maggio 1939 in cui leggiamo “Vedo una somiglianza tra l’attività scientifica e quella artistica. Entrambe tentano di assemblare, partendo dalle singole parti, un insieme che è di per sé indistinto in modo che l’ordine che ne risulta crei distinzione e chiarezza… Ciò accade nella scienza e nell’arte. Nella scienza il principio di ordine che crea le unità viene ottenuto attraverso le connessioni logiche, mentre nell’arte il principio di ordine è ancorato all’inconscio”.
La somiglianza di cui scrive Einstein viene esplicitata in “Leggere libri non serve” , dove le concezioni oscillatorie della coscienza evocano la fisica quantistica, pensiamo a Joyce e Svevo. Forse la letteratura ci dice qualcosa non solo del mondo interiore ma anche della realtà che ci circonda. Scienza e arte, scrive Terrinoni (pag. 161) sono percorsi paralleli “facenti parte di un campo condiviso, una rete di relazioni che in qualche modo questi percorsi li fa intrecciare per indicarne di nuovi e immaginare inattese vi di fuga. Se è vero, infatti, che secondo la cosiddetta interpretazione relazionale della quantistica ogni cosa è ‘solamente il modo in cui agisce su qualcos’altro’, e anche che ‘le caratteristiche di un oggetto sono il modo in cui esso agisce su altri oggetti’ (come ci ricorda Rovelli in Helgoland), allora possiamo pure postulare che la letteratura, fenomeno indefinibile per eccellenza, sia il modo in cui interagiamo con essa”.