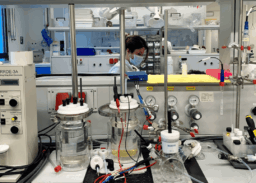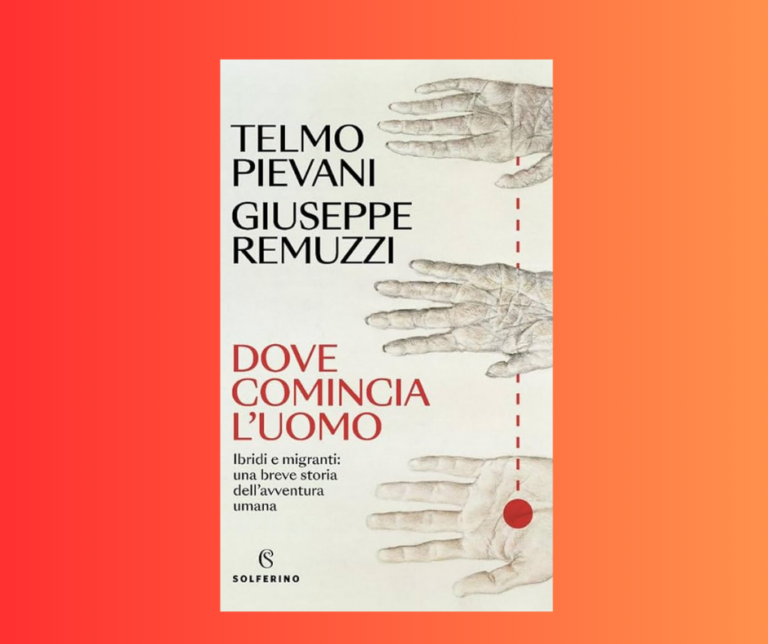“Dove comincia l’uomo – Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana” di Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, pubblicato pochi giorni fa da Solferino, fa il punto sulle scoperte dell’origine dell’Homo sapiens e sulle conseguenze di tali scoperte.
Nel primo ventennio del Duemila si è avuta una svolta rivoluzionaria negli studi sull’origine dell’umanità: scienziati come David Reich, Svante Pääbo (Premio Nobel per la medicicina nel 2022) e altri del Max Planck hanno messo a punto gli strumenti in grado di farci conoscere la genetica dell’antico Dna. Svante Pääbo ha sequenziato il genoma del Neandertal, nel 2009-2010. Da allora è una scoperrta continua. Oggi sappiamo che fino a circa 40 mila anni fa il mondo era abitato da vari gruppi umani arcaici che erano diversi da noi nel fisico ma condividevano tante delle nostre capacità. Tanto che con la nostra specie si sono ibridati. Che sono geneticamente vicini a europei, est asiatici e abitanti della Nuova Guinea più che alle popolazioni dell’Africa occidentale e ai San. Come ci si aspettava, visto che l’incontro è avvenuto in Europa e in Asia. Genomi Neandertal presenti nei Sapiens non africani attuali sono dell’1,5 – 2,1%.
Reich ha fatto il punto su quanto si sapeva al momento in cui ha scritto la sua opera, “Chi siamo e come siamo arrivati qui -Il dna antico e la nuova scienza del passato dell’umanità” (Raffaele Cortina Editore) pubblicata la prima volta nel 2018: in quel momento non esisteva un libro scritto da un genetista ancora in attività che illustrasse l’impatto della nuova scienza.
Il lavoro di Pievani e Remuzzi, pubblicato sette anni dopo quello di Reich riassume le scoperte di queste ultimi anni.
“Per noi oggi è quasi impossibile – si legge nel loro libro – immaginare un essere umano ibrido, ma in passato fu per lungo tempo la norma (…) Siamo figli delle ibridazioni tra una molteplicità di specie umane. Non sono esistiti solo il Sapiens e il Neanderthal, si sono trovate tracce di Denisova, Homo Floriensensis, Homo luzoniensis. “Tirando le somme, specie umane ancora coabiatavano sulla terra fino a poche decine di millenni fa. Non eravamo soli. L’evoluzione umana è una storia plurale. E queste specie umane si sono ibridate tra loro” e con la nostra specie”. (Almeno due di esse, Neanderthaliani e Denisoviani).
“Dove comincia l’uomo” ci spega che l’80% della popolazione tibetana di oggi ha ereditato dai Denisoviani una variante genetica che favorisce l’adattamento alla mancanza di ossigeno in altitudine. Ibridarsi può fare bene. Ma anche male. Secondo i due studiosi la predisposizione al diabete, la tendenza alla trombosi, certe alterazioni del ritmo cardiaco sono tutte cose che ci vengono dai Neanderthal. Come anche determinati geni che una volta forse proteggevano i Neanderthal dalle infezioni e nella popolazione moderna dei Sapiens producono un eccesso di a risposta immunitaria al Covid. D’altra parte abbiano preso dai Neanderthal la capacità di fare coagulare il sangue che cola dalle ferite piuttosto rapidamente e la riduzione di episodi di sanguinamento durante la prima fase della gravidanza, il che comporta più fertilità e meno aborti.
Il libro di Pievani e Remuzzi è davvero “una breve storia dell’avventura umana”: ci racconta l’avventura dell’uomo, accidentata e imprevedibile, tra migrazioni, ibridazioni, cambiamenti climatici, e cerca di interpretare le tendenze evolutive in atto, le sfide per la salute e l’abiente, gli scenari futuri.
Fa luce per il pubblico non specialista sulle nozioni acqusite e invita a riflettere sulle conseguenze delle noste azioni. Leggerlo è come viaggiare nei millenni. Un’avventura eccitante. Ma il suo fascino profondo, come quello del libro di Reich e, pensiamo, di altri pubblicati o da pubblicare sull’argomento, sta nel punto primigenio: la scoperta che c’è continuità tra l’uomo e altri esseri, che non erano Homo sapiens ma in qualche modo erano umani. Il che induce a porsi la domanda cruciale e inquietante: in fondo, chi sono i veri esseri umani?
È la domanda, per esempio, che ci inquieta lungo tutto lo svolgimento di un capolavoro del cinema, “Blade runner”, in cui si confrontano esseri umani e replicanti, due entità distinte e simili. La domanda trova una risposta negli ultimi istanti del film: dopo uno scontro violento in cui l’uomo, Rick Deckard (Harrison Ford) ha avuto la peggio, e il replicante, Roy Batty (Rutger Hauer), recita il monologo che è rimasto uno dei più celebri nella storia del cinema, Deckard conclude con una riflessione: «Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l’avesse mai amata… Non solo la sua vita: la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo: “Da dove vengo?” “Dove vado?” “Quanto mi resta ancora?” Non ho potuto far altro che restare lì e guardarlo morire».