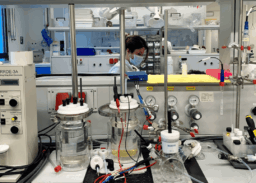“I sonnambuli– Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra” di Christopher Clark è stato pubblicato la prima volta nel 2012 (“The Sleepwalkers- How Europe Went in the War in 1914”, Allen Lane, an imprint of Penguin Boooks). Non è quindi una novità ma dagli scaffali delle librerie, nell’edizione Laterza, in questi giorni il libro con il suo titolo colpisce per la possibile, inquietante analogia tra le vicende che nell’estate del 1914 portarono al conflitto mondiale e quelle in cui sono coinvolte Russia e Ucraina: non c’è il rischio che, passo dopo passo, incoscienti come sonnambuli, anche oggi i governi ci stiano portando verso un’altra catastrofe epocale?
 Il rischio c’è ma per fortuna oggi la situazione internazionale è molto diversa da quella di fine dell’Ottocento-inizio del Novecento e ce lo dimostra proprio il lavoro di Clark, una dettagliata, accuratissima ricostruzione degli eventi e di come statisti e opinion maker di allora li interpretarono. Ma i “Sonnambuli” sono un’opera di grande interesse per un altro motivo: fa giustizia di un comodo luogo comune imposto dai vincitori della Grande Guerra e dominante ancora oggi. Il conflitto che provocò stragi immense, e aprì la strada all’affermarsi di fascismo, nazismo, comunismo sarebbe stato “colpa” esclusivamente della Germania e dell’Austria-Ungheria. È la versione, imposta dai vincitori (e codificata nell’articolo 231 del Trattato di Versailles che recita: «I Governi Alleati e Associati dichiarano e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi Alleati e Associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall’aggressione della Germania e dei suoi alleati».). I rappresentanti dei Paesi sconfitti furono autorizzati solamente ad assistere alla Conferenza. Potevano, come accadde, solo accettare le decisioni prese. A questa interpretazione delle cause della guerra, che giustificava una pace punitiva e autorizzava le potenze vincitrici a cercare di ottenere vantaggi territoriali ed economici, aderirono negli anni Sessanta, anche intellettuali tedeschi che, condannando l’eredità del passato intendevano condannare presunti lasciti di quell’eredità nella cultura contemporanea del loro Paese.
Il rischio c’è ma per fortuna oggi la situazione internazionale è molto diversa da quella di fine dell’Ottocento-inizio del Novecento e ce lo dimostra proprio il lavoro di Clark, una dettagliata, accuratissima ricostruzione degli eventi e di come statisti e opinion maker di allora li interpretarono. Ma i “Sonnambuli” sono un’opera di grande interesse per un altro motivo: fa giustizia di un comodo luogo comune imposto dai vincitori della Grande Guerra e dominante ancora oggi. Il conflitto che provocò stragi immense, e aprì la strada all’affermarsi di fascismo, nazismo, comunismo sarebbe stato “colpa” esclusivamente della Germania e dell’Austria-Ungheria. È la versione, imposta dai vincitori (e codificata nell’articolo 231 del Trattato di Versailles che recita: «I Governi Alleati e Associati dichiarano e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi Alleati e Associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall’aggressione della Germania e dei suoi alleati».). I rappresentanti dei Paesi sconfitti furono autorizzati solamente ad assistere alla Conferenza. Potevano, come accadde, solo accettare le decisioni prese. A questa interpretazione delle cause della guerra, che giustificava una pace punitiva e autorizzava le potenze vincitrici a cercare di ottenere vantaggi territoriali ed economici, aderirono negli anni Sessanta, anche intellettuali tedeschi che, condannando l’eredità del passato intendevano condannare presunti lasciti di quell’eredità nella cultura contemporanea del loro Paese.
La lettura del libro di Clark dimostra che il tema della colpa è ben più complesso. “Lo scoppio della guerra – si legge a pag. 604-605 – non è un episodio di una dramma di Agatha Christie, alla fine del quale si scopre il colpevole con la pistola ancora fumante accanto a un cadavere. In questa storia non ci sono pistole fumanti, o piuttosto, ognuno dei personaggi principali ne ha in mano una. Se la guardiamo da questa prospettiva, lo scoppio della guerra fu una tragedia non un delitto con un colpevole (…) I tedeschi non erano i soli imperialisti e non erano gli unici a essere in preda a ossessioni paranoiche. La crisi che portò alla guerra nel 1914 fu il frutto di una cultura politica condivisa, ma fu anche multipolare e con elementi realmente interattivi: è questo che ne fa l’evento più complesso dell’epoca contemporanea, ed è per questo che il dibattitto sulle origini della Prima guerra mondiale continua ancora oggi, un secolo dopo i fatali colpi che Gavrilo Princip sparò sulla via Franz Josef”.
Clark ci mostra i comportamenti e le motivazioni di quei “sonnambuli apparentemente vigili ma non in grado di vedere, tormentati dagli incubi ma ciechi di fronte alla realtà dell’orrore che stavano per portare nel mondo”. Ma quei sonnambuli si muovevano in una notte cupa, la temperie spirituale di allora. Una temperie spirituale che spiega l’entusiasmo con cui una parte dei giovani intellettuali dell’epoca si gettò in quella festa di morte. (Soltanto una parte, costituita da studenti, professori, giornalisti, scrittori, politici minoritaria ma in grado di farsi sentire. La guerra era attesa, anche in Italia, non solo da nazionalisti-imperialisti di ciascun Paese, e da liberaldemocratici e massoni che si aspettavano dal crollo degli imperi centrali la liberazione dei popoli e la nascita di un’Europa democratica, ma da un fronte ben più ampio ampio e variegato comprendente anarchici e socialisti rivoluzionari – come Mussolini per esempio – che vedevano in un grande conflitto l’occasione per distruggere l’ordine costituito, esteti amanti della guerra in sé e chi detestava la prospettiva di benessere e di vita pacifica e fiduciosa nell’idea di progresso dischiusa dalla Belle Époque. L’umanità descritta da Nietzsche non aveva sostituito il Dio che aveva ucciso, o lo aveva sostituito con degli dei minori, ed era ben lontana dall’affermazione dell’Oltre-Uomo. Era insoddisfatta, confusa, impaurita, intollerante e aggressiva.
A capire gli umori di allora, ci aiuta la letteratura. Thomas Mann, nella “Montagna incantata” (ed. Corbaccio, 2011, p. 644) in una descrizione degli ospiti del sanatorio che rappresentano l’Europa scrive: «Cosa aleggiava nell’aria? – Smania di risse. Irritazione con minaccia di crisi. Indicibile impazienza. Tendenza generale a battibecchi velenosi, a scoppi di collera, persino alla zuffa. Litigi accaniti, incontrollati diverbi sbottavano ogni giorno tra individui o interi gruppi, ed era significativo il fatto che i non implicati, invece di essere nauseati dallo stato dei furiosi e di interporsi, partecipavano con simpatia, e mentalmente si lasciavano prendere dal delirio. I loro occhi mandavano lampi aggressivi, le labbra si torcevano con furore. Invidiavano agli scatenati il diritto, l’appiglio di gridare. Una trascinante voglia d’imitarli torturava il corpo e l’anima; e chi non aveva la forza di rifugiarsi nella solitudine era irrimediabilmente tratto nel vortice».