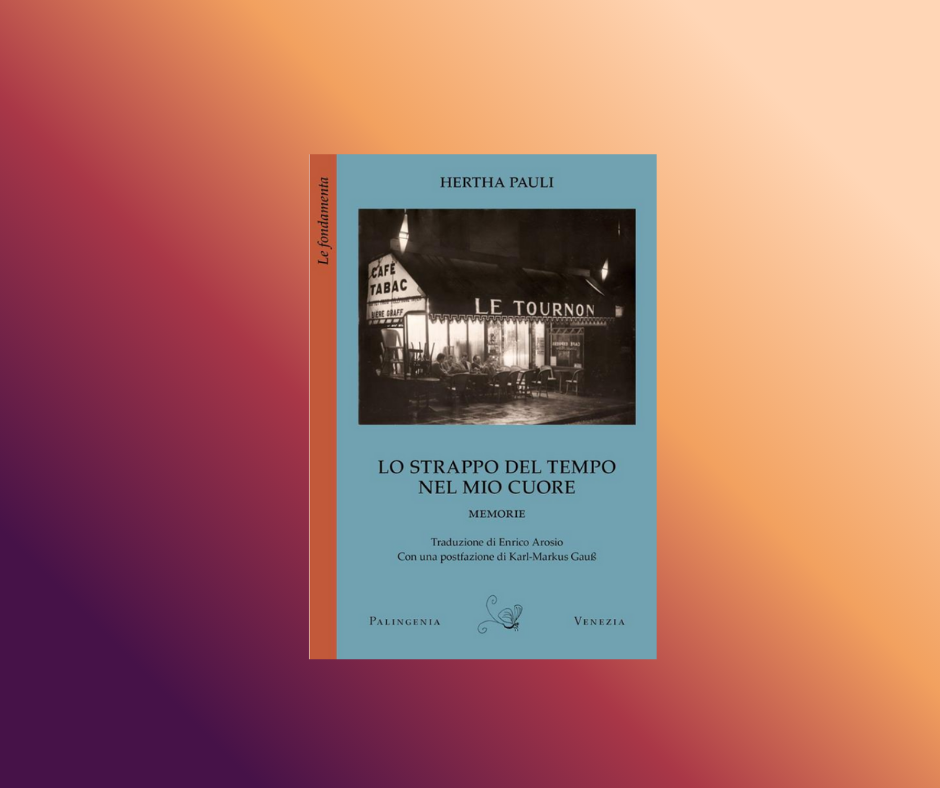Il caso del granchio crocifisso – specie originaria dell’oceano Indiano – catturato da un pescatore pochi giorni fa al largo della Lanterna (vedi qui) non è un avvenimento isolato: l’episodio fa parte d’un più ampio fenomeno che ha conseguenze di tipo ecologico e anche economico.
Se i primi ritrovamenti insoliti si sono verificati già a partire dagli anni Cinquanta, con l’intensificazione delle rotte commerciali transatlantiche e delle attività di pesca commerciale, oggi il problema si è fortemente accentuato. Scarico delle acque di zavorra, fouling (l’incrostazione che aderisce alla chiglia delle imbarcazioni) o dispersione di residui sulle reti da pesca, acquacoltura, acquariofilia e non ultima la migrazione spontanea attraverso gli stretti di Suez e Gibilterra sono le cause più frequenti di queste “invasioni”. Trattandosi di un trend in rapida evoluzione, però, i suoi fattori non sono sempre e chiaramente individuabili.
A settembre 2021, l’Ispra ha stimato la presenza di circa 280 specie aliene nel Mediterraneo, oltre a 70 di provenienza incerta, e dunque definite criptogeniche. Il cambiamento climatico e il conseguente aumento della temperatura dell’acqua nel Mediterraneo, lo rendono sempre più adatto a ospitare pesci, molluschi, artropodi e alghe provenienti da ecosistemi di clima tropicale o atlantico.
Alcune specie aliene risultano sostenibili e prive di effetti collaterali sull’ecosistema ospite, dove riescono a integrarsi. Altre sono invasive e possono danneggiare il loro nuovo ambiente in modo irreparabile. E spesso risultano dannose per le attività economiche. Un caso significativo è quello della Caulerpa taxifolia, un’alga originaria del mar Cinese meridionale e della Guinea. Adatta ad acque temperate calde, nel secolo scorso venne importata in Europa come complemento decorativo per gli acquari, sebbene risulti estremamente invasiva per le altre alghe e tossica per gli animali che se ne nutrono. Il suo rilascio accidentale nel Mediterraneo, dovuto allo scarico di acque reflue da parte del museo oceanografico di Monaco, ha tutt’ora effetti nefasti sulle specie nostrane. L’alga, che prospera nei fondali bassi e sabbiosi, risulta oggi particolarmente nociva per la vegetazione marina dell’Adriatico settentrionale, con una situazione critica sulla costa istriana. A farne le spese, sono tutti i gradini della piramide alimentare, non ultima l’orata, che assieme al branzino è la specie ittica più comunemente allevata nel Mare Nostrum.
E nel Mar Ligure? «Di recente, nel nostro mare la Caulerpa non ha causato danni molto consistenti agli allevamenti o agli animali in sé – spiega Daniela Borriello, referente regionale per la Liguria di Coldiretti Impresa Pesca –. Qui il danno riguarda sostanzialmente non gli allevamenti ma l’attività della pesca. È accaduto molto spesso che le reti da posta e più raramente da strascico dei pescherecci si siano riempite di queste alghe nocive. Una volta tirate a secco vanno pulite con cura: un lavoro impegnativo che richiede giorni, e tiene ferme le barche. In altri casi, le reti si sono rotte a causa del sovraccarico, e i pescatori hanno impiegato molto tempo a rammendarle. È un inconveniente che si è verificato abbastanza spesso».
«Fortunatamente – conferma Roberto Cò, titolare dell’allevamento ittico Aqua de Mâ – le nostre sedici gabbie, situate al centro del golfo di Lavagna, sono in acque abbastanza profonde da prevenire i danni causati dalla Caulerpa che meglio si adatta a fondali più bassi».
Sul tema Liguria Business Journal ha intervistato Laura Castellano, biologa e curatrice del dipartimento Mediterraneo per l’Acquario di Genova.
Quali dinamiche possono aver condotto il granchio crocifisso sulla costa genovese?
«Si possono fare solo ipotesi, difficili da verificare. Si pensa che, essendo un animale che vive nell’areale Indo-Pacifico e non presente nel mar Rosso, non sia passato spontaneamente attraverso il canale di Suez. Potrebbe essere stato attaccato a una chiglia; mentre è improbabile che sia stato rilasciato assieme alle acque di zavorra di una nave perché, a differenza di altre specie più minute, difficilmente sarebbe riuscito a passare attraverso le strette maglie dei filtri. È un predatore opportunista, che si nutre di altri macrorganismi, non sappiamo come possa essere sopravvissuto a una traversata simile. Non ne è mai stato ritrovato alcun esemplare nel Mediterraneo meridionale, per cui non è possibile sapere se la specie sia in condizioni ideali per la riproduzione».
Perché è morto, dopo il suo recupero?
«È morto dopo cinque giorni. Eppure, dopo essere stato preso in cura dall’Acquario, l’animale ha dimostrato un grande appetito, mangiando voracemente tutto quello che gli è stato dato; questo dimostra che non fosse in condizioni di stress tali da impedirne la sopravvivenza. Il fatto potrebbe essere imputabile allo sbalzo termico subìto. In questo periodo dell’anno, la temperatura media delle acque del mar Ligure si aggira attorno ai 13-14°, contro i 25° dell’Oceano Indiano, che ha un clima tropicale. Per cui, possiamo solo avanzare l’idea che l’animale non sia adatto alle temperature, relativamente fredde, del Mediterraneo. Ne sono stati rinvenuti solamente quattro esemplari in 18 anni; significa che evidentemente la specie non trova condizioni compatibili alla sussistenza e alla riproduzione. Ma anche in questo caso si tratta di supposizioni, che ancora non hanno trovato una conferma definitiva».
Come si diffondono le specie alloctone nel Mediterraneo?
«Parliamo di alcune centinaia di specie. Distinguiamo tra specie alloctone invasive e non invasive. Mentre le prime raggiungono in qualche modo l’ecosistema estraneo e vi si adattano, impiantandosi senza creare danni al suo interno, le altre si inseriscono in nicchie ecologiche già occupate da specie indigene, e per maggiore efficienza, capacità di adattamento e mancanza di predatori naturali, tendono a soppiantarle. Tendenzialmente, quando viene introdotta una specie priva di antagonisti e particolarmente efficiente in un ambiente diverso da quello d’origine, tende a creare danno. In questa tipologia rientrano per esempio il pesce palla, originario del Mar Rosso e ormai diffuso nell’Egeo, o il pesce scorpione, adattatosi ai climi del Mediterraneo inferiore. Altre specie non causano un danno ecologico rilevante, e addirittura vengono pescate, come nel caso di alcune specie di triglie. Vengono scoperte e rilevate nuove specie aliene in continuazione, ed è perciò difficile quantificare con esattezza scientifica l’impatto».
L’Acquario di Genova ospita specie alloctone?
«L’Acquario di Genova non si occupa di specie aliene in genere, poiché nel Mar Ligure ce ne sono ancora poche. Ospitiamo una specie di pesce trombetta, il pesce flauto o Fistularia Commersonii, pescata in Liguria alcuni anni fa. Si pensò che si fosse impiantata in Liguria, ma non essendoci stati ritrovamenti successivi, l’ipotesi è stata esclusa. Il Mar Ligure è particolare, con un fondale che diventa subito molto profondo per la scarsezza della piattaforma continentale e una ristretta fascia costiera, oltre ad avere temperature tendenzialmente più fredde che il resto del Mediterraneo. Inoltre, dagli studi effettuati nei porti liguri e toscani risulta che l’attività delle barche da diporto non possa aver avuto un forte effetto su queste dinamiche. Al contrario, l’ampliamento dello stretto di Suez può avere un ruolo nella questione. Più dei pesci, che possono provenire da Suez o da Gibilterra, alghe, briozoi, crostacei e tunicate, che spesso compongono il fouling».
(Nella foto di apertura: Carybtis feriata)