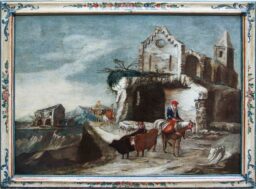«Chiunque vorrà ricostruire gli anni di piombo e misurare le devastazioni che quella grande ubriacatura produsse nella testa della nostra intellighenzia (inutile aggiungere “di sinistra”: quella di destra non è riconosciuta come intellighenzia) non avrà che da sfogliare questo libro-documento. Nomi e cognomi, c’è tutto quello che bisogna sapere, e che i citati vorrebbero invece dimenticare e far dimenticare. Ecco perché a suo tempo mi stupii che Brambilla avesse trovato un editore». La presentazione che del libro di Brambilla “L’eskimo in redazione” (Edizioni Ares) fece Indro Montanelli nel 1993 dice tutto. Il libro, però, nonostante lo stupore di Montanelli, non solo fu pubblicato, nel 1990, ma da allora ha avuto diverse riedizioni. L’ultima è recente e ci dà l’occasione di trattare di questo libro che è utilissimo per capire l’Italia degli anni Settanta – andrebbe regalato a chiunque non l’abbia letto e sia nato dopo i primi anni Cinquanta
 Libro spassoso, o irritante secondo i punti di vista, non tanto per le considerazioni, scarne e obiettive, che l’autore vi introduce ma per le citazioni in sé. Brambilla racconta che l’idea di scriverlo gli è venuta quando, da redattore del Corriere della Sera, stava cercando qualche vecchio articolo nell’archivio del giornale: «Mi colpì leggere le cronache degli anni Settanta. Mi colpì, per esempio, leggere che anche il delitto di Ramelli era stato definito “un delitto fascista”» (Ramelli era un militante dell’Msi).
Libro spassoso, o irritante secondo i punti di vista, non tanto per le considerazioni, scarne e obiettive, che l’autore vi introduce ma per le citazioni in sé. Brambilla racconta che l’idea di scriverlo gli è venuta quando, da redattore del Corriere della Sera, stava cercando qualche vecchio articolo nell’archivio del giornale: «Mi colpì leggere le cronache degli anni Settanta. Mi colpì, per esempio, leggere che anche il delitto di Ramelli era stato definito “un delitto fascista”» (Ramelli era un militante dell’Msi).
Gli argomenti principali presi in considerazione, intorno ai quali Brambilla agglomera la maggior parte delle citazioni sono le Brigate Rosse e i cosiddetti “anni di piombo, il rapporto del prefetto Mazza, la morte di Feltrinelli, l’assassinio del commissario Calabresi, quelli di Ramelli e Brasili, il ferimento di Montanelli, l’omicidio di Pasolini. Qui metteremo a fuoco il capitolo dedicato alle Br e agli anni di piombo perché ci sembra l’architrave del lavoro di Brambilla.
Negli anni Settanta, ci spiega l’autore, gli italiani furono ingannati dai nove decimi della stampa nazionale che chiamò «sedicenti» le Brigate Rosse e nascose e negò qualsiasi episodio di violenza di estrema sinistra. Almeno fino al delitto Moro. Perché lo fecero? Per conformismo. E in questo L’Eskimo in redazione è ancora attuale. Perché, scrive Brambilla nell’introduzione «lungi dall’essere un libro contro la sinistra, è un libro di denuncia di uno dei vizi mai morti nella nostra categoria: il conformismo. Negli anni Settanta sembrava che nulla potesse fermare le sorti magnifiche e progressive della sinistra: e la maggior parte dei giornalisti si allineò. Ma si allineò così come molti altri si erano già sdraiati e si sdraieranno poi, in periodi diversi, sulle posizioni del vincente di turno. Siamo il paese in cui si era tutti fascisti con il fascismo, tutti partigiani dopo il 25 aprile, tutti democristiani nella Rai degli anni Sessanta, tutti prima craxiani e poi anticraxiani, ecc…»
E oggi? Secondo Brambilla «non c’è più un pensiero unico … resta l’abitudine di accodarsi a un pensiero di moda. Resta il rinunciare alla propria libertà di critica per aderire aprioristicamente alla parte che si è scelta … perché sempre attuale è l’infezione di un giornalismo fazioso, spesso mosso da un banale interesse di bottega, cioè dalla necessità di baciare la pantofola a chi ci può garantire la pagnotta e magari pure la carriera».
Non era comunque soltanto la necessità di “guadagnarsi la pagnotta” a spingere tanti giornalisti a deformare la realtà che avevano il dovere di rappresentare nel modo più obiettivo possibile ai loro lettori, perché di “sedicenti Brigate Rosse” non scriveva soltanto la stampa di sinistra ma anche quella che allora veniva definita “borghese”. . Il fatto è che la sinistra godeva di un prestigio intellettuale, tanto immotivato quanto poderoso, tale da poter imporre le sue chiavi interpretative anche fuori del proprio recinto, anche nel campo avversario. Poi, una volta diventata egemone la versione dei terroristi di sinistra come fascisti mascherati o agenti provocatori, divenne difficile o anche pericolosa contrastarla e fu questione anche di pagnotta. O almeno di carriera.
Il primo esempio che riporta Brambilla è quanto scrive Giorgio Bocca sul Giorno, quotidiano di proprietà pubblica, il 23 febbraio 1975.
«A me queste Brigate Rosse – scriveva il famoso giornalista – fanno un curioso effetto, di favola per bambini scemi o insonnoliti; e quando i magistrati e gli ufficiali dei Cc e i prefetti ricominciano a narrarla, mi viene come un’ondata di tenerezza, perché la favola è vecchia, sgangherata, puerile, ma viene raccontata con tanta buona volontà che proprio non si sa come contraddirla». Secondo Bocca «Questi brigatisti rossi hanno un loro cupio dissolvi, vogliono essere incriminati a ogni costo, conservano i loro covi, le prove di accusa come dei cimeli, come dei musei. Sull’auto di Curcio, al momento dell’arresto, vengono trovati dei documenti, delle cartine; in un covo, intatto, c’è, si dice, la cella in legno in cui era prigioniero Sossi… E, naturalmente, bandiere con stelle a punte irregolari». (…) E allora, che cos’erano queste Br? «Una cosa è certa, le vigilie elettorali hanno per queste Brigate Rosse un effetto da flauto magico, due o tre note e saltano fuori nello stesso modo rocambolesco in cui sono scomparse». Conclusione: «Questa storia è penosa al punto da dimostrare il falso, il marcio che ci sta dietro: perché nessun militante di sinistra si comporterebbe, per libera scelta, in modo da rovesciare tanto ridicolo sulla sinistra».
Va notato che nel momento in cui Bocca scriveva quel pezzo, le Br avevano già compiuto una serie di gravi azioni, tra cui i rapimenti del dirigente della Siemens Idalgo Macchiarini, del sindacalista della Cisnal Bruno Labate, di Ettore Amerio, capo del personale del settore auto della Fiat, del sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi, avevano ucciso il 17 giugno ’74, a Padova, e, il 16 ottobre dello stesso anno 1974, a Robbiano di Mediglia, il maresciallo dei carabinieri Felice Maritano era rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con dei brigatisti. E il 9 settembre 1974 erano stati arrestati a Pinerolo due capi storici delle Br, Renato Curcio e Alberto Franceschini. Era difficile, a quel punto, non capire chi fossero le Br: i profili politici di Pietro Bassi e Roberto Ognibene, arrestati a Robbiano di Mediglia e soprattutto di Curcio e Franceschini, erano noti. Sarebbe bastato chiedere informazioni a polizia e carabinieri.
Anni dopo Bocca fece pubblica autocritica, ammettendo di «non avere capito niente».
Ma non fu certo un’eccezione. A un certo punto le Br furono considerate da alcuni addirittura come una specie di avanguardia violenta del movimento degli antidivorzisti in vista del referendum del 12 maggio. Quando nella primavera del ’74, venne rapito Sossi, molti giornali scrissero che il sequestro aveva lo scopo di favorire il fronte del sì! Tra questi il Corriere dell’Informazione, la Stampa, con Andrea Barbato, Panorama. E dopo il referendum, il 26 maggio 1974, Alberto Moravia scrisse sul Corriere della Sera che «il referendum o quello che vorremmo chiamare lo spirito del 12 maggio poterebbe far capire una buona volta agli italiani che essi hanno un mezzo potente per ricacciare indietro la società dei sequestri».
Le Br, con loro disappunto, rimasero “sedicenti” fino al delitto Moro. Eppure, dopo la cattura di Bassi, Ognibene, Curcio , Franceschini, il 5 giugno 1975, nello scontro a fuoco di Cascina Spiotta tra carabinieri e brigatisti era stata uccisa Mara Cagol, moglie di Curcio, nota se non altro nell’ambiente di Trento e dell’estrema sinistra, figura che non poteva certo essere considerata fascista o agente dei servizi segreti. Cagol, tra l’altro, aveva studiato alla Facoltà di Sociologia di Trento, rettore Francesco Alberoni. A lui aveva proposto la tesi: uno studio sulla “Qualificazione della forza lavoro nelle fasi dello sviluppo capitalistico”. Si laureò il 29 luglio del 1969 con 110 e lode e, conclusa la discussione, alzò il braccio sinistro con il pugno chiuso.
Pochi andarono controcorrente, scrive Brambilla, tra questi Indro Montanelli, naturalmente, Giampaolo Pansa, che molto più tardi susciterà scandalo raccontando delle vittime dei partigiani durante (e subito dopo) la guerra civile, Walter Tobagi, ucciso poi dai terroristi, come Carlo Casalegno.
Rimarrebbe molto da citare ma il lettore potrà vederlo nel libro di Brambilla.
Qui non ci resta che sottolineare un altro aspetto delle vicende di quei tempi. Conformismo e ottusità non avevano paralizzato soltanto i giornalisti ma anche politici, professori, architetti, filosofi, artisti, scienziati. Pensiamo a Sandro Pertini, che nel maggio 1974 a proposito dei brigatisti aveva dichiarato al Mondo: «Quando conosceremo i connotati di costoro scopriremo quello che si è già scoperto dopo la strage di piazza Fontana: una pista rossa diventata nera».
Brambilla cita una lettera aperta inviata da cinquanta esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo nell’ottobre 1971 al procuratore della Repubblica di Torino che aveva denunciato direttore e militanti per istigazione a delinquere.
Nella lettera tra l’altro si legge: «testimoniamo pertanto che, quando i cittadini da lei imputati…si impegnano a “combattere un giorno con le armi in pugno contro lo Stato fino alla liberazione dai padroni e dallo sfruttamento” ci impegniamo con loro».
L’autore riporta i nomi dei firmatari: Enzo Paci, Giulio A. Maccacaro, Elvio Facchinelli, Lucio Gambi, Marino Barengo, Umberto Eco, Paolo Portoghesi, Vladimiro Scatturin, Alberto Samonà, Lucio Colletti, Tinto Brass, Paolo Pernici, Giancarlo Maiorino, Francesco Leonetti, Manfredo Tafuri, Carlo Gregoretti, Giorgio Pecorini, Michele Canonica, Paolo Mieli, Giusepope Catalano, Mario Scialoja, Saverio Tutino, Giampaolo Bultrini, Sergio Saviane, Serena Rossetti, Franco Lefevre, Elio Aloisio, Alfredo Zennaro, Renato Izozzi, Giovan Battista Zorzoli, Cesare Zavattini, Bruno Caruso, Mario Ceroli, Franco Mulas, Emilio Garroni, Nelo Risi, Valentino Orsini, Giovanni Raboni, Luciano Guardigli, Franco Mogni, Giulio Carlo Argan, Alessandro Casillin, Domenico Porzio, Giovanni Giolitti, Manuele Fontana, Giuseppe Samonà, Salvatore Samperi, Pasquale Squitieri, Natalia Ginzburg, Tullio De Mauro, Francesco Valentini.
Nomi che, in gran parte, oggi ci sorprendono, per la statura intellettuale di alcuni, e per la promessa di “combattere con le armi in pugno” da parte di molti che avevano l’attitudine guerriera di un coniglio. Ma i tempi erano quelli. E gli intellettuali, allora come oggi, sono spesso intellettualmente fragili e soggetti al conformismo. Non solo i giornalisti e non solo in Italia. (Si veda, tra l’altro, il libro “Pellegrini politici-Intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba” di Paul Hollander, Società editrice il Mulino). Perché? Per quanto ne sappiamo noi, the answer is blowing in the wind.
 Infine, un’informazione per i lettori più giovani. L’eskimo era un giaccone, in genere di color verde, in cotone, con una parte interna di pelliccia sintetica. Non risultava di grande utilità, riparava poco dal freddo e dalla pioggia. Era diventato una divisa dei militanti della sinistra.
Infine, un’informazione per i lettori più giovani. L’eskimo era un giaccone, in genere di color verde, in cotone, con una parte interna di pelliccia sintetica. Non risultava di grande utilità, riparava poco dal freddo e dalla pioggia. Era diventato una divisa dei militanti della sinistra.