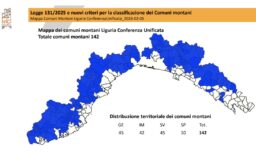L’aspetto peggiore della crisi, che è passata lasciando la Liguria più ristretta di quanto lo sia geograficamente, è l’aver abbassato le aspettative di tutti.
Parlare di attese di avanzamento di carriera oggi sembra un’assurdità. Perché i giovani cercano disperatamente un lavoro, qual che sia. E qual che sia il titolo di studio di cui dispongono. Identico il discorso per gli espulsi dal lavoro a cinquant’anni e senza aver commesso alcun fallo. Il calo della produttività è spesso dettato dal poco entusiasmo, soffocato dall’incertezza sul futuro.
Per quando sia statisticamente in aumento il tasso di fiducia, di certo non lo è quello di entusiasmo, ammesso che ci sia un indice che lo possa misurare.
Il ritratto del genovese oggi al lavoro è una via di mezzo tra l’ordinato (e bravissimo) travet di fine 800 e il manager depotenziato all’americana al quale i vertici della società si rivolgono con terminologie anglo-marziane perché da loro ci si aspetta ogni giorno l’applicazione di metodologie astruse, spesso incomprensibili, che rappresentano nuove visioni aziendali per un futuro che verrà. Ma tenendo ben presente che il fatturato deve arrivare subito, altrimenti sono guai.
Guardare il residuo di quella che fu la “classe media” della Superba aiuta a comprendere il perché la città e la regione fanno fatica a ripartire. E perché se in questo territorio un giovane vuole lavorare deve innanzitutto imparare a pensare da vecchio.
La foto è nitida. I lavoratori liguri a cavallo del mezzo secolo (dirlo fa sempre effetto) sono quasi la metà degli occupati genovesi. Quasi l’ 80% di loro gode ancora di contratti a tempo indeterminato. Quei tipi di assunzione che una volta usavano indiscutibilmente per tutti e che ora sono appannaggio, in città, di un giovane lavoratore su tre. Visto il numero, gli occupati di mezza età rappresentano il cervello, la spina dorsale, quand’ancora gli (stanchi) muscoli dell’ economia cittadina. Chi di loro doveva far carriera l’ ha fatta, gli altri sudano – senza aspettative – lo stipendio.
Solo fino a quindici anni fa il cinquantenne (che allora era in massima parte occupato nell’industria o nel pubblico) era in attesa della pensione. A pochissimi anni dal vitalizio dell’Inps, spesso e volentieri ulteriormente avvicinato da prepensionamenti a pioggia. Aveva i figli sistemati o quasi e andava al lavoro già pregustando la libertà fatta di bici, bocce e canna da pesca.
Oggi il genovese di mezz’età ha una vita e delle attese enormemente diverse. Innanzitutto la riforma pensionistica ha spostato a 63 (e oltre) l’ età del riposo, e quindi questo lavoratore ha ancora davanti una decina buona di anni di lavoro. Senza speranza di scivoli. Non lavora più – se non in modesta percentuale – nelle fabbriche, ma è occupato nei servizi, che rappresentano, nella più ampia accezione, circa l’ 80% della produttività di fatturato ligure. Ha i figli ancora in età scolare, visto che in questi ultimi tre lustri l’ età media del diventare genitori si è spostata di circa 8 anni in avanti e, fatte le debite eccezioni, si diventa mamma e papà ben oltre i 30 anni. È gravato da debiti (vedi mutui e prestiti) che nel 1990 avevano un carico medio sulle famiglie inferiore al 60% rispetto ad oggi. Sotto quei capelli spesso bianchi (minimo sale e pepe) le preoccupazioni sono almeno il doppio dei fortunati pari età di inizio ultimo decennio del secolo scorso. E l’ aspetto sociale è complicato da altre e più complesse situazioni occupazionali.
Oggi queste persone mature rappresentano, nell’economia della globalizzazione, un bel peso. Sono esperte, espertissime. Conoscono ormai a menadito le procedure produttive delle proprie aziende. Sanno cavarsi d’ impiccio da situazioni complesse. Dovrebbero dunque essere considerate delle risorse importanti. Invece no. Nella struttura di bilancio, dalla grande alla piccola impresa, rappresentano, e vengono considerate, un costo elevato e incomprimibile. Tra l’ altro difficilmente cancellabile, in quanto sono tutelate da contratti che non ne prevedono il licenziamento se non per ragioni assolutamente specificate dalla legge.
La politica del risparmio sempre e comunque a partire dall’occupazione li rende invisi, in particolare ai colleghi più giovani che lavorano al loro fianco e che hanno contratti atipici, e dove un giovane su tre sa esattamente quando gli scade il contratto.
Mai come oggi questa città, la più anglosassone d’ Italia dal punto di vista delle reazioni al cambiamento, è stata obbligata a dover decidere sul proprio domani. E come spesso è accaduto in passato, da qui potrebbe nascere un nuovo modello utile per l’ Italia post crisi.
Per capire lo stato morale, economico e finanziario delle famiglie genovesi è utile leggere (e interpretare per valutare in chiave locale) quanto dichiarato qualche tempo fa da Andrea Brandolini, del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria di Bankitalia, in commissione lavoro e previdenza sociale del Senato. Dal ’93 a oggi autonomi, dirigenti e pensionati hanno visto salire i propri redditi, mentre operai e impiegati sono andati a rimpinguare il numero dei poveri.
Le percentuali medie, che per Genova valgono assai, dicono che soprattutto dal 1993 al 2006 e poi, fino a oggi, il reddito disponibile equivalente (espresso in termini reali con il deflatore dei consumi delle famiglie) è cresciuto in Italia mediamente dell’1,2%. La media è quella dei polli pro capite. Vediamo come si compone. L’ aumento medio di disponibilità per i lavoratori autonomi è cresciuto del 2,6%; per i dirigenti (pubblici e privati) dell’ 1,5%; per i pensionati dell’ 1,6%. Molto più contenuti quelli per gli operai (+0,6%) mentre la classe media , quella che comprende(va) i quadri intermedi, gli impiegati direttivi e gli insegnanti ha potuto far conto solo su un incremento dello 0,3%.
Questa condizione di appiattimento ha portato a dati assolutamente sorprendenti sulle dinamiche distributive del reddito familiare. La quota di famiglie sui limiti della povertà è aumentata dal 27% al 31% tra coloro che appartengono al coacervo degli operai e dal 7% all’ 8% tra quelle con n reddito impiegatizio (ivi comprendendo anche quadri intermedi o, per esempio, insegnanti di ogni livello). Per converso si legge, e anche questo sorprende, che i nuclei familiari che poggiano sulla pensione e che vivono ai limiti dell’ indigenza siano diminuiti dal 24% al 21%, mentre le famiglie dei lavoratori autonomi che danzano sul baratro della povertà sono diminuite dal 25% al 14%.
Lavoro fisso è bello? Parrebbe, economicamente, non più. Lo dicono i numeri. Anche perché l’insicurezza del momento pone un altro e spesso più assillante problema. Quello di come e per quanto tempo le famiglie possono affrontare, finanziariamente, un periodo di difficoltà. Le risposte sono desolanti. Quasi 40 italiani su cento possiedono attività liquide sufficienti a sostentarli, da sole, a livello della soglia di povertà per un periodo non superiore a tre mesi. Il 16% non dispone neanche di queste riserve e in più ha un reddito basso.
L’aver sbriciolato – per risparmio aziendale o aumento della pressione fiscale – la classe intermedia ha reso anche la nostra città più povera ed economicamente insicura. Oltreché politicamente illeggibile.